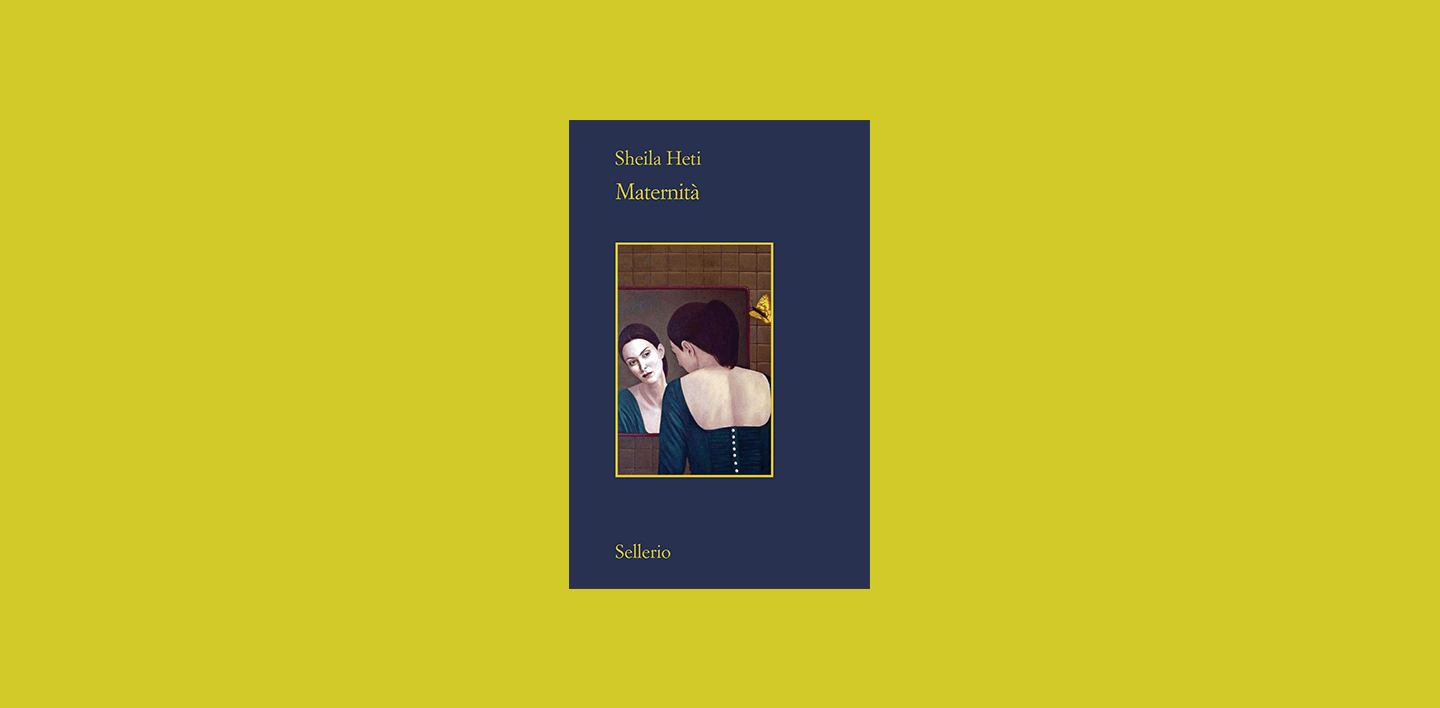
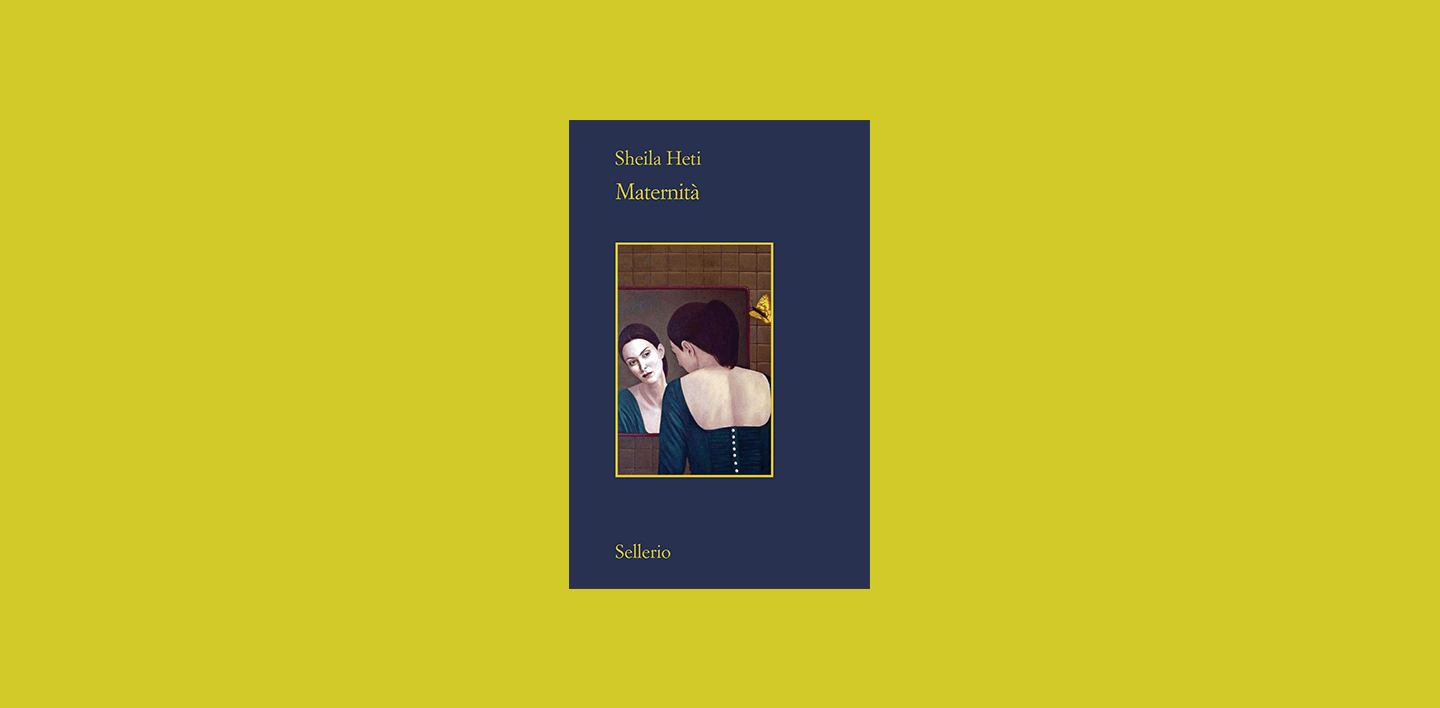
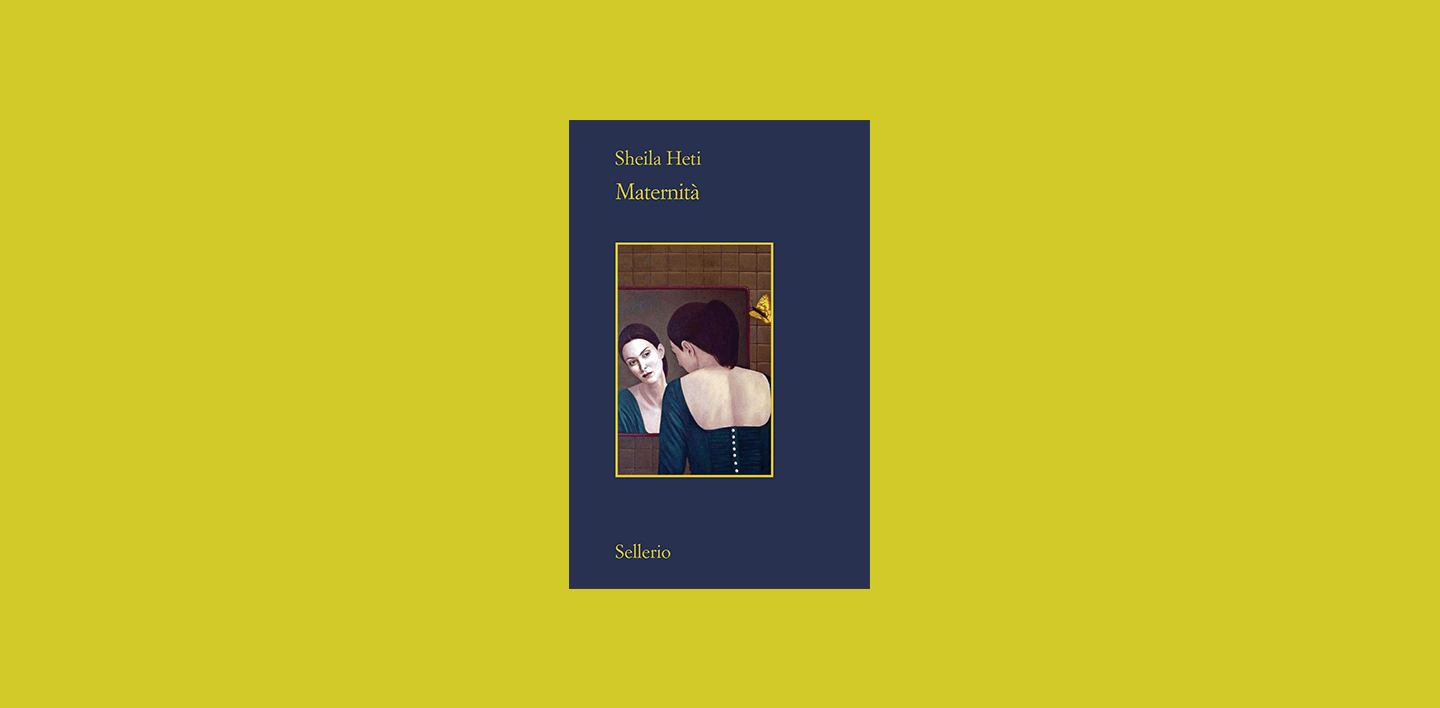
D ue o tre volte testa significa sì, due o tre volte croce significa no.
Lanciare tre monete è una tecnica usata da chi consulta l’
I Ching, un sistema di divinazione che ha avuto le sue origini in Cina più di tremila anni fa. I re lo usavano in tempo di guerra e la gente comune per risolvere i problemi della vita.
Il nuovo libro di Sheila Heti nasce da una domanda: avere o non avere un figlio? A chiederselo è la protagonista di Maternità, una donna che, a trentasette anni, sente che è il momento di prendere una decisione, prima che sia il suo corpo a prenderla per lei. Il compagno è d’accordo, “possiamo anche farlo, ha detto, però devi essere sicura”, così lei, per svelare “il più grande segreto che nascondo a me stessa”, come chiama la sua posizione nei confronti della maternità, si affida alle monetine, che con i loro sì e i loro no dovrebbero essere utili a indagare i suoi dubbi. Invece di applicare questo metodo divinatorio solo alla madre di tutte le domande, decide di utilizzarlo per interrogare ogni aspetto della sua vita: “questo libro è una buona idea?”, si chiede, “è ora il momento di cominciarlo? Farà bene alla mia anima? Sto facendo tutto giusto?” E le monetine emettono la loro sentenza: sì, sì, sì, no.
Confucio, uno dei più importanti interpreti dell’I Ching, disse che se avesse avuto cinquant’anni in più da vivere, li avrebbe dedicati allo studio del libro. Il testo originale dell’I Ching è poetico, denso, molto filosofico, cosmologico nella sua ampiezza e notoriamente sibillino. Nelle pagine che seguono vengono usate tre monete: tecnica ispirata all’I Ching, ma non corrispondente al vero I Ching, che è qualcosa di diverso.
Canadese dalle origini ungheresi, Sheila Heti è uno dei nomi più noti della grande ondata di autofiction di questi anni: come quelli di Ben Lerner, Heidi Julavits e Rachel Cusk, per citarne alcuni, i suoi libri nascono all’intersezione tra la vita e la scrittura. Nel suo romanzo più famoso, La persona ideale, come dovrebbe essere?, la protagonista aveva il suo stesso nome e con lei compariva l’amica Margaux Williamson (un’artista visiva con cui Heti ha collaborato spesso): Heti lo aveva definito un romanzo tratto dalla vita (a novel from life).
Era una storia quasi vera, cioè, come quella che aveva interpretato per Leanne Shapton, posando per le fotografie di Importanti oggetti personali e memorabilia dalla collezione di Lenore Doolan e Harold Morris, splendido e falsissimo catalogo d’asta che raccontava una storia d’amore per oggetti, un lotto alla volta.
Aveva anche pubblicato il suo diario, trascrivendolo, però, per chiave alfabetica: se dovessi trovare un esempio capace di illustrare il metodo con cui Heti lavora, potrebbe essere questo – una versione riorganizzata di cose che possono o non possono essere successe.
Per molti aspetti, Maternità (tradotto da Martina Testa per Sellerio), non è che la naturale progressione di questo metodo: se la protagonista de La persona ideale non aveva ancora compiuto trent’anni e si interrogava su cosa accadeva a relazioni, amicizia e lavoro culturale al tempo della precarietà, questo, che esce sei anni dopo, contiene una meditazione su maternità e creatività.
Anche questa volta le coordinate biografiche della protagonista sembrano coincidenti con quelle di Heti: eppure, se per approssimazione si direbbe la sua storia, in realtà è praticamente impossibile cogliere un grammo di biografia da queste pagine. Una nota iniziale in Maternità assicura che tutte le risposte che si trovano all’interno del libro sono il risultato di effettivi lanci di monetine: forse sono questa l’unica cosa vera di questo libro.
Quella di Maternità è un’indagine sulle origini del desiderio di avere figli: la protagonista si chiede se per lei non sia forse la risposta a una generica pressione sociale, il desiderio di provare al mondo che il suo corpo funziona, che può avere tutto, un lavoro, i figli, la gloria. Così, attraverso continue oscillazioni di desiderio (“Come facciamo a sapere come andrà a finire per noi, trentasettenni indecise? Da un lato la gioia dell’avere figli. Dall’altro le tribolazioni dell’averne. Da un lato, la libertà di non averne. Dall’altro, il rimpianto di non averne mai avuti: ma in fondo cos’è che ci si perde?”) il romanzo inizia a mettere a fuoco quello che forse è il vero cuore della questione: non compiere un’azione corrisponde a vivere l’esperienza di quella assenza? Perché, altrimenti, definire le donne che decidono di non avere figli a partire da quel senza, dalla mancanza di qualcosa, invece di considerare la loro esperienza come equivalente? Non partecipare a “una storia più universale – il presunto ciclo della vita” deve essere per forza un atto di privazione, un egoismo?
Forse voglio dei figli perché desidero essere ammirata come il tipo di donna ammirevole che ha dei figli? Perché voglio essere vista come una donna normale, o perché voglio essere il miglior tipo di donna possibile, una donna non solo con un lavoro, ma con il desiderio e la capacità di allevare dei figli, un corpo in grado di fare bambini e con cui un’altra persona vuole fare bambini?
In un’intervista, la scrittrice Leila Slimani definiva la maternità come una condanna all’ergastolo, per quanto scandaloso possa sembrare: “dal momento in cui una donna rimane incinta”, rifletteva, “la donna che era prima muore per sempre”. Maternità è una riflessione alla soglia di questo bivio, che considera ognuna di queste due esperienze nella loro pienezza, con le loro rinunce, ma anche scelte e libertà: più semplicemente (e non c’è niente di semplice qui) le considera come concluse in se stesse.
Le ragioni per cui, nel discorso pubblico, la decisione da parte delle donne di non avere figli (perché non si vogliono, perché non si possono avere, perché ci sono desideri che non sono abbastanza forti da dover essere realizzati) è ancora poco accettata: da una parte questa resistenza riguarda il fatto di non poter considerare più la maternità come un atto capace di produrre senso di per sé, un atto risolutorio; dall’altra perché si oppone a una pressione collettiva, esercitata tanto da uomini quanto da donne, che vuole che le donne diventino madri, al di là delle loro inclinazioni personali. In un intervento sul suo ultimo libro Bambini, l’antropologo Matteo Meschiari sottolineava come i figli fossero continuamente presenti nel discorso politico, ma solo in qualità di oggetto, mai di soggetto: è facile riconoscere come molte delle misure a favore della maternità non siano altro che strumenti di controllo della sessualità femminile. Perché non fare figli è osceno? Scrive Sheila Heti:
Le donne devono avere i bambini perché devono essere occupate. Quando penso a tutta la gente che nel mondo vuole vietare l’aborto, mi sembra che il senso possa essere uno solo: non è che vogliono una persona nuova al mondo, vogliono che le donne si occupino innanzitutto di tirare su i figli. C’è qualcosa di minaccioso in una donna che non è impegnata coi figli. Una donna del genere dà un senso di instabilità. Cos’altro si metterà a fare? Che razza di guai combinerà?
Heti però non limita la conversazione al piano politico – anche se come ogni scelta oggetto di pubblico scrutinio, che deve essere cioè accettata, ogni riflessione sul tema non potrà che essere politica –, ma rivolge il suo sguardo più in alto, al tema della nostra temporalità, alla possibilità di lasciare sul mondo una traccia di noi. In My life is a joke, un raccolto apparso sul New Yorker, immaginava di essere morta, investita da un’auto: “quando sono morta, non c’era nessuno intorno a vederlo. Sono morta completamente sola. Va bene così”. Raccontando di non aver sposato il fidanzato del liceo, da sempre ossessionato dal bisogno di avere qualcuno che potesse far da testimone per la propria esistenza, realizzava che lei, senza marito e senza figli, non avrebbe avuto nessuno a tramandare la sua storia. Quando, in Maternità, un’amica della protagonista le consiglia di fare un figlio col compagno, “come se fosse un modo per tenersi più vicino un uomo”, si accorge allora di invidiare “le madri perché qualunque cosa succeda hanno sempre questa persona, una cosa tutta loro”: ma i figli non sono una nostra proprietà, per quanto lo desideriamo, restano qualcosa di separato da noi. A lasciare un segno di sé nel mondo saranno i suoi libri, dopotutto.
A rendere Maternità un libro infinitamente più interessante di tanti altri che affrontano lo stesso tema, è che sembra davvero interrogarsi sull’argomento, senza riuscire a dare una risposta univoca: in questa incertezza, che assomiglia al tempo che fluttua e che domina il libro, troviamo qualche frammento di senso. Potremmo definirlo una ruminazione incessante sull’argomento, senza che quella parola abbia connotazioni negative: è una ruminazione perché non si sviluppa in forma lineare, ma in forma circolare, torna ripetutamente al punto di partenza, dismette argomentazioni e poi le recupera. È un romanzo filosofico, in cui i meccanismi di finzionalità sono camuffati da un apparente autobiografismo: Maternità, però, non è la rappresentazione di una vita, è uno spazio letterario in cui tutto quello che avviene è simbolico e, quindi, analizzabile. Le monete, l’uso che fa dei tarocchi, dei sogni: sono tutti segni che la storia che stiamo leggendo è metaforica, per così dire.
A tratti questo libro ricorda la prima prova di Heti, The Middle Stories, una raccolta di racconti archetipici, di fiabe; in mezzo, però, c’è stata l’autofiction, il romanzo tratto dalla vita. Se La persona ideale elevava il personale a universale, questo è un romanzo che inventa una persona reale per parlare di universali. Fiction, in una parola.
Senza tenere in considerazione questa filiazione, è difficile capire da dove arrivi la scrittura sapienziale di Maternità, un’evoluzione stilistica che del resto non è solo di Sheila Heti.
Una scrittura che ha una ascendenza religiosa: se Sarah Manguso distilla tutta la sua saggezza in frasi minime, quasi che potessimo consultare la sua letteratura come consultiamo le Sacre Scritture o i libri delle risposte, Sheila Heti abbraccia la preghiera buddista o la meditazione ortodossa, in una ripetizione infinita della stessa frase o della stessa domanda.
Franny Glass ripeteva “Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, peccatore”, così Heti si chiede dovrei avere un figlio?: è dalla ripetizione stessa della domanda, che si produce la conoscenza, anche se poi non è chiaro se si arrivi a una risposta. In un film girato dalla sua amica Margaux Williamson, Sheila Heti interpretava l’Amleto: anche qui la domanda è essere o non essere (madre)?
E non è neanche un’ascendenza nascosta: la sua indagine sulla maternità è esplicitamente paragonata alla lotta di Giacobbe con l’Angelo. “Giacobbe rimase solo”, racconta, “e una creatura lottò con lui fino allo spuntare dell’alba […] Poi la creatura disse: Lasciami andare perché è spuntata l’alba. Giacobbe rispose: Non ti lascerò, se prima non mi benedici”. L’episodio, contenuto nella Genesi, si conclude con Giacobbe che battezza il luogo della lotta Penuel, “perché è dove ho visto Dio faccia a faccia, eppure ho avuto salva la vita”; Heti chiama questo luogo maternità.
Alle monete chiede: Il punto non è rafforzarsi nella lotta, o vincere, ma superare la prova?
E loro rispondono: sì
Quando Annie Ernaux dice di preferire il noi o la terza persona per parlare di sé è perché, quando pensa alla sua vita, dall’infanzia ad adesso, non riesce a separarla dal mondo in cui ha vissuto, è perché è insieme la sua storia e quella della sua generazione e degli eventi che sono capitati a tutti loro. Forse, è proprio questa ascendenza religiosa (senza religione) la cosa più vicina a un noi collettivo a cui Heti potesse ricorrere, in assenza di una storia collettiva in cui poterci riconoscere. Forse è questo il respiro sapienziale che riesce qui a creare spazio per dialogo, spazio per meditare una scelta senza l’ansia della rivendicazione.
Fino al 2016, Sheila Heti e Margaux Williamson hanno tenuto insieme un profilo Instagram in cui postavano foto sgranate di momenti qualunque, di loro, della strada: si chiamava Stunningkunst ed era, come suggerisce il nome, un progetto artistico. Le fotografie erano fotografie qualunque perché seguivano un modello estetico preciso: erano senza filtro, non editate come doveva sembrarlo la scrittura de La persona ideale, come dovrebbe essere?, come erano sciatte le luci di Girls. In un’intervista per la Paris Review, Sheila Heti dice di Maternità che voleva fosse semplice, che avesse lo stesso tono di una conversazione: doveva attirare i lettori, non respingerli. Il miele, per così dire, è una scrittura lirica, che assume questa ascendenza religiosa come modello letterario: è una tecnica narrativa, dopotutto, che sembra mostrare come certa autofiction si stia reinventando per superare i propri limiti. Tra gli altri, Ben Lerner, dopo Il mondo a venire, sembra aver trasformato il ricordo della sua adolescenza a Topeka nel suo numero migliore: il prossimo romanzo è ambientato qui e sarà interessante vedere cosa di vero c’è in questa previsione.
Questo libro farà bene alla mia anima? si chiede all’inizio di Maternità e la risposta è: sì, e non solo alla sua, ma a quella di chiunque vorrà leggerlo. In Maternità la scrittura lirica non diventa mai sentimentale o ricattatoria, anche quando l’argomento lo consente: è un equilibrio di temperatura emotiva e di pensiero. E questo accade nonostante il racconto della madre e della nonna – le altre vere protagoniste di questo romanzo – delle loro vite, come insieme di tragedie, tristezze e successi: nonostante e attraverso, perché qui non si usa la storia di chi è venuto prima solo per giustificare quello che accade dopo. Heti non usa cioè i sentimenti come fine, come epifania, ma come uno strumento di indagine. Trasforma la loro storia e, quindi, la sua in una riflessione sulla maternità come spazio di confronto, animato da madri e figlie, si interroga su cosa sia in realtà questa discendenza materna, su cosa venga tramandato. È il migliore dei tributi, un esercizio di onestà e di rispetto:
Se vendo questo libro, in cambio ne riceverò dell’oro. È una sorta di mutazione alchemica.I filosofi volevano trasformare la materia oscura in oro, io voglio trasformare la tristezza di mia madre in oro. Quando l’oro arriverà, andrò alla porta di mia madre e glielo consegnerò dicendo: Ecco la tua tristezza, trasformata in oro.