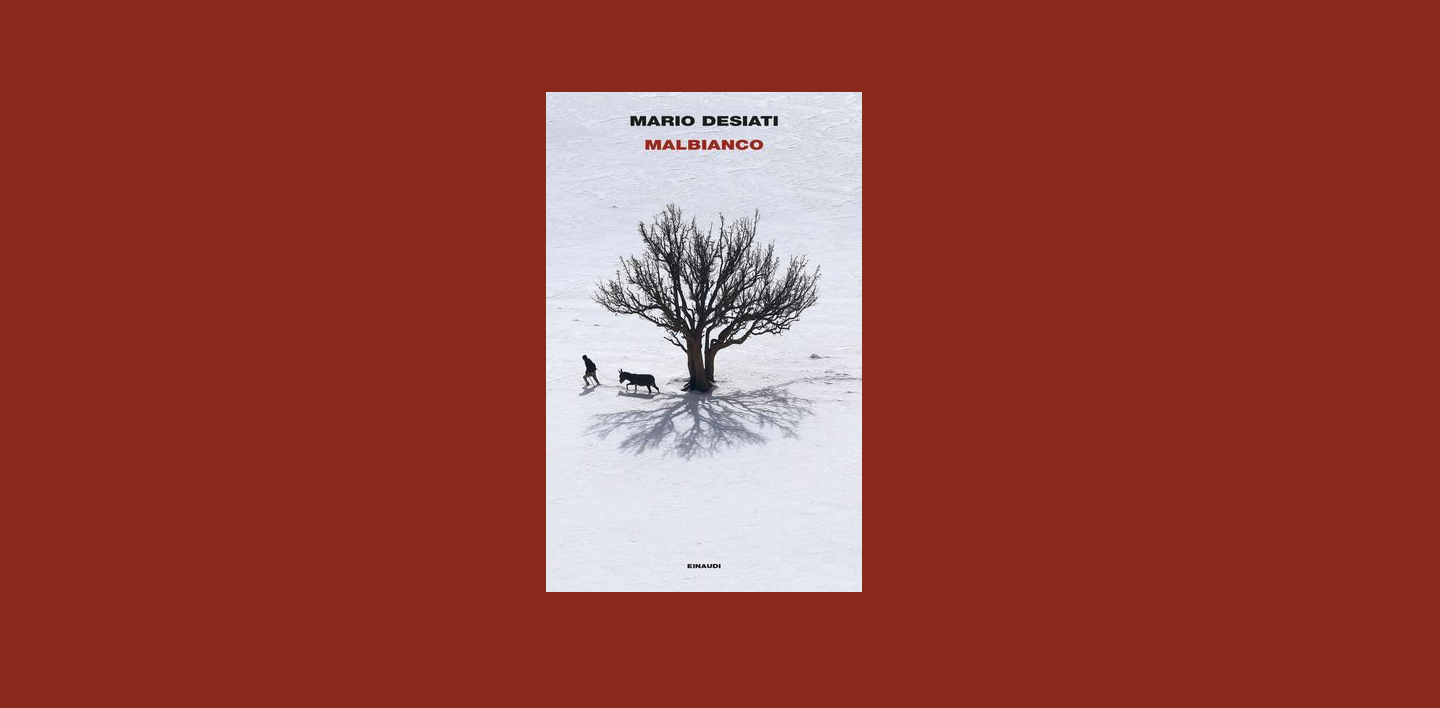
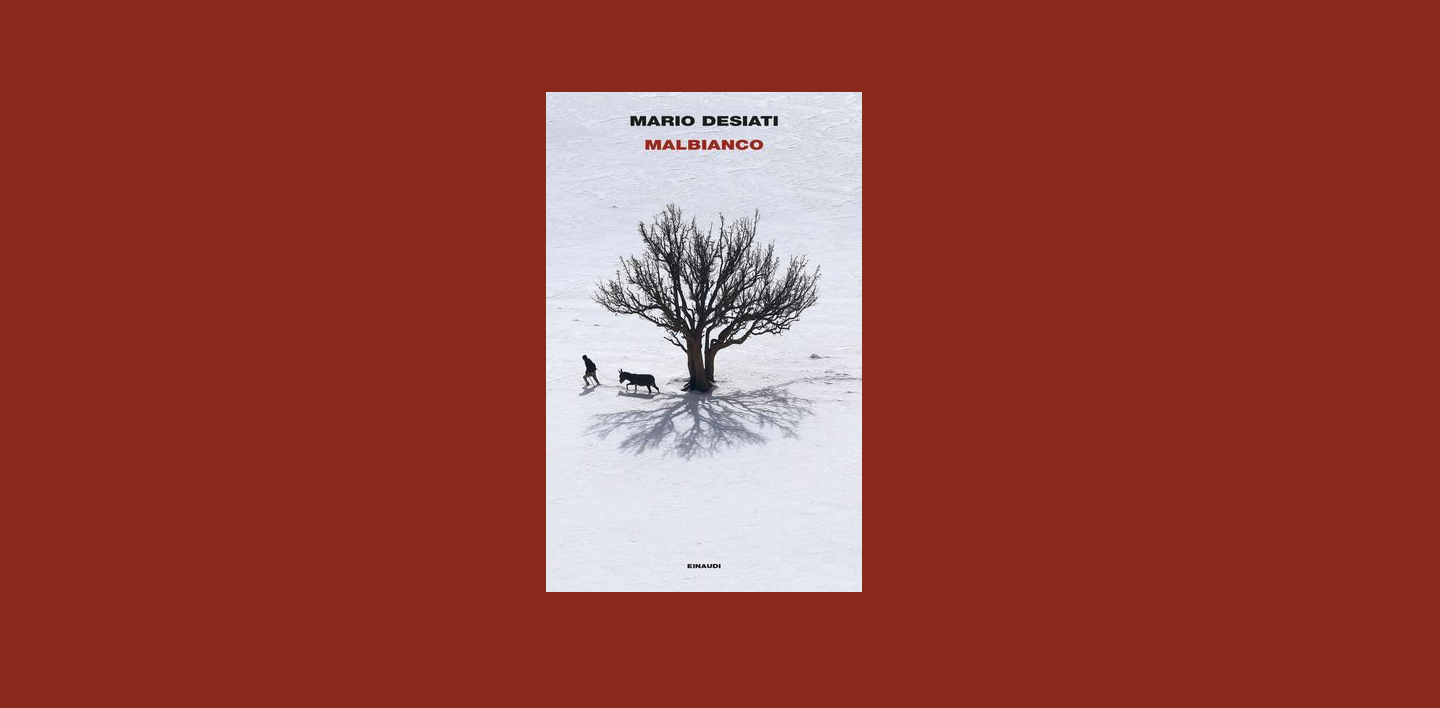
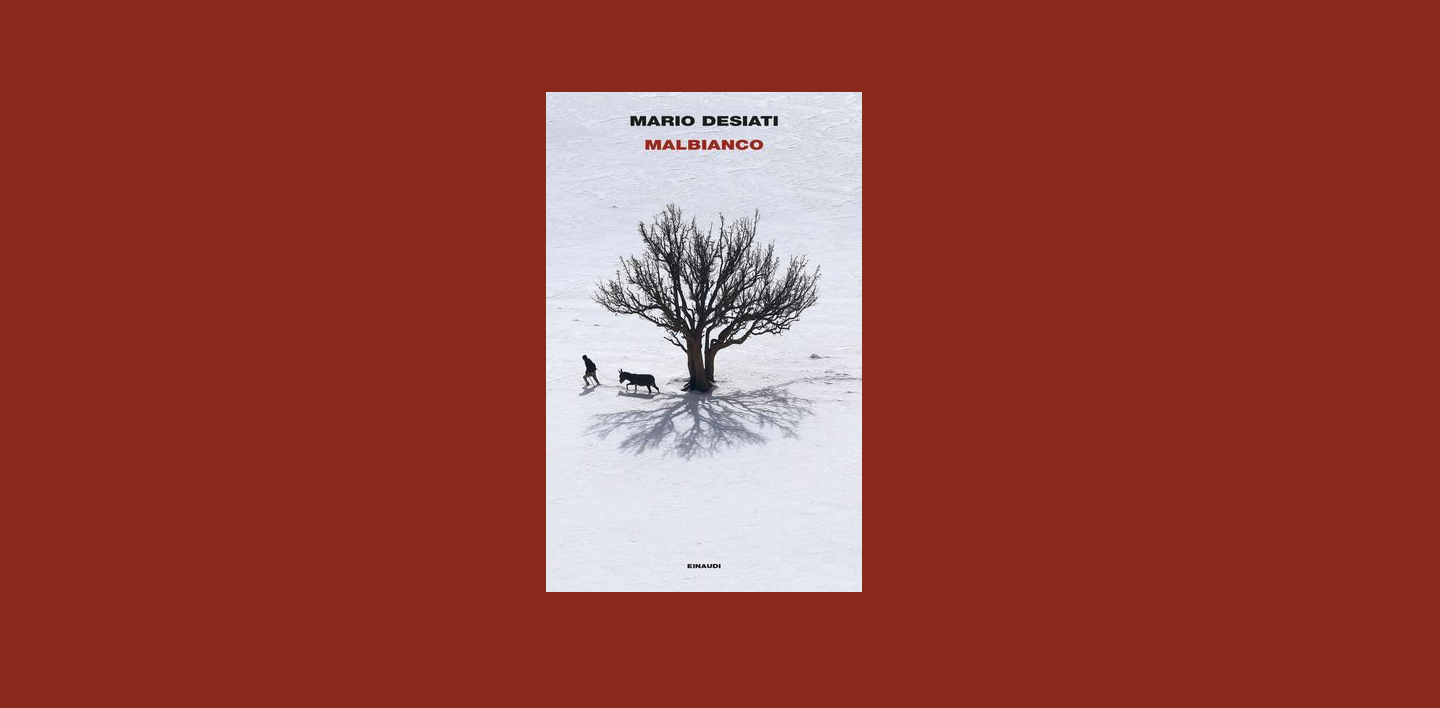
D alla città più cool d’Europa alla provincia più estrema d’Italia, da Berlino a Taranto il percorso di Marco Petrovici, protagonista dell’ultimo romanzo di Mario Desiati, Malbianco (2025), si potrebbe sintetizzare come un ritorno a casa, una fuga dalla contemporaneità berlinese per riappropriarsi prima di sé stesso e poi di quella storia familiare, in parte sottaciuta in parte nascosta, che attende ancora di essere pienamente scoperta e compresa da lui.
Un ritorno che però ha le inevitabili tinte di un fallimento, quello del ragazzo di provincia destinato a un futuro brillante in Europa che ora ritorna al suo paese, anzi per la precisione alla casa nel bosco nei dintorni di Taranto. Uscire dal centro per ritornare a casa, un movimento che sembra contenere il disagio e la sfortuna della stragrande maggioranza di chi si pensava cervello all’estero e si ritrova invece all’interno di una categoria così poco pregiata come quella del migrante, di colui che cerca fortuna e spesso dimentica sé stesso. Ma se in parte la storia potrebbe essere letta inizialmente in questo modo, pur non rigettando le basi di un discorso che è anche politico, Mario Desiati riporta fortemente in Malbianco il segno tipico del suo discorso letterario a partire dal suo secondo lavoro Vita precaria e amore eterno (2006).
Pur parte infatti di un discorso oggi comune e diffuso, in cui la drammatica perdita di senso è dettata anche da condizioni sociali ed economiche sempre più ostili, che riportano a impressioni di sconfitta e fallimento, tornare al paese e riprendere la via di casa è invece ormai più che in ogni precedente momento storico una questione di coraggio e di consapevolezza e non di resa. Una condizione che porta Marco Petrovici a muoversi da una necessità la cui urgenza ha la forma di una patologia al momento inspiegabile. Una serie di svenimenti che costellano le sue giornate berlinesi, tra angoscia e stanchezza estrema. Forse una scusa, di certo una buona scusa, quella di avere bisogno anche abbastanza rapidamente di una serie di visite mediche che constatino il suo reale stato di salute. Un modo dunque obbligato per tornare a casa, là dove i genitori portano avanti un tran tran quotidiano almeno superficialmente sereno.
Uscire dal centro per ritornare a casa, un movimento che sembra contenere il disagio e la sfortuna della stragrande maggioranza di chi si pensava cervello all’estero e si ritrova invece all’interno di una categoria così poco pregiata come quella del migrante.
Malbianco è un romanzo sulle origini, sui luoghi dell’infanzia, ma anche sulla loro ostinata presenza nella memoria, che deriva nella sua forma instabile e facilmente modificabile, da anni e secoli precedenti. Una memoria portata a spalla da predecessori che ora acquistano agli occhi di Petrovici una diversa misura e una nuova natura. Marco Petrovici esplora un inedito stare tra uomini e donne del passato tentando di cogliere le caratteristiche intime del loro medesimo passato, di quei luoghi fatti di rumori, odori e nomi che rimbalzano ancora nel suo presente, a partire da quel nome, Marco, che appartenne prima che a lui a suo zio. Un viaggio nel tempo frutto di uno scavo ostinato e di un’elaborazione che intreccia storia familiare e storia nazionale, il fascismo e la Resistenza, un’inquieta condizione di attesa che sfida la labilità del presente e le sue insensate urgenze che richiedono garanzie e sicurezze come stanche abitudini e non quali diritti conquistati a rischio della vita.
Petrovici vive come su una fune tesa tra due tempi che prima ancora che lontani l’uno dall’altro appaiono come opposti seppure conseguenti. Tempi che sembrano aver perso ogni possibilità di parola tra loro. Malbianco vive infatti di continui e a tratti strazianti silenzi necessari, costruiti con una raffinata architettura stilistica in cui l’attesa diviene lo spazio di una possibile riconciliazione. Il mondo che si palesa davanti a Petrovici acquista vita provenendo da una memoria e da una immaginazione che scalzano il reale presente mutandolo e ridefinendolo secondo canoni più affini alla propria sensibilità. Un sentimento di verità che guida Petrovici senza dargli requie alcuna.
Il protagonista vive come su una fune tesa tra due tempi che prima ancora che lontani l’uno dall’altro appaiono come opposti seppure conseguenti. Tempi che sembrano aver perso ogni possibilità di parola tra loro.
L’autore regala al lettore uno sguardo avventuroso e teso, che mischia bene gli stilemi di una ambientazione che riporta a Thomas Bernhard e alla sua cinica durezza, ma virata in un sud agreste e boscoso, così diverso dalla cartolina “tutta sole e spiagge”.
Malbianco è probabilmente il romanzo che meglio contiene e libera tutti quei temi che da sempre interessano e in alcuni casi ossessionano Mario Desiati. Un catalogo che al tempo stesso si rinnova invece di esaurirsi, dando corpo a una qualità poetica raffinata e al tempo stesso popolare, legata ai fatti della storia di una nazione e della vita di una famiglia che in quei confini ha dato corpo ai propri eventi e sentimenti. Il romanzo vive infatti di una forma di volutamente traballante ‒ quanto inquieta ‒ vivacità. Quasi una vera e propria pretesa e insistita volontà di dichiarata immaturità che permette al testo di superare le strette insegne che solitamente s’innalzano rispetto a un romanzo che ha sulla sua superficie tutti gli elementi di un genere facilmente qualificabile come familiare. Malbianco mette invece a disposizione dei suoi lettori uno scenario ben più ampio e al tempo stesso anche più godibile, dentro al quale la riscoperta delle origini diviene una forma di avventura, un’indagine che lascia stupiti e liberi di rispecchiarsi senza inutili imbarazzi.