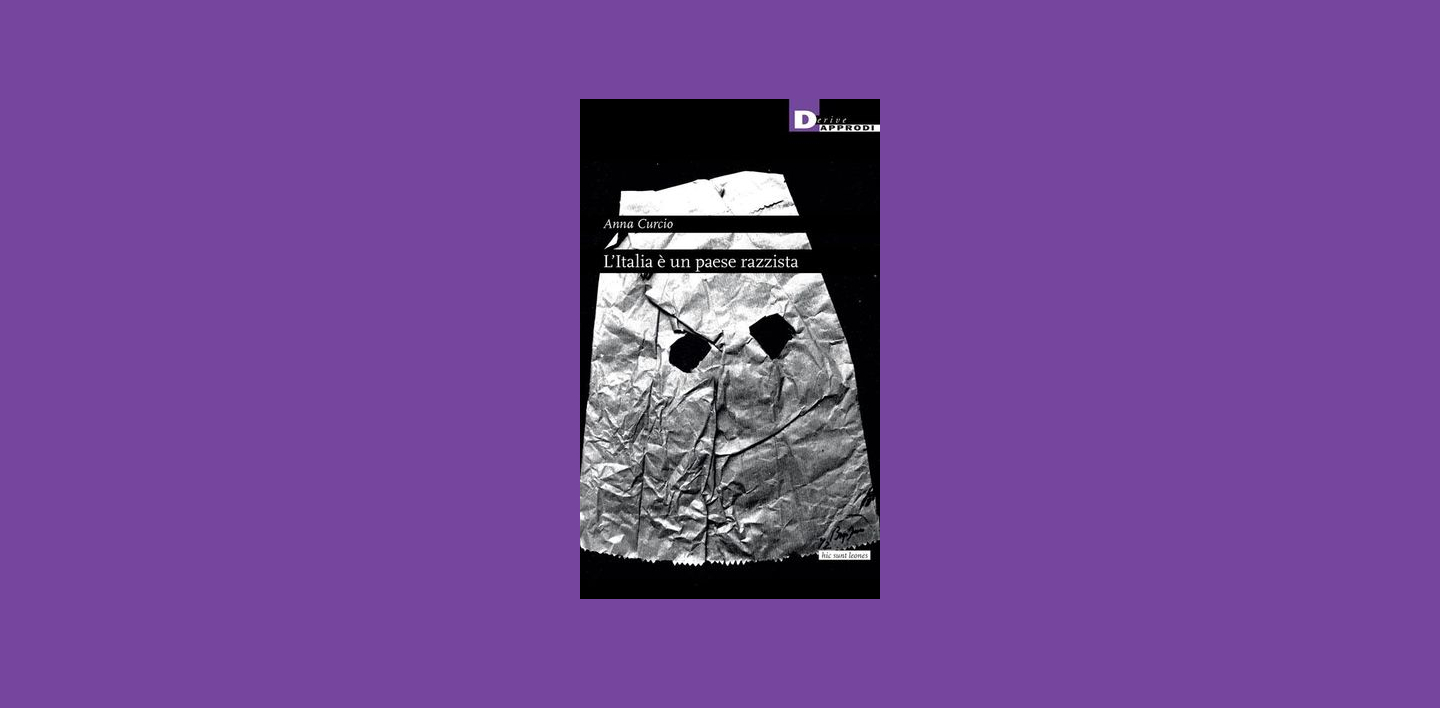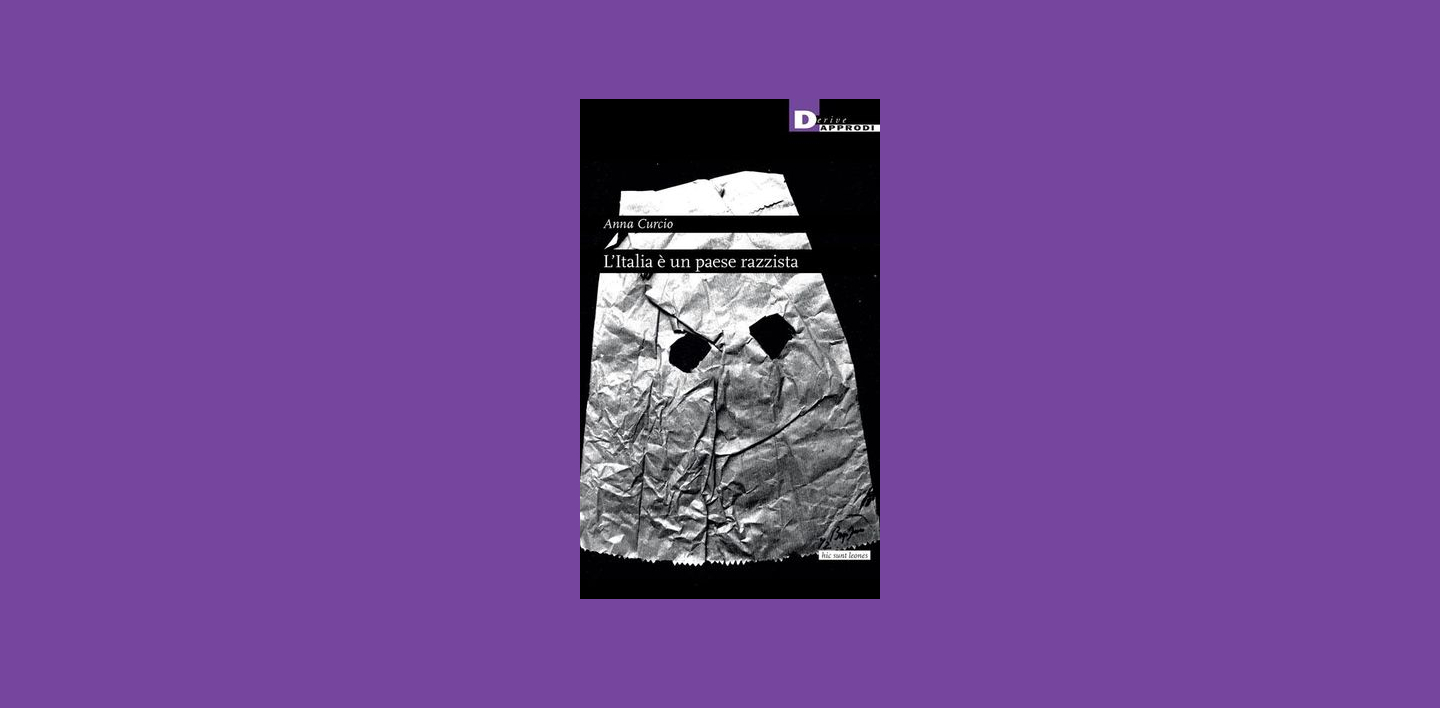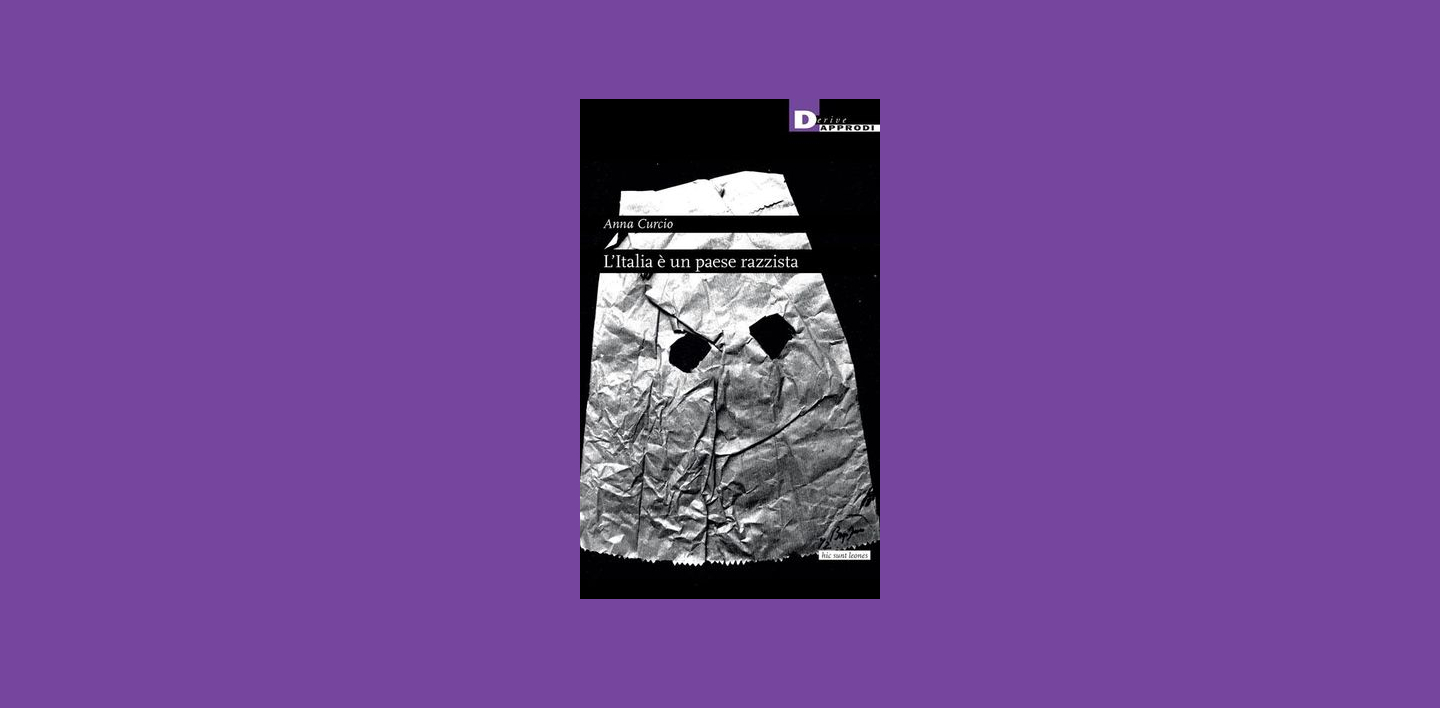P
ubblicato nel 2024 da Derive Approdi, L’Italia è un paese razzista di Anna Curcio è un lavoro importante per il dibattito antirazzista contemporaneo in Italia. Il suo valore non risiede solo nella ricchezza delle analisi proposte, ma anche e soprattutto nel suo essere una sintesi articolata di un percorso decennale che l’autrice ha dedicato all’indagine del fenomeno della razzializzazione e delle sue molteplici implicazioni. Curcio, infatti, riesce a intrecciare con grande efficacia prospettive storiche, teoriche e politiche, delineando un quadro esaustivo del razzismo italiano nella sua dimensione strutturale e sistemica.
Attraverso una raccolta di saggi, il volume affronta il razzismo non tanto in quanto forma di discriminazione, quanto come dispositivo atto a organizzare la società, modellando leggi, media, e politiche pubbliche, relazioni interpersonali e gerarchie sociali. Questo è già evidente dal (provocatorio) titolo del libro. Dire che “L’Italia è un paese razzista” mette a nudo una realtà ancora spesso negata, in un contesto nazionale in cui gli aspetti sistemici del razzismo non sono né riconosciuti né affrontati. Come osserva l’autrice: “Si tratta di rendere esplicito che il razzismo non è frutto di ignoranza o di odio, né un malessere psicologico, come gran parte dell’antirazzismo di sinistra continua a pensare, ma vive nelle leggi, negli spazi del quotidiano: casa, scuola, lavoro, luoghi del consumo ecc.”.
Curcio ‒ anche grazie alla sua esperienza di studio negli Stati Uniti, dove questi temi sono affrontati apertamente ‒ propone una lettura del razzismo che si avvale della Critical race theory, sottolineando come la razza, nel suo essere una costruzione sociale e culturale, rappresenta un dispositivo politico che, da un lato, funziona come strumento di oppressione e, dall’altro, diviene un possibile spazio di trasformazione, capace di sovvertire gli attuali rapporti di potere. Per l’autrice, infatti, nel
rapporto tra razzismo e capitalismo è […] possibile leggere le dinamiche che interessano, nella transizione storica, le nostre società: i processi di razzializzazione e le gerarchie della razza che il capitalismo organizza, ma anche le lotte dell’antirazzismo politico e la tradizione del pensiero radicale nero.
L’Italia è un paese razzista è suddiviso in tre sezioni tematiche, che testimoniano “di un dibattito che ha aperto o che sta aprendo a una nuova comprensione del razzismo e della lotta antirazzista, (e che) pone nuove domande da sviluppare insieme”. La prima sezione sviluppa le coordinate teoriche per comprendere il razzismo come fenomeno storico e politico. Qui la studiosa analizza la nascita del concetto di razza come invenzione funzionale all’organizzazione capitalistica della società. La razza, secondo Curcio, non è una semplice categoria descrittiva, ma una costruzione sociale che ha avuto e continua ad avere un peso specifico nella vita delle persone: “Una costruzione […] reale, nel senso che ha un peso materiale nell’esperienza di vita dei soggetti. Lo sanno bene, oggi, i migranti internazionali e nel corso della storia, le popolazioni colonizzate e poi diasporiche, i meridionali in Italia e, certamente, non da ultimi gli uomini e le donne della tratta Atlantica.”
In questa prima sezione l’autrice offre una genealogia del razzismo in Italia, mettendo in luce come esso si sia manifestato lungo due assi principali. Da una parte un razzismo interno, rivolto soprattutto alle persone meridionali, sostenuto dalle argomentazioni pseudoscientifiche dell’antropologia positivista lombrosiana e dal paradigma delle “due Italie” proposto dall’allievo di
Lombroso Alfredo Niceforo: “Un’Italia del Nord popolata da ariani di discendenza germanica, ‘più facili alla disciplina’ e una del Sud abitata da una popolazione latino-caucasica con influenza negroide ‘ribelli, indisciplinati e ineducabili’”.
D’altro canto, un razzismo esterno, spinto da un “desiderio di espansione coloniale” di natura intrinsecamente capitalista, legittimato da una “missione civilizzatrice dell’Europa in Africa”, e mosso anche dalla necessità di sbiancare una nazione costellata di punti marroni al suo interno.
Curcio affronta il razzismo non tanto in quanto forma di discriminazione, quanto come dispositivo atto ad organizzare la società, modellando leggi, media, e politiche pubbliche, relazioni interpersonali e gerarchie sociali.
A cavallo tra il Diciannovesimo e il Ventesimo secolo prende corpo l’impresa coloniale italiana, e con essa si diffonde l’idea di una fondamentale inferiorità delle popolazioni indigene, destinate a essere conquistate e sottomesse. Nei loro confronti il principio dell’uguaglianza tra le nazioni soccombe a favore di una superiorità razziale ‒ o, come vuole il linguaggio dell’epoca, di una superiorità di stirpe. Questo principio continuò a essere centrale nelle politiche coloniali italiane fino alla fine del fascismo. L’autrice ci ricorda che
a dispetto della narrazione di ‘Italiani brava gente’ oggi sappiamo che il massacro di Addis Abeba nel 1937, i gas asfissianti e la guerra batteriologica in Etiopia, fino all’istituzione dei campi di concentramento in Cirenaica per spezzare la resistenza guidata da Omar al-Mukhtar in Libia, sono solo alcuni dei crimini efferati compiuti per stabilire l’ordine razziale in Africa.
Partendo dall’unificazione nazionale, passando attraverso il colonialismo e l’Italia “dei provvedimenti per la difesa della razza italiana”, Curcio analizza il modo in cui la questione della razza è stata espunta dal discorso politico dell’Italia post-bellica, relegata a un problema ideologico legato al nazifascismo, e rimossa attraverso l’enfasi sui diritti universali dell’uomo.
Gli ultimi saggi della sezione intrecciano i concetti di classe, razza e genere, criticando le politiche multiculturaliste che hanno caratterizzato il discorso che si voleva antirazzista nei primi anni Duemila, e con esse il mito dell’ipotesi “post-razziale”, secondo la quale il razzismo non sarebbe più un fenomeno dirimente nella società contemporanea. Contro questa retorica, Curcio si sofferma a raccontare e analizzare opere artistiche contemporanee “orientate a svelare il mondo invisibile delle violenze e dello sfruttamento razzista e sessista malcelato dietro la retorica multiculturalista della proliferazione delle differenze, oggi dominante.”
La questione della razza è stata espunta dal discorso politico dell’Italia post-bellica, relegata a un problema ideologico interno solo al nazifascismo, e rimossa attraverso l’enfasi sui diritti universali dell’uomo.
Nella seconda parte del volume l’autrice applica i concetti elaborati nella sezione precedente a episodi concreti di razzismo, attraverso una serie di articoli pubblicati negli anni che vanno dal 2010 al 2020 circa. Qui l’autrice sposta l’attenzione “su casi di cronaca che seguono una scia di violenza, verbale e materiale”, che hanno aperto il dibattito pubblico e politico sul tema. A partire dagli omicidi razziali di Samb Modou e Diop Mor, avvenuti a Firenze nel 2011 per opera di un militante di Casa Pound, passando per la mancata riforma della legge sulla cittadinanza, fino al divieto (disatteso) di attraccare nel porto di Lampedusa posto alla comandante della Sea Watch-3 Carola Rackete, Curcio analizza il modo in cui la stampa, i media e la politica riproducono una struttura razziale nella società mentre ne negano l’esistenza stessa.
La terza sezione si concentra sul rapporto tra razzismo e lavoro, analizzando i processi di razzializzazione all’interno dei rapporti sociali di produzione e riproduzione, intesi come lavoro di cura e di riproduzione sociale. Curcio, dopo aver raccontato la storia di Altagracia, giovane donna dominicana resa subalterna nel mercato del lavoro e attraverso le leggi sull’immigrazione, dedica particolare attenzione al settore della logistica, descrivendo come i magazzini di Bologna e Piacenza siano stati il teatro di lotte sindacali che hanno sfidato le gerarchie razziali imposte dal sistema capitalistico. In questo contesto, l’autrice sottolinea il ruolo delle lotte collettive come strumento per superare le divisioni di classe e razza:
Oltre le politiche sull’accoglienza e le retoriche posticce sull’integrazione e al di là delle azioni di solidarietà antirazzista e dei percorsi educativi per disimparare il razzismo […] le lotte nei magazzini della logistica hanno costruito una straordinaria composizione politica nell’articolazione di classe e razza capace di superare le tradizionali gerarchie del capitale.
Tale composizione è “un accenno di quell’alleanza tra soggetti razzializzati e non, comunque declassati o proletarizzati” evocata da Houria Bouteldja in Beaufs et barbares. Le pari du nous (trad.it.
Maranza di tutto il mondo, unitevi! Per un’alleanza dei barbari nelle periferie, 2024) e che per Curcio rappresenta “l’orizzonte irrinunciabile della lotta antirazzista”.
L’autrice sottolinea il ruolo delle lotte collettive come strumento per superare le divisioni di classe e razza.
L’impegno dell’autrice nello studio del fenomeno, anche attraverso la partecipazione diretta nei momenti di lotta sindacale, si riflette nella sua capacità di collegare passato e presente, dimostrando come il razzismo sia un sistema capillare e pervasivo, mai relegato a episodi isolati. Un sistema che trova radici profonde e ben radicate, in un Paese che non ha mai fatto realmente i conti con il proprio passato coloniale e addirittura sembra stupirsi se la recente pubblicazione del rapporto ECRI, la commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza istituita dal Consiglio d’Europa, solleva preoccupata la questione della profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine italiane. Un sistema di differenziazione che in uno stato di diritto ha sempre trovato legittimazione nella norma.
Curcio ricostruisce nel suo libro il filo conduttore che lega le leggi coloniali alle leggi razziali fasciste, passando per la legislazione sull’urbanesimo fino ad arrivare agli attuali dispositivi securitari, che impongono un trattamento speciale, ovvero discriminante, alle persone migranti. In questo contesto diventa consentita la privazione della libertà personale e la detenzione presso i centri per il rimpatrio, nonostante le numerose inchieste sul tema continuino a denunciare i trattamenti inumani e degradanti che sono costrette a subire le persone lì trattenute. È consentito ostacolare l’accesso alla cittadinanza, e più in generale l’accesso e il mantenimento di una posizione regolare sul territorio attraverso una stratificazione normativa sempre più restringente. È permesso osteggiare il soccorso in mare, mentre si finanzia quel che resta della guardia costiera libica per trattenere persone in centri che sono stati definiti “lager” per migranti.
Tutto questo mosaico di dispositivi rappresenta l’esercizio di un potere che accuratamente sceglie chi può sopravvivere e chi no, chi può accedere ai diritti e chi no, stabilendo e modificando di continuo le scelte di vita delle persone razzializzate. Un potere soffocante, che trova in quest’opera un’importante riflessione sul grado di maturazione politica del dibattito antirazzista in Italia. Curcio restituisce al lettore non solo una critica incisiva, ma anche una mappatura dello sviluppo del pensiero antirazzista e delle lotte sociali che lo hanno accompagnato.
L’Italia è un paese razzista è uno strumento efficace per chiunque voglia comprendere come il razzismo sia profondamente radicato nella storia e nelle strutture sociali italiane. Un testo che si distingue per la capacità di unire analisi teorica e impegno politico, offrendo strumenti di riflessione e azione per decostruire i meccanismi di oppressione e costruire nuovi orizzonti di lotta e giustizia sociale. Un libro che arriva in Italia in un momento importante in cui “sull’onda di Black Lives Matter il tema del razzismo ha trovato una sua specifica declinazione critica, attraverso una nuova generazione di militanti antirazzisti, giovani donne e uomini neri italiani, che hanno preso parola per dire, anche in Italia, che le vite dei neri contano”.