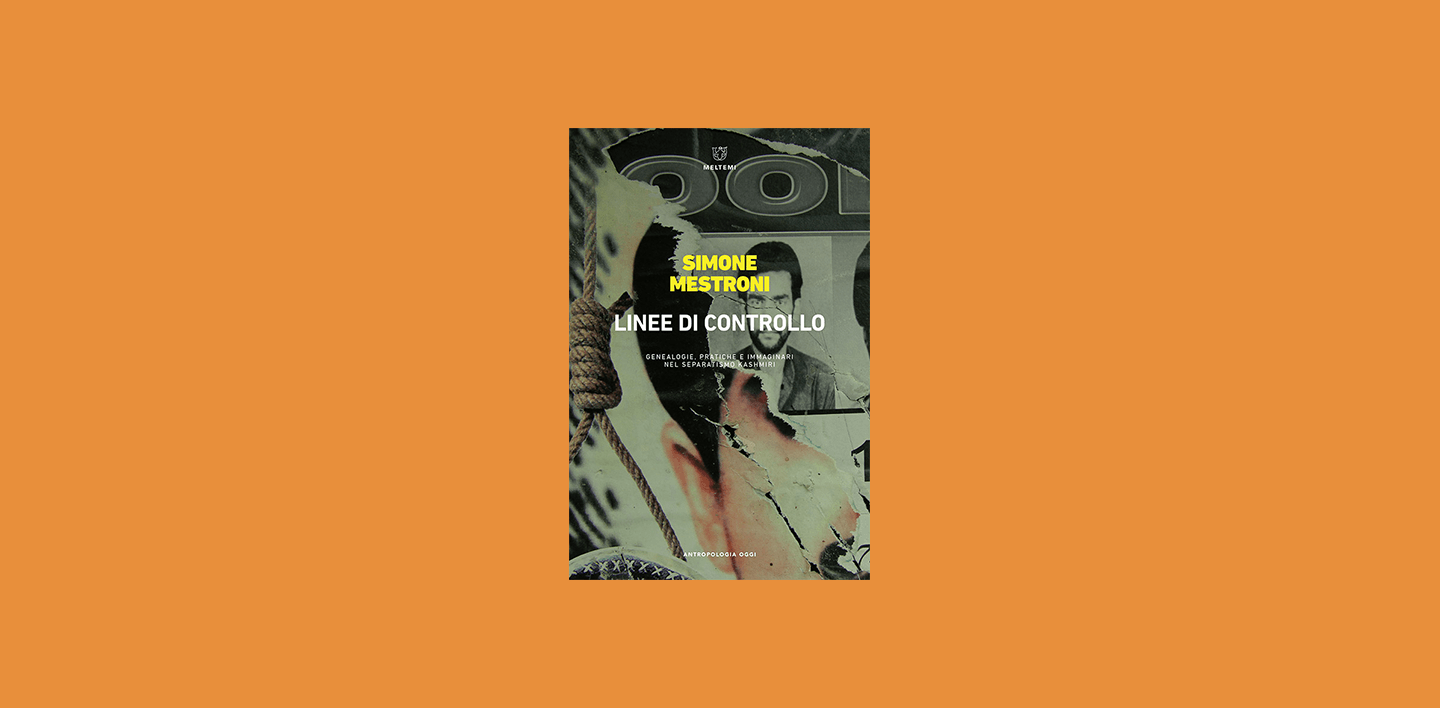
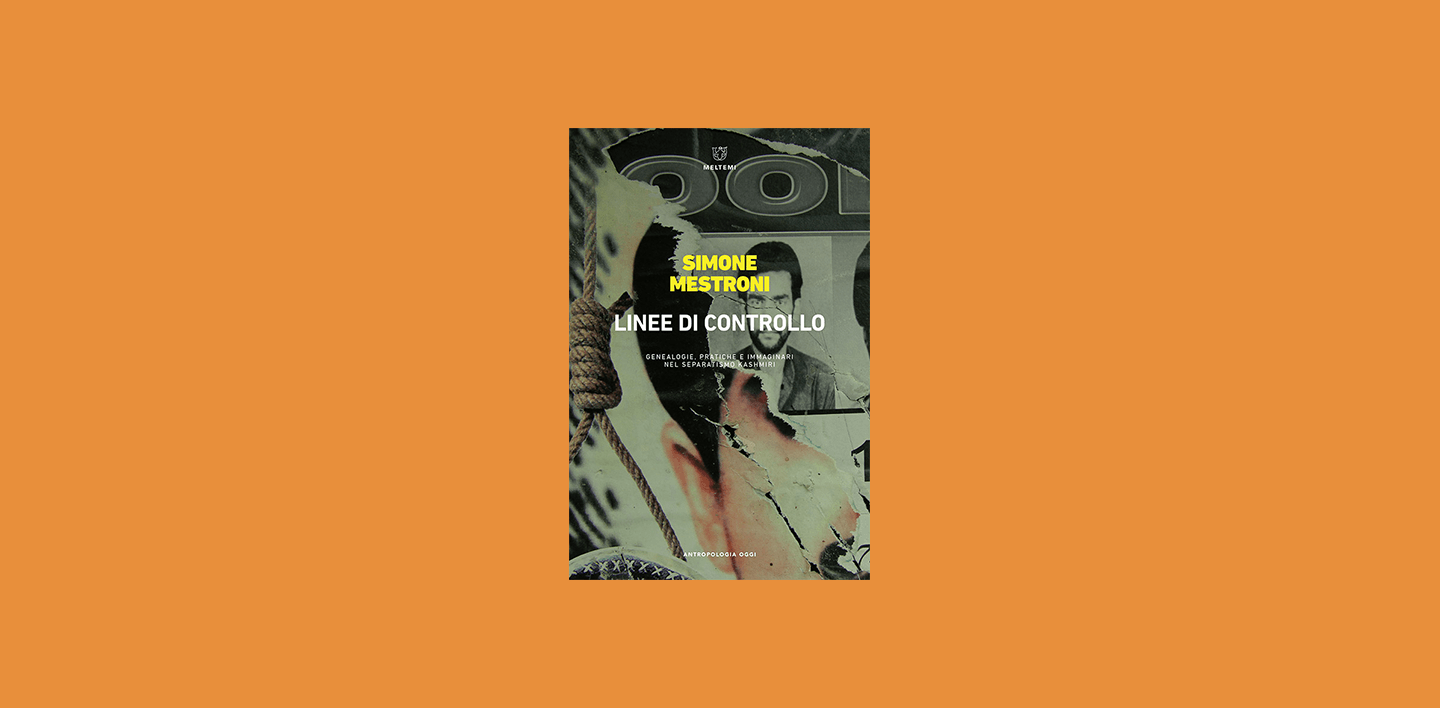
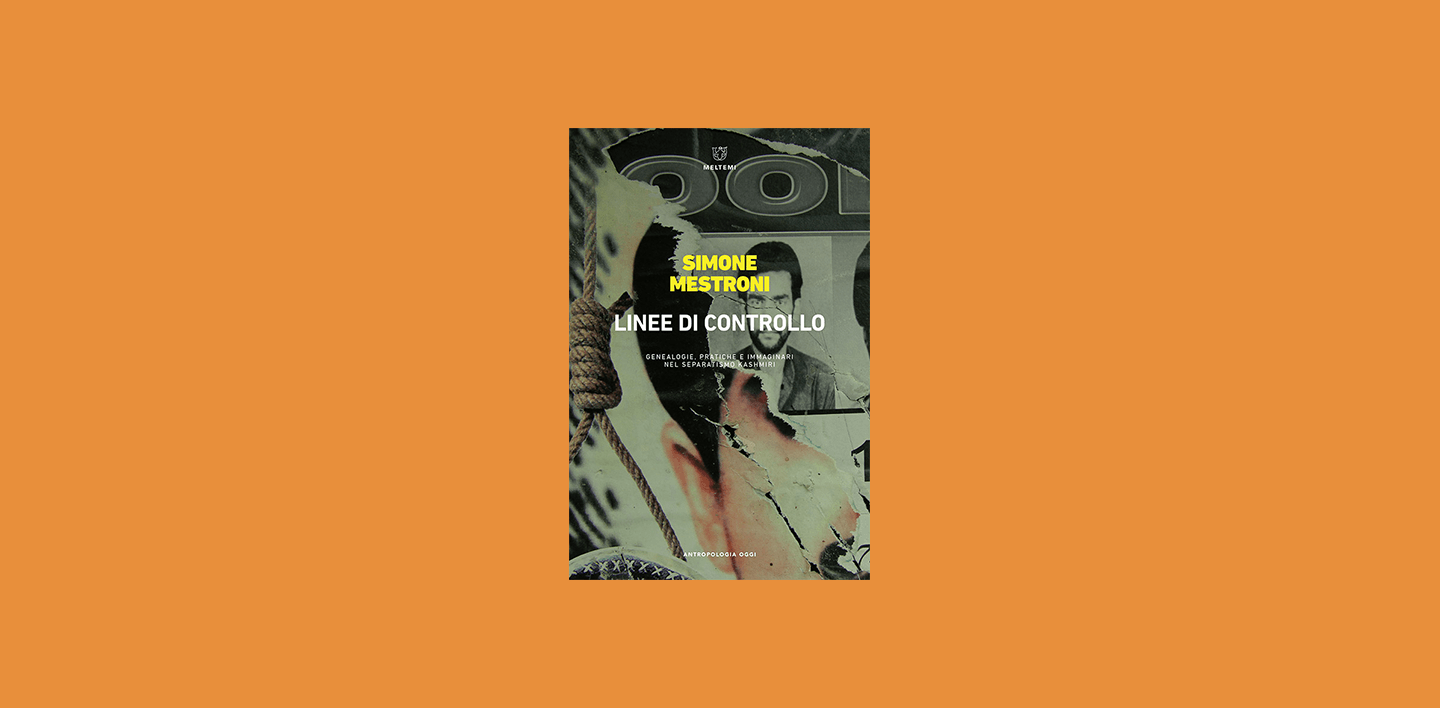
L inee di controllo di Simone Mestroni (Meltemi, 2018) è un raro scorcio sulla realtà kashmiri attraverso gli occhi e l’esperienza di chi ha vissuto gli eventi: la repressione indiana, la kanijang (le sassaiole), il lutto, la frustrazione dell’Azadi (libertà). Mestroni si cala nella vita della valle con il rigore dell’etnografo e la descrive con un linguaggio efficace e denso, assorbendone la ricca tradizione poetica. Lo fa da una posizione privilegiata, grazie al ruolo di apprendista in una bottega d’intaglio nella città vecchia di Srinagar, la capitale estiva dello stato.
È nel percorso casa-bottega, tipico della quotidianità kashmiri, che “si irradierà una rete di relazioni informali che daranno poi spessore alla sua ricerca” e da lì Mestroni si muove per raccontare la genesi, gli sviluppi e le zone d’ombra di un conflitto mai risolto. Lo fa cucendo episodi e testimonianze a necessari approfondimenti storico-politici, che tratteggiano il contesto in cui si è formata la resistenza kashmiri.
La storia della vallata si innesta su quella della partizione – la “teoria delle due nazioni” e la questione politico-religiosa che sottende alla sanguinosa creazione di India e Pakistan – le cui fratture si propagheranno nella politica kashmiri e nel (mai univoco) discorso separatista. Mestroni guida il lettore nell’intrico della politica locale, legata a doppio filo con quella globale, con “uno ‘strabismo’ che rende possibile osservare simultaneamente una specifica situazione tenendo contemporaneamente in mente non solo le dimensioni mediatiche cui un evento si raccorda, ma tutte le totalità discorsive in gioco”.
Eventi storici come la prima (e poi la seconda) guerra indo-pakistana, la nascita della frontiera, la promessa del referendum, i brogli, la lotta armata, la crisi di Amarnath, fanno da sfondo a una narrazione che procede battente attraverso gli eventi chiave della resistenza, filtrati dal vissuto personale dei personaggi, con un occhio attento al delicato riposizionarsi delle due superpotenze sul palcoscenico mondiale.
Se la Linea di Controllo sancisce con evidenza geograficamente apprezzabile la dimensione internazionale della disputa, sul piano micro-sociale questa forza divisiva si riproduce, esprimendosi in un articolato apparato di linee di controllo che arrivano a intersecare il vissuto quotidiano delle persone.
Nei primi anni ’90, “la vita a Srinagar sembrò relegarsi a due luoghi simbolo: il bunker e la moschea”. Il racconto si immerge nell’atmosfera di paura mista all’adrenalina, nel clima che si respirava nella valle, nei delicati equilibri rappresentazionali di quegli anni. Le parole di Oyoub, ex-comandante di un gruppo armato pro-pakistano, reso cieco dalla guerra, svelano le crude ragioni che hanno indotto migliaia di giovani al martirio per la causa separatista. L’autore rintraccia le radici dell’insurrezione dell’89 (e del suo fallimento) nella frattura verificatasi in quegli anni nella geopolitica e nelle macro-narrative, legate alla guerra russo-afgana e all’assetto bipolare.
Dalle parole di Saiba o di Arifa trapelano i drammi intimi, familiari, riflesso di un conflitto che pervade ogni ambito della vita, della struttura e delle relazioni sociali. Le storie, le versioni, si sovrappongono e si intrecciano, le varie voci si susseguono in un repertorio umano – Oyoub, il vetraio ex-guerrigliero, il ristoratore di Dal Gate, il Pandit della minoranza hindu – che racconta la valle da ogni prospettiva, tessuto in un racconto che diventa un documento storico prezioso per capire la complessità della storia e dell’identità kashmiri.
Sempre più giovani si univano alla lotta armata, sempre più lapidi venivano erette nel cimitero dei martiri.
Arrivano poi gli anni in cui la guerriglia iniziò ad adottare nuove strategie, come gli attacchi suicidi, rischiando di rimanere schiacciata sotto le letture semplificanti che tendono a identificare l’Islam con il fondamentalismo. Il cambio di paradigma sul piano globale è secondo l’autore “una consapevolezza che si fa strada nell’immaginario politico separatista” kashmiri dopo il 2001. Mestroni disseziona questo immaginario, gli slogan, l’autorappresentazione, e ne scarnifica la struttura, svelando le zone d’ombra nei simulacri di una narrazione ancora in corso.
In questo senso l’Azadi può essere considerata per certi versi un contenitore vuoto, un segno opaco, versatile quanto possibile nel ricercare disperatamente punti di sutura con altre formazioni d’opinione.
Il racconto passa per le mobilitazioni di massa, i funerali dei martiri, le violazioni dei diritti umani, le paranoie cospirative e la diluizione delle istanze separatiste nella rassegnazione, per raggiungere il cuore della resistenza fisica: la kanijang. Nell’anamnesi del fenomeno guerriglia nelle sue nuove vesti, il rituale delle sassaiole è per l’autore azione performata, normativizzata, scagliata contro le truppe indiane, in cui la violenza è costitutiva della comunità e ne rafforza il senso di appartenenza. La sassaiola diventa quindi la “manifestazione sensoriale ed emozionale più immediata del conflitto”, “un dispositivo attraverso cui si generano nuovi martiri, attraverso cui la spirale della violenza e quindi il conflitto stesso, si perpetuano” e la “compenetrazione tra dimensione ludica e ordine necropolitico”.
Le linee di controllo morali, personali lungo cui si muove il libro rivelano gli aspetti sociali, umani e intimi di una disputa geopolitica che non ha mai trovato soluzione. Con una rilettura della storia coloniale e contemporanea, e dei segni che essa ha lasciato, la ricerca di Mestroni diventa una chiave di lettura utile a comprendere la multidimensionalità di un conflitto che non trova spazio sui media mainstream. Il suo lavoro si colloca a cavallo tra la ricerca etnografica partecipata e un testo storico-politico che spiega l’attualità con la scorrevolezza di un romanzo, lasciando al lettore una mole di informazioni di prima mano e immagini vivide e struggenti di un Kashmir onirico e a lungo brutalizzato.