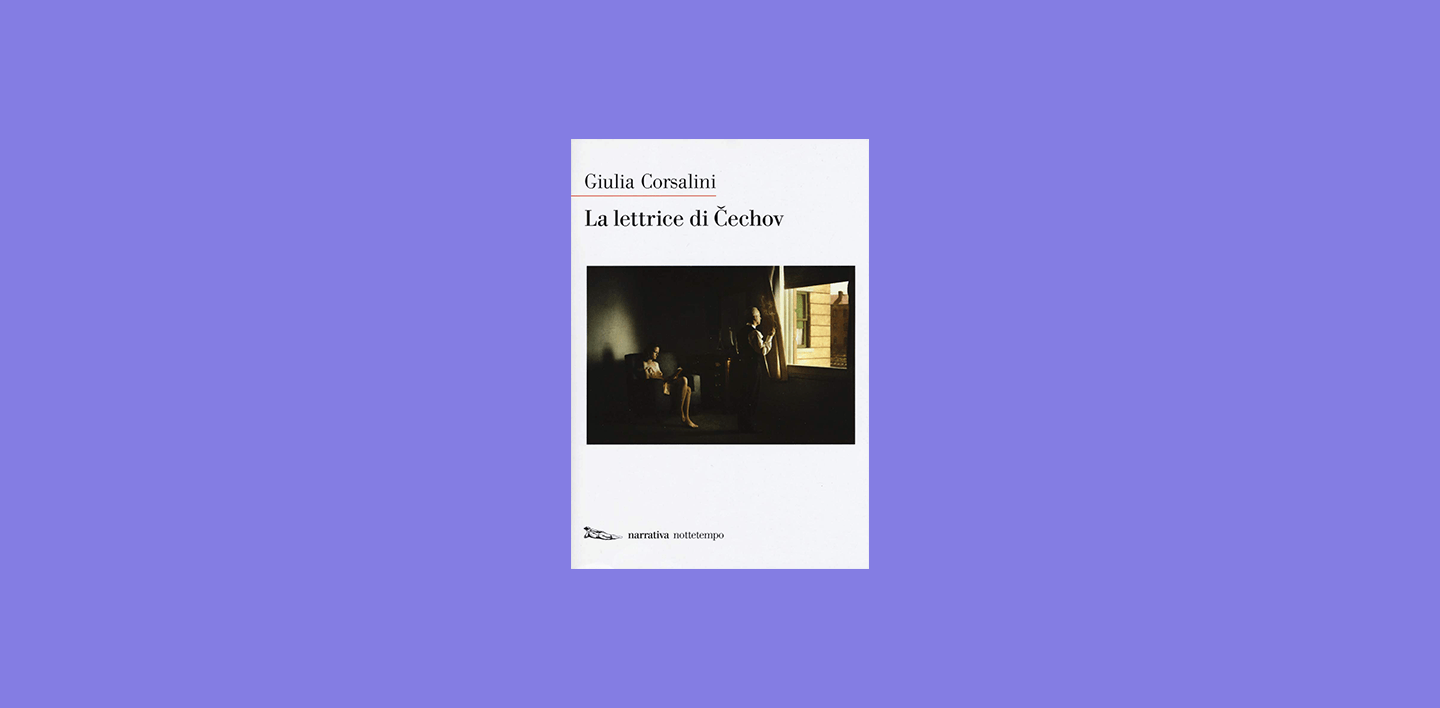
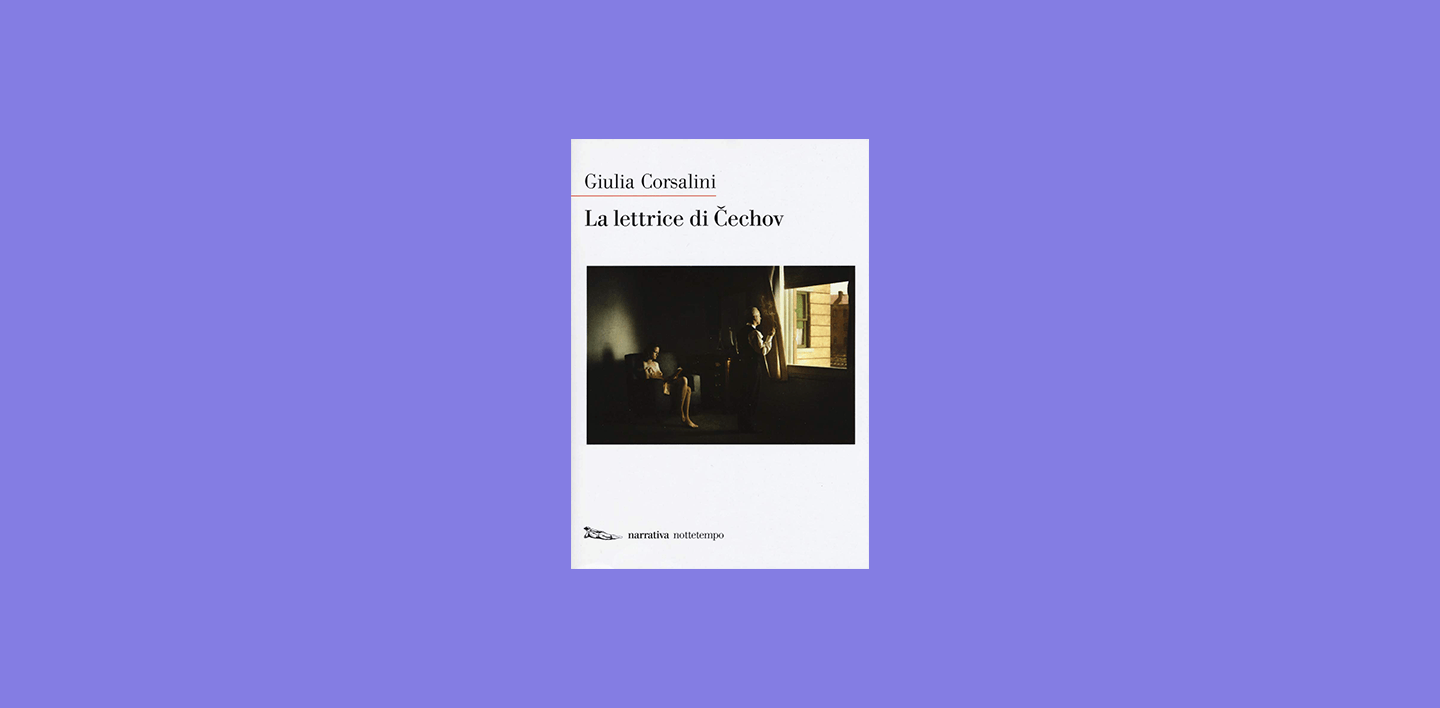
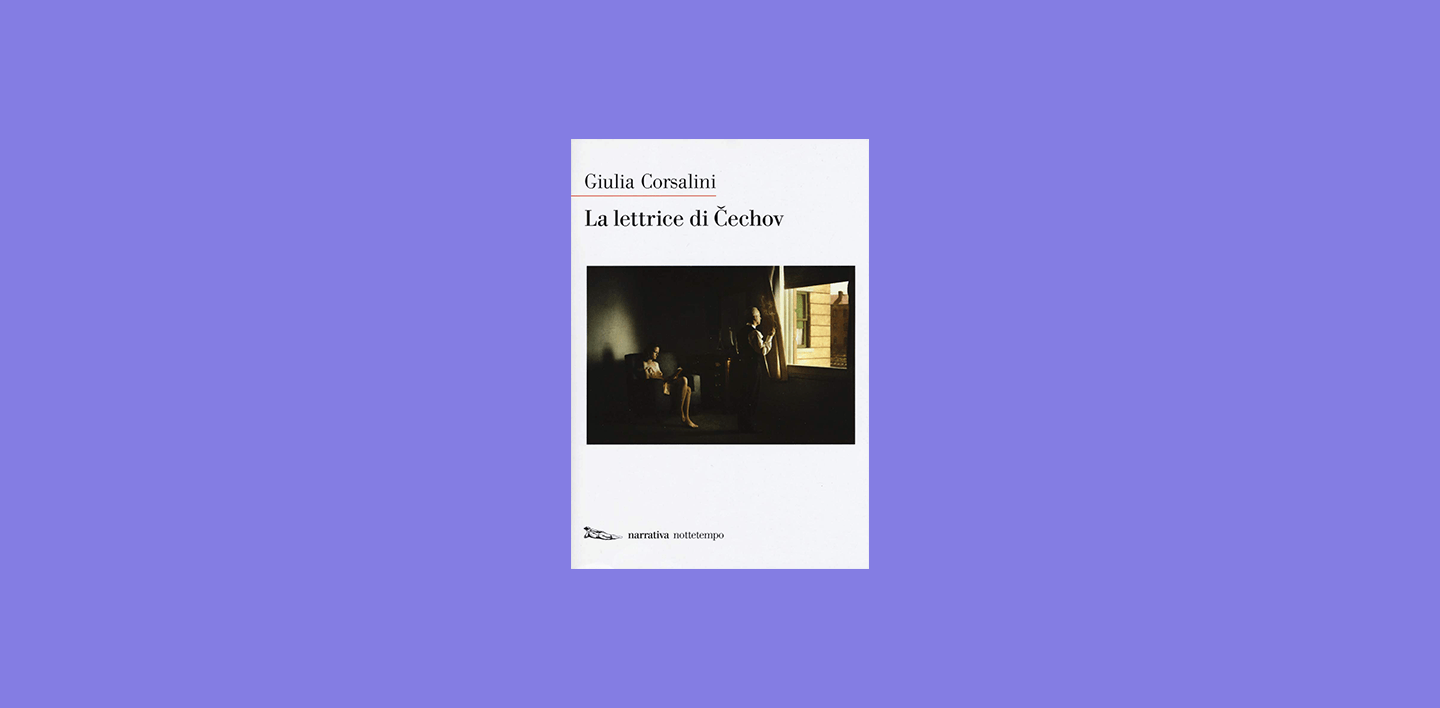
I l romanzo La lettrice di Cechov di Giulia Corsalini illustra chiaramente quali caratteristiche debba avere un’opera prima di narrativa per essere considerata un buon esordio: la voce, prima di tutto. Quella della protagonista del romanzo, che ci racconta la sua storia in prima persona, senza che arrivati alla fine sappiamo neanche il suo nome. Eppure la conosciamo, e non perché l’autrice ci abbia fatto addentrare, tediandoci, nei meandri dei suoi pensieri, nevrosi, paranoie, ma perché raccontandoci la sua storia, noi la viviamo con lei e ne comprendiamo il senso esistenziale e politico.
In strada incontravamo poca gente, soprattutto addetti allo scarico delle merci e negozianti, e i turnisti di una fabbrica di stufe, alcuni dei quali erano nostri conoscenti: venivano verso di noi lenti, stralunati, sembravano minatori usciti dalla terra; di uno di loro, un giovane alto e grosso, dal volto oblungo, d’una cordialità grossolana ed ebete, sapevamo che aveva aspirato a lungo a un incarico di segretario e forse in cuor suo ancora ci pensava.
Quel tono è come un colore, una nuance: dimessa ed elegante, di una malinconia ragionata e profonda, che lascia spazio agli altri. Lo spazio da dedicare agli altri, quale sia la giusta misura e il rischio che esso strabordi è una questione cruciale anche rispetto alla trama del romanzo, che racconta la cura. La protagonista lascia infatti l’Ucraina per trasferirsi in Italia e svolgere il ruolo di assistente personale, badante, a Macerata, al capezzale di un’anziana donna, Mariangela, non auto-sufficiente. A causa della malattia di suo marito, a casa mancano i soldi per permettere alla figlia Katia di continuare gli studi, così lei parte.
Erano pasti silenziosi, che Mariangela eseguiva come un rito, con una doppia anima, per un verso concentrata e pedante, come se il cibo fosse un dovere da assolvere, o anche qualcosa che le fosse dovuto, per l’altro assente, ottusa, lontana. Che cosa scorresse davanti a quella sua seconda anima, e se qualcosa vi scorresse o non fosse piuttosto un punto fermo del passato o un puntiglio presente, io non riuscivo in alcun modo a intuirlo: delle volte la pignoleria dei suoi gesti, il ruminare della bocca avvizzita, la piega risentita degli occhi abbassati mi erano insopportabili; altre volte la sua sola presenza mi teneva compagnia.
La narrazione di questa relazione, quella tra l’assistito e la badante, così cruciale nel mondo occidentale contemporaneo, non occupa uno spazio preponderante nel romanzo. Corsalini sa raccontarci anche ciò che tutti sanno, ma pochi ricordano: che le donne che arrivano nel nostro paese per occuparsi di anziani e disabili molto spesso approdano qui da ben altri percorsi professionali. (Indimenticabile, a riguardo, la feroce sagacia dello scrittore premio Nobel John M. Coetzee che nel romanzo Slow Man fa emergere come Marijana, la donna balcanica che si occupa del protagonista rimasto senza una gamba, non sia una donna di campagna, abituata a lavorare in una fattoria occupandosi di animali e bambini, come crede invece Paul invaghitosi di lei, ma una restauratrice, nata e vissuta in città, prima di aver attraversato l’Oceano per cercare di garantire ai propri figli la possibilità di studiare.)
La protagonista del romanzo di Corsalini è una studiosa di Cechov, che aveva rinunciato alla carriera accademica già prima di trasferirsi in Italia ma è rimasta una donna che crede che “il lavoro intellettuale in sé e la sua comunicazione a una classe di studenti continuano per me a dare un senso al mondo che ho di fronte”. È per questo che si legge e che si studia, del resto, nell’affannata ricerca di un senso: quando questa ricerca è un bisogno reale, travalica gli ostacoli che spesso si frappongono fra gli studiosi e la possibilità di vivere dei proventi dell’attività intellettuale. Non a tutti accade, infatti, di godere del paradosso meraviglioso di rispondere a un bisogno attraverso il soddisfacimento di un altro bisogno, in questo caso la necessità di lavorare con quella di studiare. A Macerata, nelle ore libere dal lavoro, prende a frequentare la biblioteca del dipartimento di lingue: alimentando questo desiderio, la nostra protagonista si garantirà anche la possibilità di continuare a studiare, almeno per un altro po’.
Attraverso l’esperienza di Lyzaveta, un’altra badante, Corsalini racconta anche la durezza assurda delle condizioni di vita di queste lavoratrici che, pur occupandosi come nessun altro fa né vorrebbe fare delle persone vulnerabili della nostra società iper-performante, sono spesso clandestine. E ci dice anche della cecità di una legge che stabilisce che per uscire dalla clandestinità è necessario avere delle prove evidenti di aver vissuto nel nostro paese: “Lyzaveta ha dovuto far finta di non esserci, per più di un anno, altrimenti sarebbe stata considerata fuori legge, sarebbe stata rispedita nella sua terra, ma questo sembra essere un dato trascurabile, non pare importante per nessuno”. Come dimostrare di essere stati laddove si doveva evitare di essere visti?
Essendo clandestina, Lyzaveta non aveva mai potuto rimpatriare per vedere sua figlia, rimasta nel suo paese, cresciuta dai nonni. Il romanzo affronta la questione sociale e politica dell’abbandono da parte di queste lavoratrici delle “loro” persone vulnerabili: i loro anziani, soprattutto i loro figli: “allontanarsi dalla propria famiglia tanto a lungo andrebbe fatto solo se si è allo stremo e forse neanche allora”. “Non devo partire” si dice la protagonista mentre in un negozio sta cercando con la figlia un abito dignitoso per arrivare in Italia, eppure lo fa e non ritorna in Ucraina quando la ragazzina la chiama per chiederglielo. Così, le due resteranno imprigionate per anni in una colpevole innocenza: quella di essere state abbandonate, quella di aver dovuto farlo.