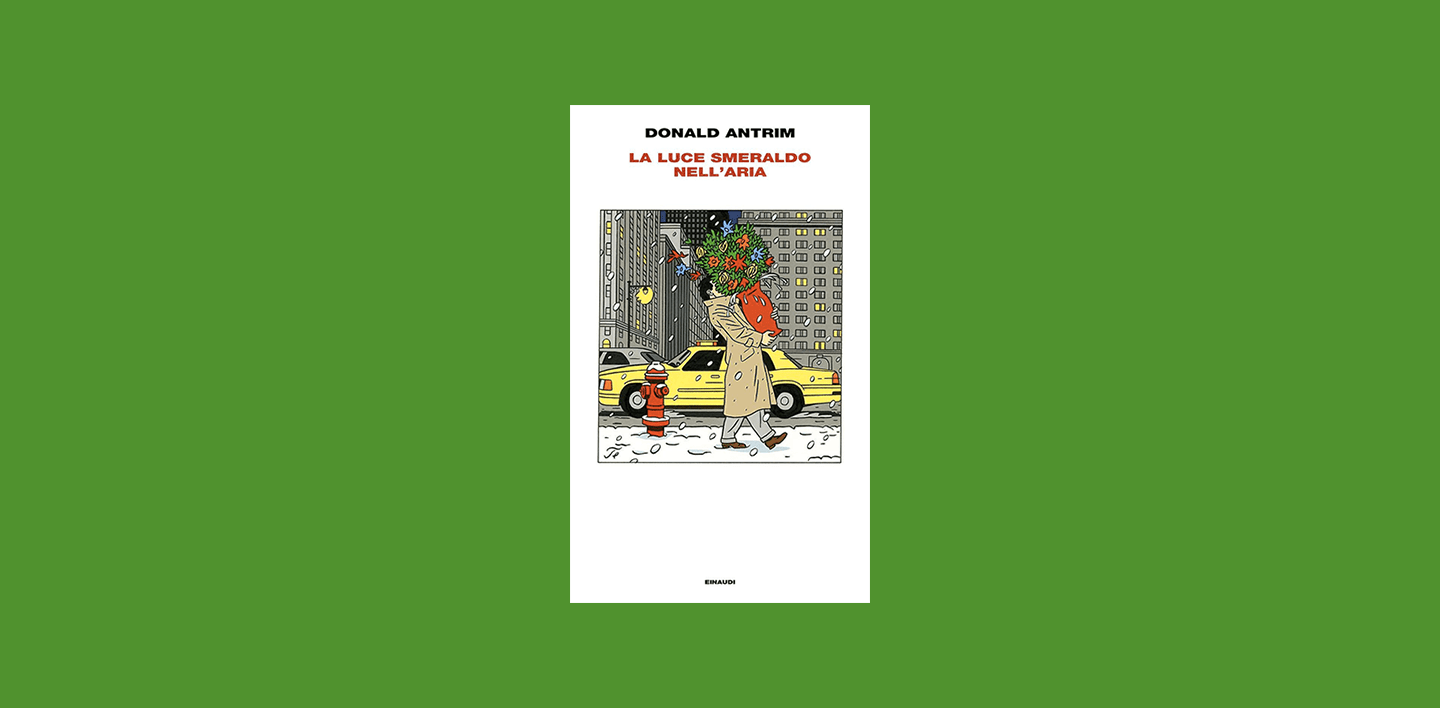
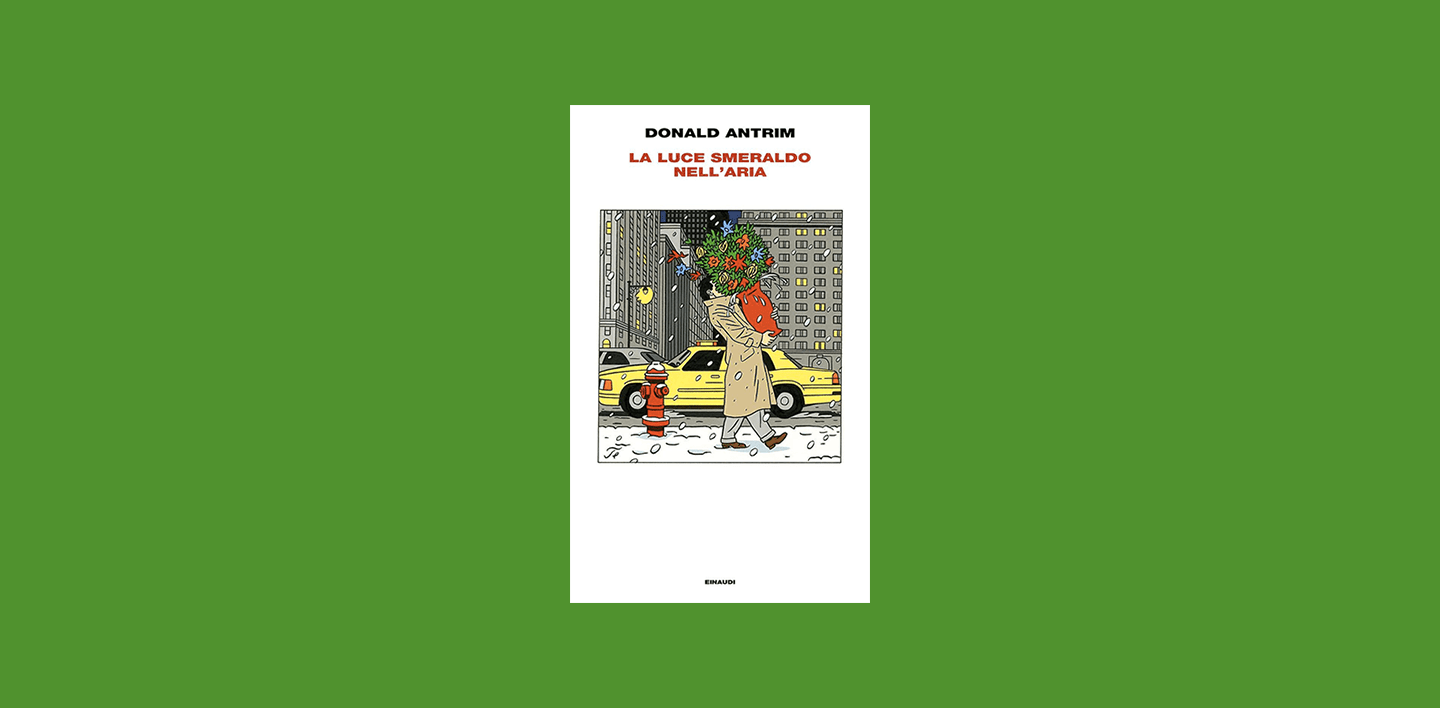
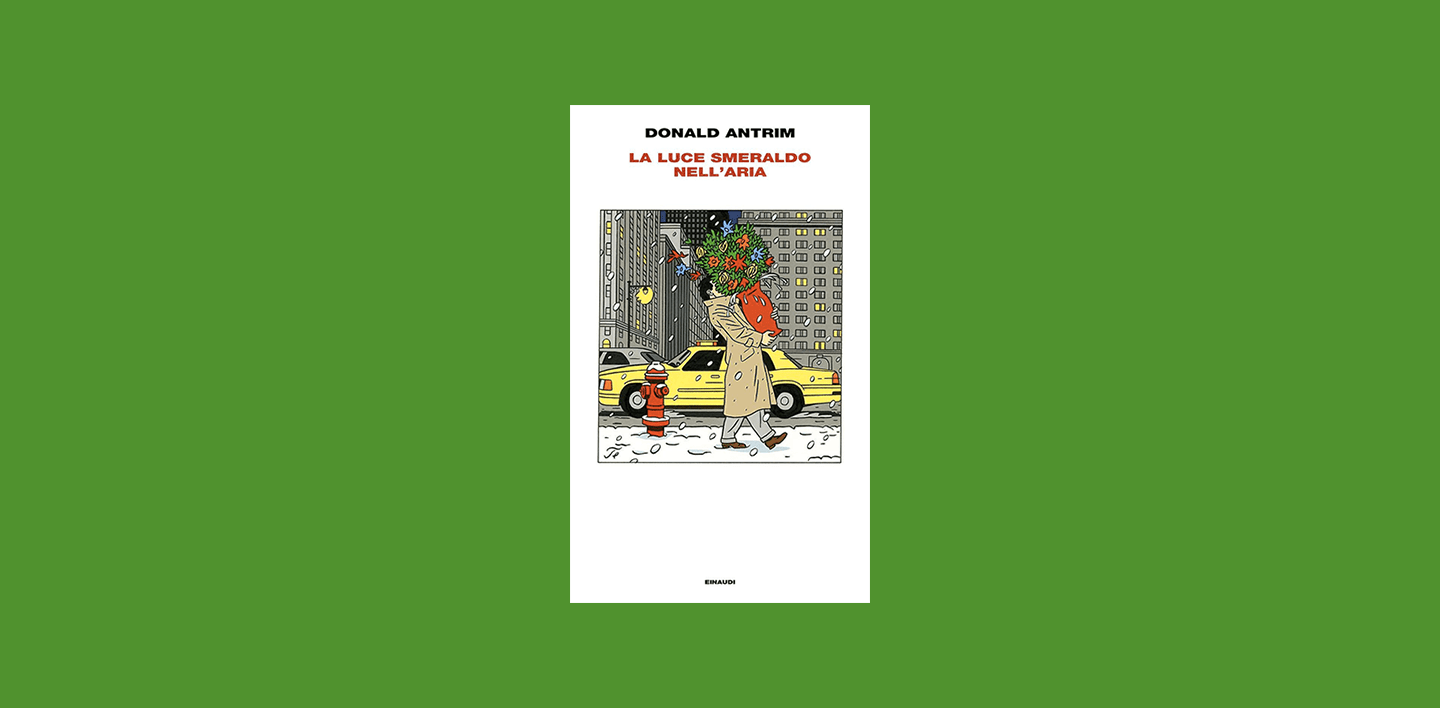
N el ruolo di direttore del New Yorker, dal 1952 al 1987, William Shawn ha contribuito a dare forma al genere letterario che oggi conosciamo come “short story americana”, creando uno dei suoi sotto-generi più influenti, ovvero quella che oggi, molto semplicemente, è nota come la “New Yorker short story”. Shawn è stato un gigante, un uomo timido e geniale che ha lanciato Joseph Mitchell, John Updike, John Cheever, Ann Beattie ed Eudora Welty, e anche, anni dopo, Philip Roth. Sebbene sia importante ricordare che non tutti i racconti del New Yorker sono stati “racconti del New Yorker” – fu Shawn stesso a insistere per dedicare quasi tutto un numero al surrealismo sperimentale e postmoderno della deliziosa Biancaneve di Donald Barthelme – è innegabile che Shawn abbia creato un genere letterario, un genere che risponde a delle caratteristiche precise, non ultima la collocazione geografica a New York, per l’appunto.
C’è anche un certo tipo di luce e di punto di vista, che emerge dai migliori racconti del New Yorker. Una luce difficile da definire: è leggera, ma anche impietosa, ma anche vissuta, benevolente, a volte si permette di sconfinare nell’assurdo, nel surreale, ma non è mai “magica”. È la luce che trovi, per esempio, nei Racconti di John Cheever, forse l’autore che meglio definisce la ‘New Yorker short story’.”
Ricercandone una definizione più concreta, ho trovato questa descrizione, tratta da un articolo del New Yorker stesso che, in un momento molto New Yorker, recensisce una collezione dei migliori racconti del New Yorker. “Cosa rende un racconto una ‘New Yorker story’? La prosa attentamente posata e ricca di virgole; i lunghi passaggi di descrizioni fisiche, la precisione e la sobrietà che creano una sorta di spazio emotivo negativo, un suggerire i sentimenti senza mai dar loro nome; i suoi protagonisti maschili, bianchi, di buona famiglia, che si trovano a soffrire le melanconie del benessere, la noia dei matrimoni nei sobborghi, l’eccitazione e la disperazione dell’adulterio; e infine, il particolare stile nei finali, che, in base ai gusti, potrebbe essere visto come elegante e obliquo o schivo e frustrante. Fuori dagli uffici del New Yorker, si raccontava che gli editor della rivista cancellassero, di routine, l’ultimo paragrafo di qualsiasi racconto venisse accettato per la pubblicazione.”
Quello che non si può ignorare, aprendo la sottile, meravigliosa raccolta di sette racconti di Donald Antrim, La luce smeraldo nell’aria, pubblicata in questi giorni da Einaudi, è che tutti i racconti sono usciti, in origine, proprio sul New Yorker. E che sono, tutti quanti, inevitabilmente, e splendidamente, racconti del New Yorker. Sono precisi, sono taglienti, sono tristi, come i migliori racconti della tradizione americana, ti restituiscono un pezzo di vita osservata con cuore, con affetto impietoso, e poi ogni tanto sono dolorosissimi. Certo è che i loro personaggi sono quasi inevitabilmente newyorchesi, newyorchesi raccontati alla New Yorker, con un sacco di virgole, un sacco di nevrosi, e un’eleganza senza pari.
Quello che non si può ignorare, aprendo la sottile, meravigliosa raccolta di sette racconti pubblicata in questi giorni da Einaudi, è che sono tutti usciti, in origine, proprio sul New Yorker. E che sono, tutti quanti, inevitabilmente, e splendidamente, parte di quel sottogenere noto come “racconti del New Yorker”.
Quello che Antrim è riuscito ad aggiungere alla ricetta, però, è uno spostamento degli argomenti, delle preoccupazioni dei personaggi, che emergono da questa forma-racconto. Se i personaggi di Cheever erano principalmente ossessionati dal conformismo del dopoguerra e dagli scoordinati tentativi di ribellione ad esso — che fossero l’adulterio, l’arte, la letteratura, la voglia di scappare o di scopare – quelli di Antrim, invece, si scontrano con una preoccupazione molto più contemporanea, quella della salute psicologica, della paura della malattia mentale, del trauma e dell’accettazione, o quantomeno del tentativo di convivere con quel dolore.
La prima frase del racconto Consolazione ne è un esempio perfetto: “Erano figli di persone che li avevano trattati in maniera grottesca, qualcuno potrebbe dire violenta, anche quando erano piuttosto piccoli, e quando, appena passata la trentina, si conobbero e cominciarono a scambiarsi confidenze, la scoperta di quel terreno comune – perché per lei questo era – le sembrò un’enorme, gradita consolazione.”
O quest’altro, l’inizio di Lui sapeva: “Quando si sentiva bene, o anche solo vagamente un po’ bene, a volte anche quando, dal punto di vista psichiatrico, non era affatto in salute ma aveva l’impressione che presto sarebbe uscito dall’Orrore, come lo chiamava lui, insisteva per portare Alice da Berdorf Goodman e poi a fare una passeggiata sulla Cinquantesettesima fino alla Madison, dove svoltavano – era diventata una tradizione – e proseguivano a nord sulle East Sixies e Seventies fino alle Eighties, in giro per negozi costosi. Anche lui alle volte era un fanatico delle firme, ovviamente – quando non stava chiuso in casa in accappatoio.”
Antrim ha sofferto un grave esaurimento nervoso dopo la scrittura di un memoir sulla scomparsa della madre, La vita dopo, nel 2005. È un autore che ha parlato più volte dei suoi tentativi di suicidio, che ha passato due lunghe degenze in un ospedale psichiatrico dal 2005 al 2007, e la sua carriera è stata segnata in modo drammatico da questo spartiacque. Nei suoi primi romanzi – la satira di Votate Robinson per un mondo migliore, nel quale un paesino della Florida esplode in un’orgia di violenza medievale; il geniale I cento fratelli, nel quale 99 fratelli si ritrovano in un castello per una notte per decidere che fare delle ceneri del padre, una specie di seguito del Padre morto di Barthelme; l’ironico Il verificazionista, nel quale uno psichiatra ha un’esperienza extra-corporea in un ristorante di pancake – sembrava essere posseduto dallo spirito postmoderno, giocoso e assurdo di Donald Barthelme. Sebbene dimostrasse già ai tempi una strabordante, quasi angosciante intelligenza, non sembrava così interessato alla verità emotiva dei suoi personaggi.
Una delle cose più interessanti, nel leggere questa collezione, quindi, è proprio vedere l’autore evolvere, progressivamente, racconto per racconto — con l’aiuto della presentazione nell’ordine cronologico di pubblicazione originale. E quindi se il primo racconto, Un attore si prepara, è ancora una farsa che risente dell’influenza Barthelmiana, è dal progressivo maturare di uno stile e dall’allargarsi del suo perimetro d’interesse che possiamo tracciare l’evoluzione e la maturazione dell’autore.
Nel mezzo del libro troviamo uno dei racconti più dolorosi che, già dal titolo, Ancora Manhattan, sembra prendere in giro l’irrilevanza delle nevrosi dei suoi personaggi newyorchesi, e la presenza del racconto sulle pagine del New Yorker allo stesso tempo. È anche zeppo di riferimenti a Virginia Woolf, dall’esaurimento nervoso mentre il protagonista compra dei fiori, come ne La Signora Dalloway, fino alla fine del racconto, che termina con uno struggente riferimento a Una stanza tutta per sé. È un racconto che riesce a reggersi in delicato equilibrio sul crinale tra il vero effetto emotivo e il distacco di un narratore che è sicuro di sé, che è anche conscio del suo sfruttare quest’effetto in maniera precisa.
Forse il vero capolavoro della collezione è il racconto che le dona il titolo. Eccone l’incipit, così newyorkeroso, così virgoloso; che include un riferimento al suicidio che per struttura del paragrafo è quasi nascosto, alla fine, obliquamente. Proprio come vuole il New Yorker.
“In meno di un anno aveva perso sua madre, suo padre e, come credeva un tempo e a volte ancora gli sembrava, l’amore della sua vita: Julia; e, durante quell’anno o, per meglio dire, durante il periodo seguito ai tentativi di suicidio, si era ricoverato due volte nel reparto psichiatrico dell’ospedale universitario di Charlottesville, dove, in entrambe le occasioni, una in autunno e l’altra nell’estate seguente, per tre mattine a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, era salito su un tavolo operatorio dove piangeva rivolto al soffitto mentre i medici regolavano le pulsazioni, gli piazzavano gli elettrodi sulla fronte, gli mettevano l’ossimetro al dito, gli affondavano un ago nel braccio e gli ordinavano, fra i bip delle macchine e l’anestetico che gocciolava dalla pipetta verso la vena, di contare alla rovescia a partire da cento; ora, a distanza di un altro anno, stava andando alla discarica, a buttare i disegni e i dipinti che Julia aveva sfornato nei mesi in cui andava a letto di nascosto con l’uomo per il quale alla fine lo aveva lasciato, e che aveva sposato, e la sua collezione di fumetti – più che una collezione era uno scatolone zeppo di giornalini – che conservava da quando era piccolo. Aveva dimenticato da tempo i suoi vecchi fumetti; poi, pochi giorni prima, li aveva scoperti su una mensola polverosa in fondo al garage, mentre cercava una scatola di cartucce.”
I critici di Donald Antrim l’hanno accusato di presentare dei personaggi che non cambiano, ma se cambiano, impazziscono. Un’analisi superficiale oltre che stranamente cattiva. Poco importa, perché Antrim sembra zittire i suoi critici, con un racconto che a prima vista parte come tutti gli altri, e invece, inaspettatamente, lascia intravedere un po’ di speranza, un po’ di luce verde smeraldo nell’aria.