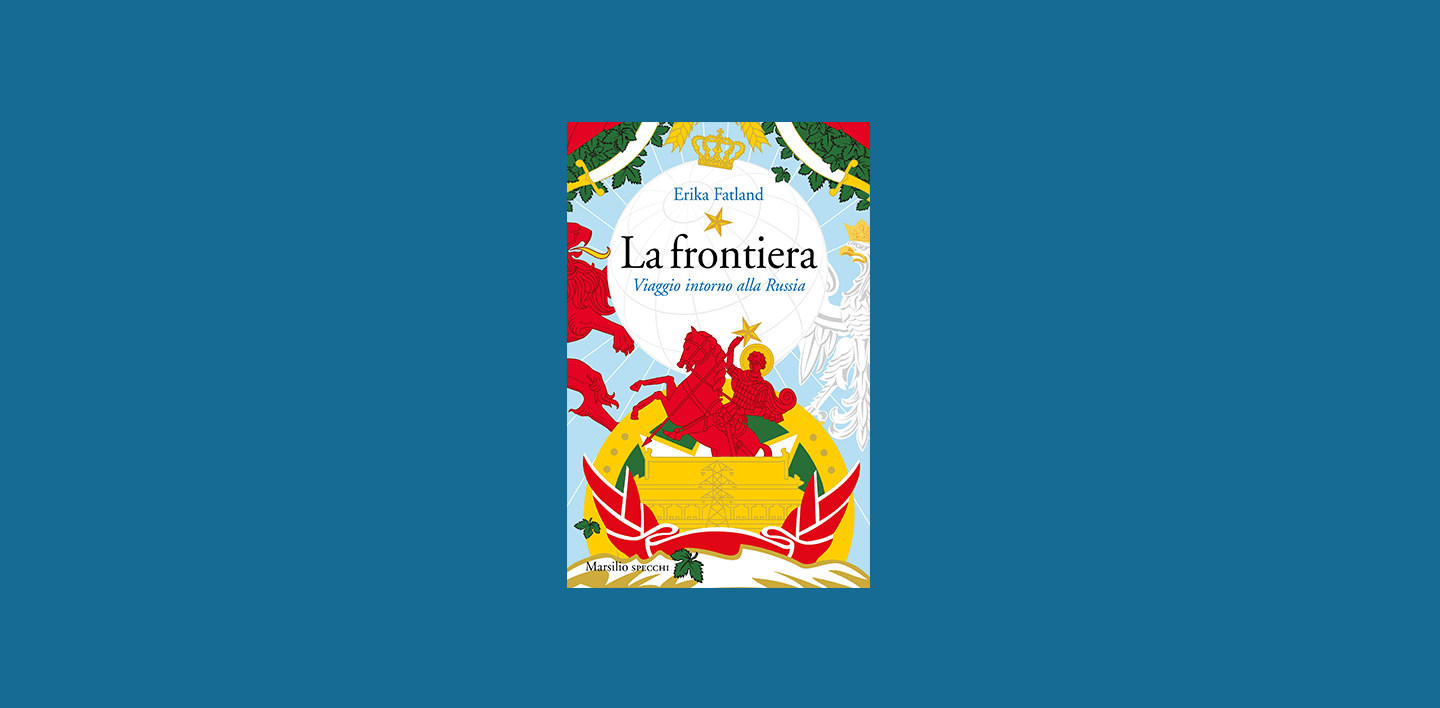
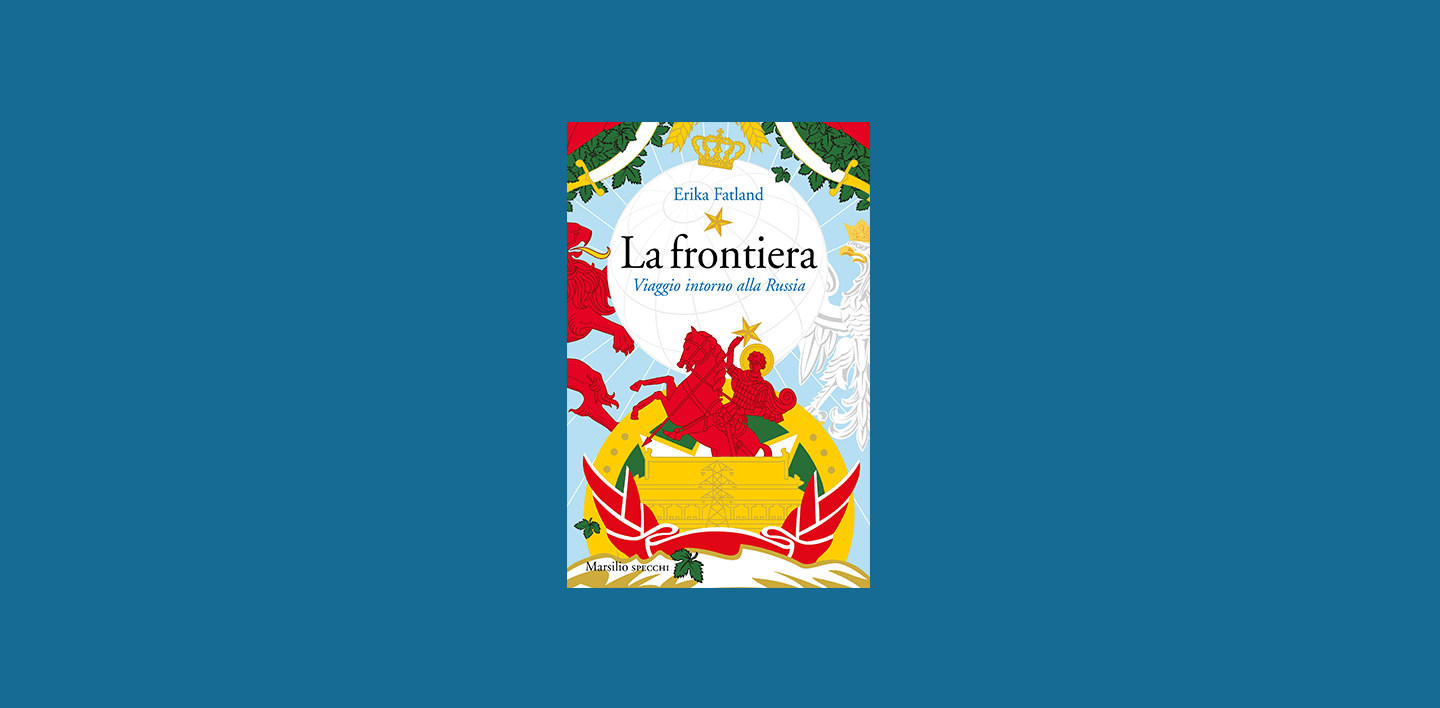
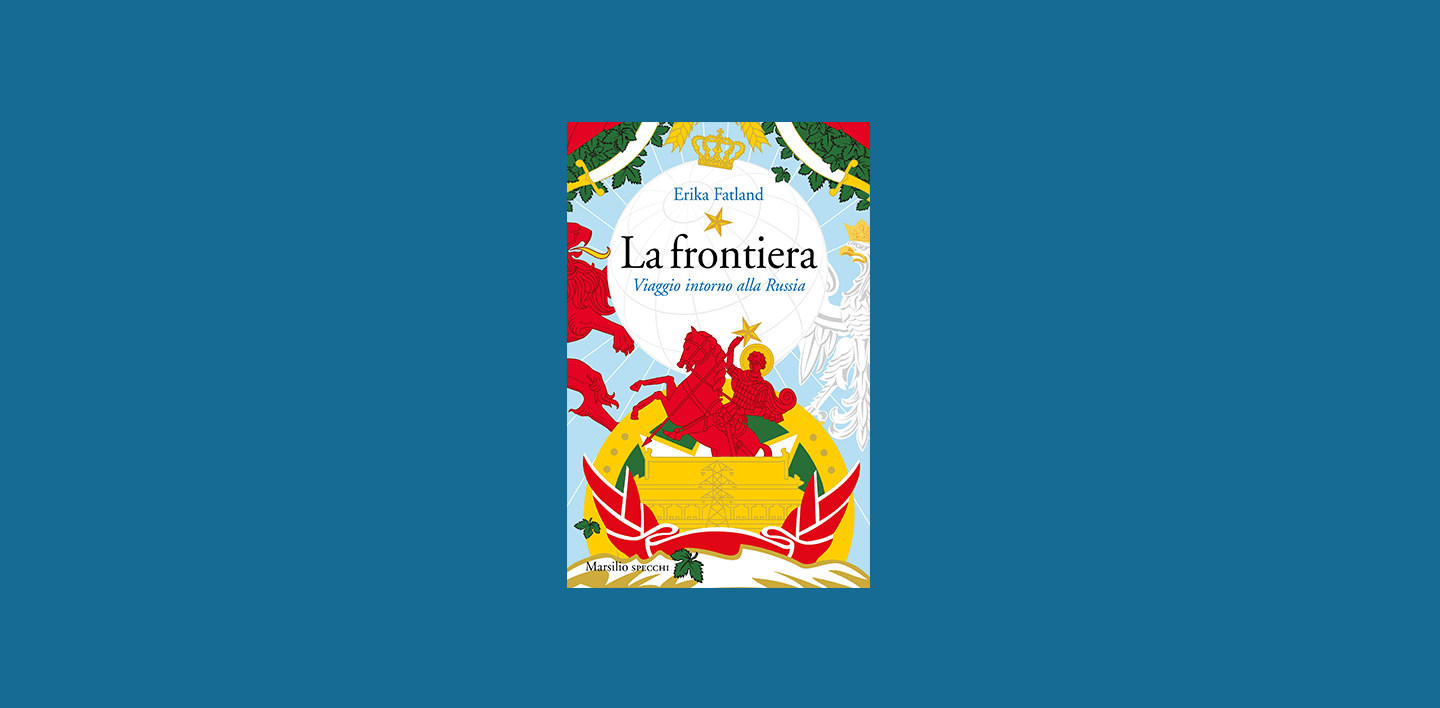
T utto iniziò con un sogno: una carta geografica, sulla quale era tracciato il profilo della Russia. Una lunga, frastagliata linea rossa ne segnava i confini, dalla Čukotka al Mar Nero. Sessantamila chilometri (una volta e mezzo la circonferenza della Terra), quattordici stati e duecentocinquantanove giorni dopo, quel sogno si sarebbe trasformato nella Frontiera (Marsilio, 2019).
La curiosità nei confronti dell’anima russa (russkaja duša) è il filo conduttore che unisce le storie di cui il libro di Erika Fatland si compone; storie tra loro tanto diverse quanto lo sono le culture, le lingue e le tradizioni da cui provengono (nel solo territorio dell’odierna Federazione Russa, annota la Fatland, esistono 200 nazionalità diverse).
Ma l’elemento caratterizzante de La Frontiera, forse il suo pregio maggiore, ciò che lo rende molto di più di una raccolta – per quanto erudita e artisticamente felice – di aneddoti che vanno dalla commedia al tragicomico, è la solidità dell’impianto teorico che ne è alla base. La Frontiera è contraddistinto dalla formazione antropologica dell’autrice, un approccio che unisce la capacità di osservazione alla simpatia per le storie di cui racconta. Senza distinzioni: dalle grandi vicende della geopolitica alle catastrofi ambientali nascoste dietro la cortina di ferro e ora dimenticate, fino all’aneddotica e alla cronaca di provincia.
Il modo più efficace per comprendere la Russia, sostiene la Fatland, consiste nello studiarne l’immagine quale si è sedimentata nelle culture e nelle memorie degli uomini che, per secoli, hanno vissuto in contatto con un’entità politica in costante espansione. Tra il 1600 e il 1800, l’autrice racconta, il territorio dello Zar cresceva al ritmo di migliaia di chilometri quadrati al giorno. “Cosa significa essere vicini di casa del più grande stato del mondo?”. Questa è la domanda che, da Ulaanbaatar a Kiev, da Murmansk a Öskemen, da Erevan a Ürümqi, Fatland ha posto alle centinaia di persone con le quali, nel corso di oltre due anni di viaggio e di ricerca, ha avuto modo di conversare; tra queste si annoverano capi di stato, professori universitari, tassisti, guide turistiche, pescatori, pensionati e allevatori di renne.
La storia di ogni impero non costituisce solo il resoconto di battaglie e di trattati diplomatici. Essa è, in primo luogo, la storia dell’invenzione, creazione e dissoluzione di “paesaggi culturali”: dell’interazione dell’uomo con l’ambiente circostante, della sua attività in grado di plasmarlo (e talvolta distruggerlo). Ciò non vale solo per flora e fauna, ma anche per i gruppi umani che in un dato territorio abitavano, prima di diventare sudditi di zar Nicola, Michele o Alessandro. Ciò avvenne non di rado all’insaputa dei colonizzati, molto spesso attraverso il dispiego della violenza dalla Kamčatka a Taškent: l’espansione dell’impero, e della civiltà di Puškin, Turgenev e Tolstoj, costituiva il Russian man’s burden.
Agli occhi di Churchill, la Russia si presentava come “un rompicapo, incastonato in un mistero, avvolto da un enigma”.
Questo complesso rapporto tra l’impero, i suoi spazi e i suoi popoli era stato già riconosciuto e descritto tra gli altri da Kapuściński, l’eco del cui capolavoro (Imperium, 1993) il lettore attento non mancherà di riconoscere, per esempio, nell’epopea della conquista dell’artico, ricostruita attraverso le vicende dei suoi protagonisti. Dal suo primo esploratore, il cosacco Semën Dežnëv (lo stretto di Bering, nota sarcastica l’autrice, dovrebbe essere intitolato a lui, che solcò quelle acque 80 anni prima del più celebre danese) a Paul Bjørvig. Partito con alcuni compagni alla conquista della Severnaja Zemlja (“terra del nord”), il marinaio norvegese si ritrovò per sei mesi a dormire in una baracca semi interrata nel ghiaccio perenne, nello stesso sacco a pelo con un compagno morto, che Bjørvig non ebbe cuore di seppellire per timore che gli orsi polari lo divorassero. E ancora: dalla bomba zar (Big Vanja in codice, “Grande Ivan”) fatta esplodere il 30 ottobre 1961 dall’URSS di Chruščëv sulla Novaja Zemlja (“terra nuova”), causando un terremoto che fu avvertito in un raggio di mille chilometri, a Capo Čeljuskin, ex base militare e ora, non diversamente dalle acque del golfo di Andreev, al confine con la Finlandia, trasformato in una pattumiera nucleare di cui nessuno sembra avere la voglia (o il coraggio) di curarsi.
Gli imperi trasformano il territorio quanto trasformano gli uomini che in essi vivono: quanto sia vero lo insegna la storia dell’ultimo impero del 1900, l’URSS. L’homo sovieticus acutamente studiato da Svetlana Aleksievič (Tempo di seconda mano, 2013) costituisce il grande protagonista collettivo del percorso della Fatland, un percorso a volte lontano migliaia di chilometri dall’attuale frontiera russa, a volte pochi metri, ma sempre, costantemente, impregnato dalla memoria di un passato le cui tracce sono visibili nella terra e nei volti degli uomini un tempo sudditi degli zar, rossi come bianchi. Benché oggi vivano in paesi diversi (a volte tra loro in guerra, come in Ucraina), parlino lingue diverse e sognino sogni diversi, gli “uomini del socialismo” tuttavia si riconoscono, e si capiscono, con uno sguardo.
Da Vladimir, un tempo professore di storia e ora miliziano anti-ucraino nel Donbass a Maja Krapina, una dei pochi sopravvissuti all’epurazione del ghetto di Minsk, passando per Dato Vanišvili, che alzatosi una mattina scoprì di essere divenuto apolide (la sua casa era stata annessa dall’ Ossezia del Sud, uno stato non riconosciuto da nessuno, nemmeno dalla Russia che la sua secessione dalla Georgia aveva propiziato), ai vecchi credenti di Poperečnoe nel profondo Altai o l’ex polizei nazista lettone Visvaldis Lācis, Erika Fatland dà voce ai sogni e alle miserie che hanno caratterizzato, per usare le parole di Varlam Šalamov, “una battaglia coraggiosa, e perduta, per rifondare il genere umano”.
Agli occhi di Churchill, la Russia si presentava come “un rompicapo, incastonato in un mistero, avvolto da un enigma”. Al termine del viaggio, Erika Fatland non pretende di aver risolto il rompicapo di Churchill. Tuttavia, contemplando lo spazio infinito dell’artico dalle scogliere di Grense Jakobselv, l’ultima tappa, tanto l’autrice quanto i suoi lettori hanno modo di riflettere sulla verità profonda di ciò che, duemila anni fa, Erodoto aveva osservato a proposito dei destini umani: “città che un tempo erano grandi ai miei giorni sono divenute piccole, e città un tempo piccole sono ora divenute grandi”. Al pari delle Storie, La Frontiera dimostra che questa legge universale non risparmia nessuno. Nemmeno il più vasto impero del mondo.