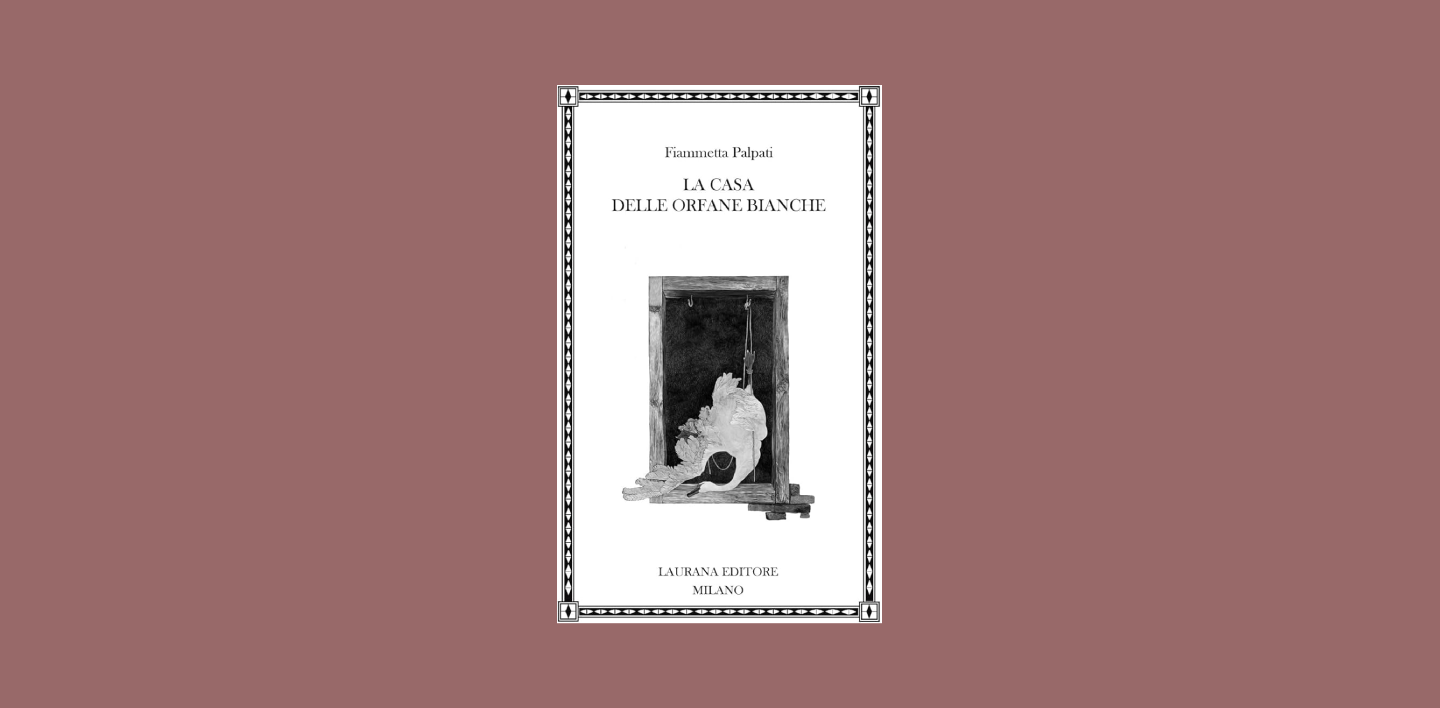
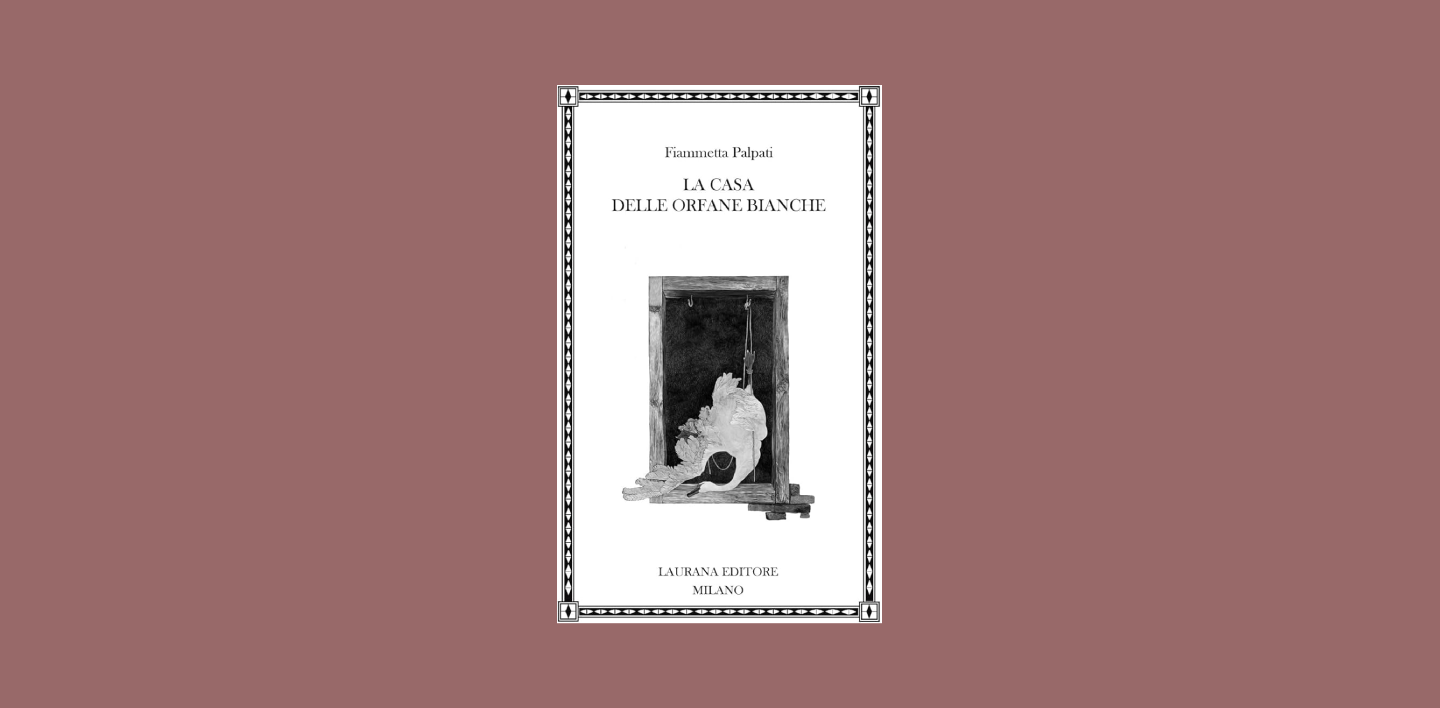
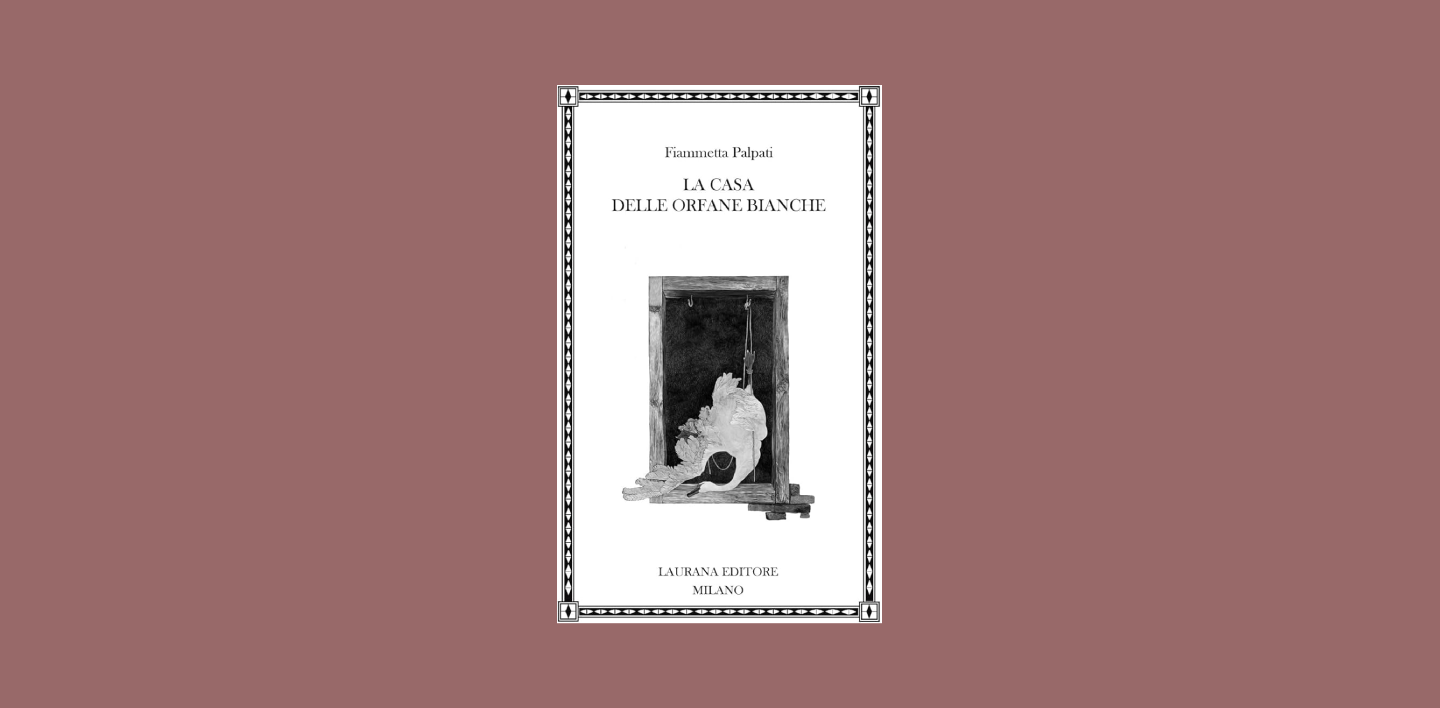
D ella grande quantità di romanzi familiari che da un po’ di tempo a questa parte ha conquistato la ribalta dei premi letterari e gli scaffali più in vista delle librerie (le due cose, naturalmente, sono in stretta relazione) cosa ricorderemo, in futuro? Prendendo in analisi le più recenti trasformazioni del romanzo di famiglia Dominique Viart, con la categoria di “récit de filiation”, ha messo a fuoco uno scivolamento del genere, nella contemporaneità, dalla questione strutturale della famiglia (riguardante, per esempio, l’eredità, o il linguaggio familiare) verso il problema soggettivo dell’espressione e dell’autenticità.
Sempre di più, secondo lo studioso, a partire dall’era postmoderna si sarebbe profilato un genere che fa della genealogia del singolo individuo, dei suoi traumi e dei suoi rimossi, la principale domanda che emerge dalle opere. Si sviluppa così un genere che scava nella storia familiare, in fondo, per liberarsene, per lasciarsi alle spalle la pesantezza dei fantasmi ereditati e dare campo ad una supposta libertà del soggetto, finalmente svincolato da ogni lacciòlo formale o strutturale. Da una simile trasformazione simbolica emerge in molti casi un narratore in prima persona, lo sguardo ossessionato dal passato, che cede spesso ad un registro melodrammatico e ad una prosa involuta, pronta (nei casi peggiori) per essere tradotta in ambito audiovisivo attraverso immagini color pastello.
Niente di tutto ciò nel romanzo d’esordio di Fiammetta Palpati, La casa delle orfane bianche. Tutta una serie di elementi, anzi, tendono a porre una certa distanza tra il lettore e la materia dell’intreccio e a raffreddarne gli effetti più emotivi, sebbene il dolore non sia risparmiato ai personaggi. Tre figlie di mezza età (Lucia, Natàlia, Germana) decidono di condividere un tetto sotto il quale spartirsi gli oneri dell’accudimento delle proprie anziani madri (rispettivamente Felicita, Pina e Adele, tutte con gravi problemi psichici). Sfumata da velleità regressive e romantiche (“… il desiderio è solo uno, e di tutte: un nido, caldo, pulito, dove l’ordine tenga lontano il male. Il desiderio di una casa felice”), l’idea organizzativa di rifondare la famiglia su basi pragmatico-razionali si rivelerà avere implicazioni dalle risonanze ben più complesse: non si stravolge la “normalità” senza pagare una qualche forma di dazio. La convivenza diventa in breve tempo una tragicommedia collettiva, una concatenazione di scene grottesche e talora farsesche, sulla quale si proiettano in tono minore i maggiori temi della vita umana (l’invecchiamento, la malattia, il sacro) e segnatamente del ruolo femminile nella famiglia (la maternità, la cura).
Già. Progetto ambizioso, dicevamo poco fa. Bislacco, aggiungiamo adesso. Che idea strampalata hanno avuto queste figlie. Non basta essere infelici per farsi venire un’idea così. Be’, sul principio, è parsa anche sensata. Poi ha preso il suo verso, come tutto ciò che è sbagliato. Perché non solo il bene, a dividerlo, si moltiplica. Anche il male.Ma non vorremmo condizionarvi col nostro pessimismo.
Come si vede, il narratore si prende la libertà di commentare con disinvoltura ironica le vicende, che riferisce in presa diretta come fosse uno spettatore davanti ad una rappresentazione teatrale, ambientata negli interni di una casa, in un piccolo paese umbro. La sala da pranzo è descritta come un vero proscenio:
Si immagini un locale ampio, che serva tanto da sala da pranzo quanto da soggiorno, nell’insieme modesto ma non trascurato; con un gusto e un carattere, anzi, che esprimono le ambizioni e i limiti di chi vi abita – e lo si consideri d’ora in avanti, in mancanza di indicazioni diverse, la scena. Sulla parete di fondo ci si figurino la porta d’ingresso e una finestra, entrambe affacciate su un’amena piazzetta con tanto di belvedere sulla pittoresca valle del Rio Grande (un torrente, ahinoi, asciutto). […] Sul lato sinistro una grande apertura ad arco, da cui si intravedono la rampa di scale che sale alle camere da letto e alla soffitta, e l’altra: quella che scende alle cantine e all’orto. Un poco più verso di voi, e sul medesimo lato, una stanzuccia da letto, poco luminosa ma al piano. Sul lato opposto, invece, lo spettatore immagini la porta della cucina e di un secondo bagno; un bagnetto, piuttosto, ricavato dalla tamponatura di un balconcino, come usava molti anni fa, prima che i servizi igienici fossero integrati nelle murature.
La voce narrante è strettamente vincolata alle percezioni che concede il punto di vista interno alla scena. Non sale né scende mai le scale: tutto ciò che il lettore apprende e che si svolge al di fuori di questo fondale scenografico è una risultante del discorso diretto di uno dei personaggi, ai quali non è in alcun caso concessa una focalizzazione interna e dei quali dunque il narratore, ed il lettore con lui, può solo inferire gli stati psicologici a partire dall’osservazione. In questo ambiente si dipana un fitto intreccio di dialoghi e azioni drammatiche – che arrivano a sfiorare, in molti punti, il ritmo incalzante di una sceneggiatura teatrale. Eppure, se di teatro si tratta (come lasciano intendere anche le notazioni peritestuali – “Romanzo in due atti e un intervallo galante”, recita il sottotitolo), manca il pubblico in platea. Quest’ultimo sembra trovare una sintesi paradossale, poiché situata all’interno del proscenio, nella voce narrante – che molto presto infatti si rivela essere un “noi” plurale.
L’idea organizzativa di rifondare la famiglia su basi pragmatico-razionali si rivelerà avere implicazioni dalle risonanze ben più complesse: non si stravolge la “normalità” senza pagare una qualche forma di dazio.
La celebre operazione pirandelliana è dunque riconoscibile (tutto è costruito per attentare alla separazione tra la scena e la realtà) ma invertita: non l’abbattimento della “quarta parete” bensì l’assorbimento della realtà, ivi inclusa la realtà fisica di uno spettacolo teatrale, nella finzione romanzesca. Prova ne sia che nella breve scena dell’“intermezzo” tra i due “atti”, è raccontato un cortocircuito tipico di una simile impostazione metanarrativa. Durante l’intervallo dello spettacolo (quello di cui, in quanto lettori, stiamo godendo) assistiamo infatti ad un flirt tra un uomo e una donna che dovrebbe stare su di un piano ontologico differente rispetto a quello diegetico. Eppure, notiamo con sconcerto, il nome della donna coincide con quello di una delle protagoniste della vicenda.
Apertamente pirandelliano è anche il meccanismo umoristico che volge le azioni sconclusionate delle figlie in manifestazioni del tragico. Germana passa, in poche pagine, dal ruolo di figlia stralunata, che fa sobbalzare la carrozzella della madre Adele sul selciato del belvedere sotto casa (noi lettori assistiamo alla scena dalla finestra della stanza), alla potenziale matricida di una scena in cui il crescente risentimento della figlia, che accompagna la tensione del monologo accusatorio verso la madre impossibilitata a rispondere, esplode in aperta violenza (cui evidentemente, vista l’indifferenza di rimando, le donne sono assuefatte):
Germana alza il tono:
“Tu le hai sopportate, le voci”. Aggrotta la fronte. “Ma io mi chiedo come si fa… Come si fa a vivere tutta la vita con qualcuno che ti parla nella testa”.
Silenzio. Poi un movimento rapido con i gomiti, un colpo deciso sulle tempie, come suonasse due piatti. Preme. Spinge. Schiaccia… gesunnostro Adele è una smorfia grottesca: gli occhi due fessure all’insù –, da cinese, mentre le labbra boccheggiano nel tentativo di prendere aria, o emettere suoni:
“Aiuto”. […] Nessuno, tra i prossimi, presta attenzione.
Dietro ogni maschera non più la vita – la vita vera che, sia pure in costante riassorbimento nella smorfia pirandelliana – bensì l’abisso spaventoso della relazione, anche quella scelta e costruita ex novo dagli individui svincolati dai legami parentali classici, che emerge violentemente in scene drammatiche come questa, oppure nelle confessioni figliali rese al sacro, che irrompe sulla scena nel secondo atto sotto forma di una suora grottesca vestita di abiti sudici e maleodoranti.
È solo attraverso una simile espiazione tragica, a cui si sovrappongono una serie di connotazioni religiose, che le figlie trovano la forza per affrontare il lutto, per diventare finalmente le orfane del titolo e porre così le premesse per una trasformazione delle relazioni, che continuerà, necessariamente, dopo il sipario e fuori dalle pagine del libro: “E qui si chiude la porta sulla casa delle orfane bianche. Non si conclude, invece, la storia”.