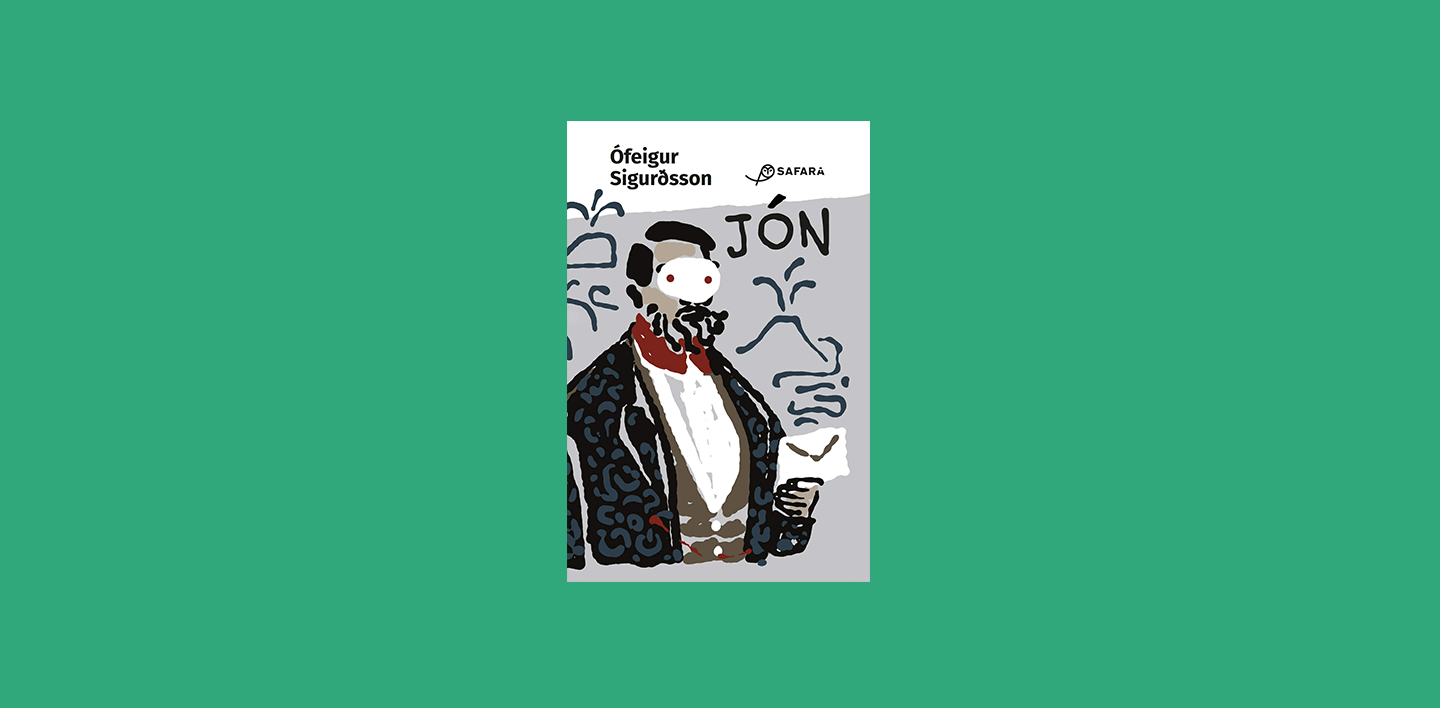E
ldklerkur – ‘chierico del fuoco’ – è l’epiteto che si meritò il pastore, medico e naturalista islandese Jón Steingrímsson (1728-1791) per aver salvato la sua parrocchia, nel 1783, deviando miracolosamente una colata di lava durante un’eruzione. Già cronista attento della sua gente e delle peculiarità della sua terra, per difendersi dalle maldicenze sul suo conto scrisse, a beneficio esclusivo degli eredi, un’autobiografia in forma di confessio agostiniana, la Ævisaga séra Jóns Steingrímssonar, data alle stampe soltanto nel 1913.
Ispirandosi ai fatti avvenuti al reverendo tra il 1755 e il 1756, Ófeigur Sigurðsson ha composto un romanzo epistolare – ora uscito nella versione di Silvia Cosimini per Safarà Editore come Jón & le missive che scrisse alla moglie incinta mentre svernava in una grotta & preparava il di lei avvento & dei nuovi tempi – con cui nel 2011 ha vinto lo European Union Prize for Literature. Si tratta del secondo romanzo dell’autore, noto in patria principalmente come poeta e traduttore in islandese di Louis-Ferdinand Céline, Michel Houellebecq e Roberto Bolaño.
Jón, ancora diacono, è costretto ad allontanarsi dalla moglie Þórunn per via delle calunnie di chi lo accusa di aver ucciso il suo precedente marito. Parte così in compagnia del fratello Þorsteinn verso l’Islanda meridionale, dove i due trovano rifugio in una grotta. In attesa che, con la primavera e al termine della gravidanza, Þórunn lo raggiunga, Jón si appresta a preparare la casa dove vivranno, ma si trova a fare i conti con un’ostilità di portata spaventosa: la devastante eruzione del vulcano Katla sulla vallata della Mýrdalur. Per esorcizzare l’angoscia, per documentare e salvaguardare il proprio lavoro e soprattutto per non perdere il contatto con l’amata, Jón le scrive allora una serie di lettere, senza alcuna certezza che le verranno mai recapitate. Jón è un’indagine sulla fragilità del rapporto tra gli esseri umani e la natura, il senso di devastazione e di impotenza, la reclusione, la distanza e l’isolamento, e li spinge all’estremo, pur rimanendo perfettamente piantato nella realtà storica dei personaggi.
Il pregio principale del libro sta proprio nel riuscire a delineare il sofferto e credibile profilo di un uomo confinato, circondato da pericoli di ogni sorta, in un mondo fuori controllo. Fiaccato nel corpo (è claudicante), nella reputazione e nello spirito, dalla grotta sul mare che condivide con il fratello, Jón osserva l’ambiente circostante, “l’abbraccio aperto della morte”.
Ai suoi occhi si offre lo spettacolo tremendo dei marosi che dissolvono la costa, del gelo iperboreo che fa strage di greggi, dei terremoti che sconvolgono il paesaggio, come se la terra fosse in lotta con sé stessa. L’acqua sporca riempie i vuoti, il terreno si fa melma e palude, le polveri vulcaniche trasformano la brughiera in un disorientante “deserto di sabbia nera”. Ai più fortunati, i fumi sulfurei e la cenere si limitano a intasare le vie respiratorie, a infiammare gli occhi. Chi non muore nel fuoco perde cari, casa e sostentamento ed è soggetto all’indigenza, al vagabondaggio e a terribili malattie che Jón, al meglio delle sue forze e conoscenze, tenta di curare con unguenti, decotti e salassi. Tutto, racconta Jón alla moglie, “è buio e freddo, un flusso tumultuoso e disperante”.
Il cataclisma in cui è coinvolto, per lui, non può che essere un segno della volontà divina, un “durissimo castigo” o un’enorme ordalia, una prova – personale, nazionale, persino globale – non diversa dalla distruzione delle bibliche Sodoma e Gomorra. L’eruzione del Katla assume i tratti della catastrofe universale, arrivando a toccare anche il terremoto che il 1° novembre dello stesso anno aveva distrutto Lisbona e aveva portato Voltaire a domandare provocatoriamente, contro le teodicee e l’ottimismo del suo tempo: “Se questo è il migliore dei mondi possibili, gli altri cosa sono?”.
Rispetto al disastro, Jón è a tratti uomo sia di scienza sia di fede ma è anche, essenzialmente, un individuo che lotta con sé stesso, sgomento e bisognoso di senso e di speranza. Allo stesso modo, ai momenti di operosità e curiosità intellettuale alterna stati di spossatezza, debilitante nostalgia, accidia e melancolia. Difficile non lasciarsi tentare dal presentimento di essere vittime di un ordine ingrato, “impietoso, freddo e smemorato”. È in tempi di crisi che le debolezze di ciascuno sono maggiormente esposte.
La gente ritiene che sia giunto il giorno del giudizio e viene colta dal terrore per i propri peccati e le questioni rimaste da risolvere per ogni dove, oppure non comprende che cosa stia accadendo. Bambini come adulti albergano in uno stato di disperazione/la lava scorre sopra la loro resistenza fisica/la cenere ricopre la loro disposizione mentale/tutti son come sul letto di morte: la melancolia prende il sopravvento.
Le sue lettere a Þórunn sono scritte con l’inchiostro nero di quella “depressione che ricerca la depressione […] una mestizia norrena, una dolcezza dolorosa, nonché un piacere del dolore” per cui “il sole diventa nero”. È un’immagine quintessenziale. Il sole nero è un simbolo ricorrente nell’immaginazione romantica (successiva all’eldklerkur, ma di certo familiare all’autore), dalle visioni di Mary Shelley in The Last Man al globo oscuro che sorge dal profilo di John Keats, rapito da un sonno misterioso, in un ritratto fattogli qualche settimana prima della morte. È il noir soleil de la mélancolie di Nerval e prima ancora di Heine, presente già nel Book of Urizen di William Blake, anticipato dalla luce fredda e sconsolante nell’orizzonte del celebre Melancolia I di Dürer, che ha origine nel Libro della Rivelazione (6, 12). Congiungendo in sé l’apocalisse e l’atrabile (o meglio, facendo dell’umor nero un’apocalisse), è l’immagine sommamente efficace per rappresentare la portata assoluta e cosmica della depressione, il senso di sfascio imminente e inevitabile a cui non solo il soggetto ma le cose tutte sembrano andare incontro.
È una concordanza, quella tra mondo esterno e mondo interiore, che fondandosi sul potere suggestivo del paesaggio nordico, reso supremamente evocativo dallo sconvolgimento naturale, riprende un percorso già iniziato da Ófeigur Sigurðsson con la sua prima raccolta di poesie, Skál fyrir skammdeginu (2001, ‘Saluto al buio invernale’), e costituisce la chiave di Jón:
La situazione è orrenda/nessuno sa dove poggiare i piedi senza timore/che la terra si fracassi tutta/sprofondi/venga lavata via/si dissolva/sia spazzata via/si prospetta una moria generale del bestiame/seguita dallo sterminio degli esseri umani/la terra è uno sfacelo/si viene risucchiati in un baratro/chiazze d’inchiostro/rantolano i ciottoli della riva/sprofondano nella sabbia/ansimano sulla battigia/presso gli scogli al largo/le secche/spariscono in un pantano/chiazze d’inchiostro/le parole di Dio s’inabissano/si sfilacciano/i miei peccati fluttuano in superficie/lo scritto straripa sulla carta/chiazze d’inchiostro/le parole sono salvifiche…
E scrivere, coltivare la conoscenza, è davvero l’unica salvezza per Jón. È il suo modo per tenere viva la speranza e prepararsi all’avvento – di Þórunn, il cui arrivo è descritto con toni soavi e sensuali da Cantico dei cantici, e del momento in cui la terra (“una creatura vivente”, un “corpo”) sarà abitabile di nuovo, e bisognerà trovare forme di convivenza e non di “faida”. L’Islanda, d’altronde, è sia la terra senz’alberi, disboscati in epoca medievale (coprono tuttora solo il 2% del territorio), sia l’isola dei ghiacci e dei vulcani mai del tutto antropizzabile. Raccogliere e preservare il sapere della sua gente diventa allora lo scopo dell’attività di Jón. E non solo perché è un uomo del suo tempo – è dopotutto il secolo del conte di Buffon e della sua Histoire naturelle, di Carl Nilsson Linnaeus e della tassonomia dei viventi, dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert –, ma perché “la conoscenza è l’uomo stesso”.
Lavoro da poeti, che “durante il sonno […] sudano come a svolgere un lavoro di fatica. In quel momento si trovano nei campi”, in quel mondo sommerso da cui provengono, “costretto e bloccato nella coscienza della veglia”. Lavoro da salvare a ogni costo, affidandolo a Þórunn nella forma di lettere d’amore, in un testo che prende dal prosimetro e dal poema in prosa, pur con un gusto per la versificazione libera e sincopata più contemporaneo che scaldico.
Sondare e purificare terra e cuore per costruire una casa concreta e una per l’anima, è questo il compito a cui Jón è chiamato. E farlo – dice – “come se stessimo edificando il mondo”, in raccoglimento e preparazione per tempi migliori, quando “tutto ciò si placherà e volerà via e sarà mondato di nuovo, e ci ritroveremo ancora sui delicati pascoli di primavera. Allora m’infilerò un tarassaco nel cappello e ti bacerò”.