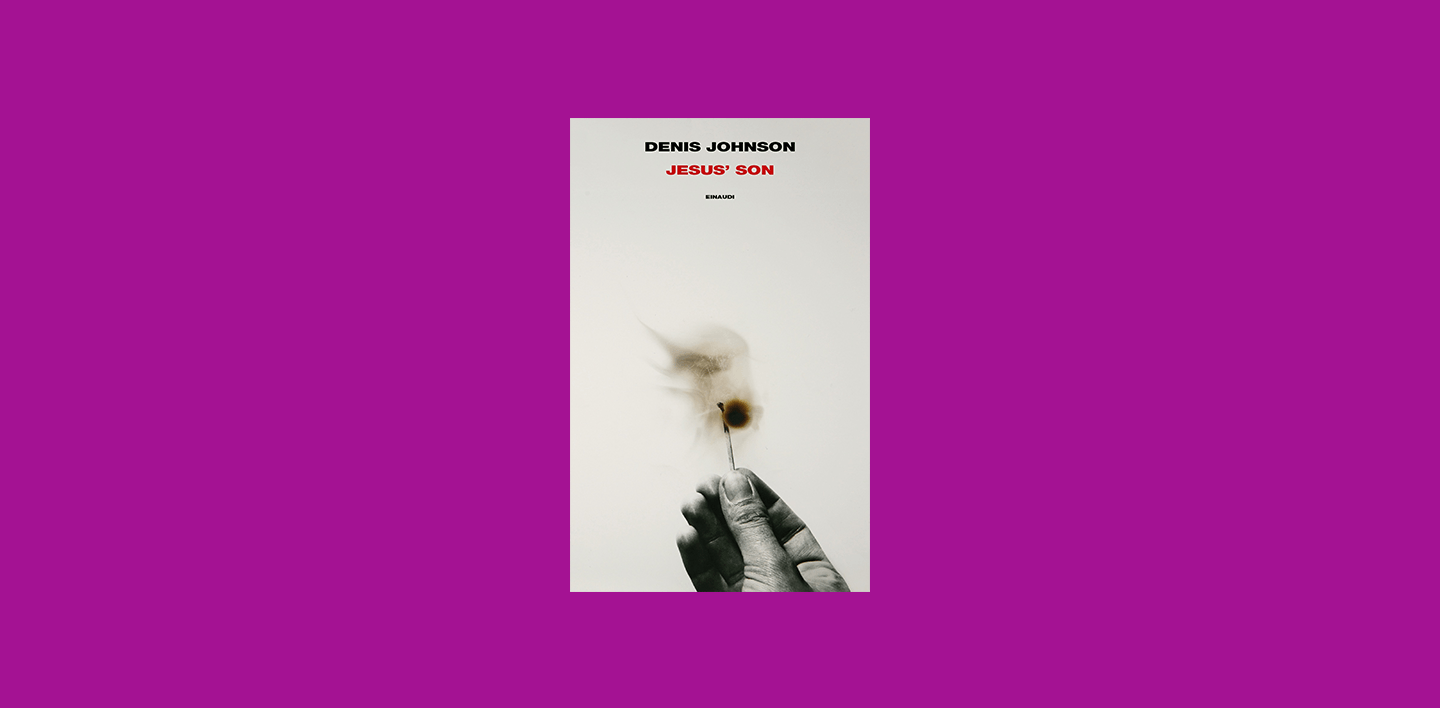
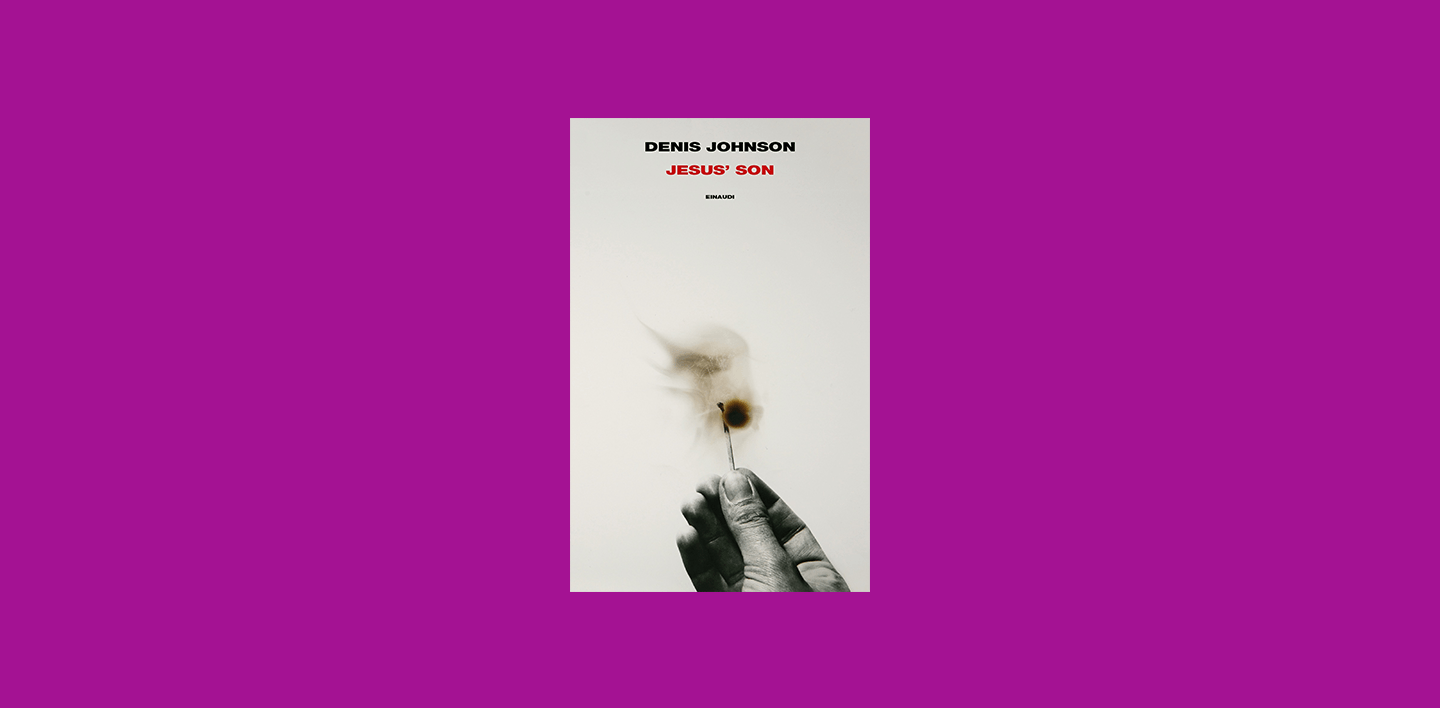
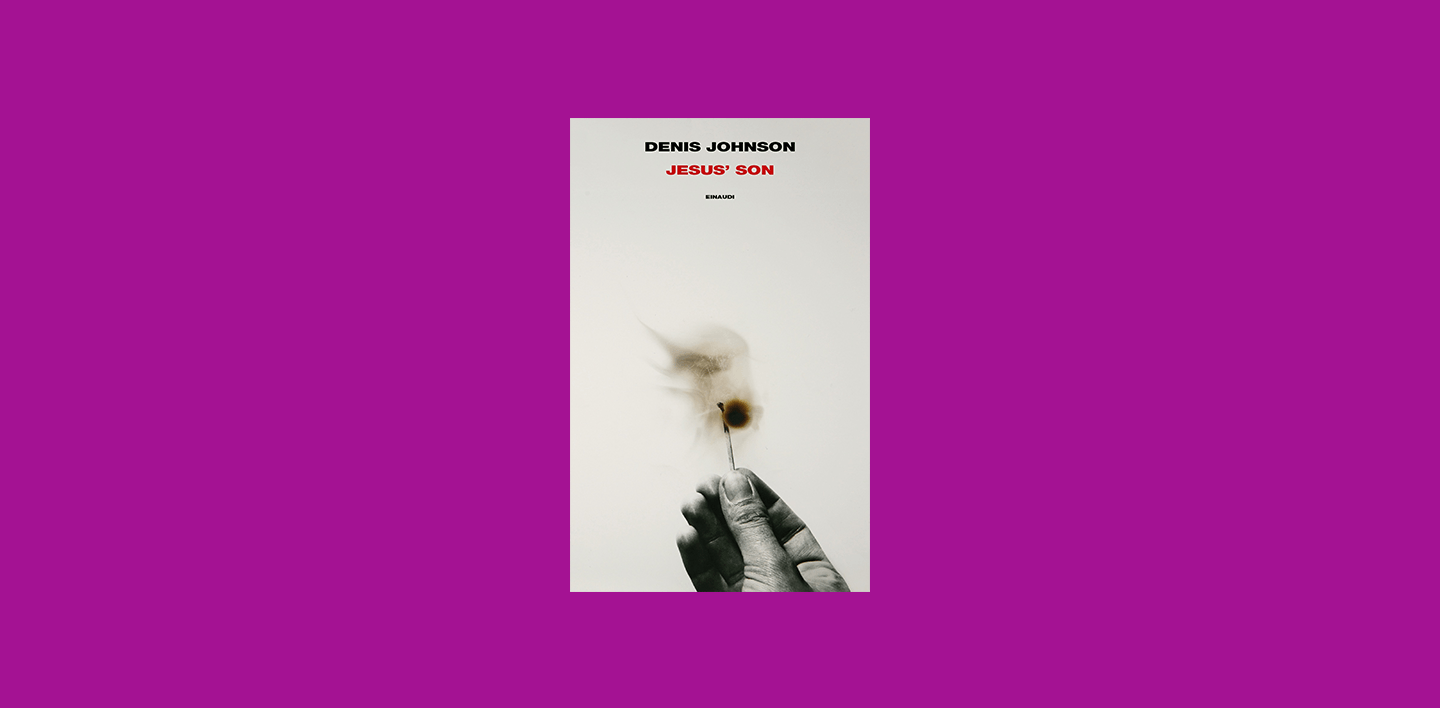
S econdo John Updike, Denis Johnson aveva lo stesso feroce minimalismo di Hemingway e i suoi racconti erano all’altezza di quelli di Raymond Carver (suo insegnante all’Università dell’Iowa). A rileggere Jesus’ son a ventisei anni dalla sua prima pubblicazione – e a un anno dalla scomparsa di Denis Johnson – questi paragoni non rendono giustizia alla straordinaria bellezza e forza del libro. Einaudi, intanto, lo ha ripubblicato, con una nuova traduzione di Silvia Pareschi: un gesto editoriale a metà tra il tributo e il bisogno di dare una rinfrescata a un libro che continuerà sempre a essere più giovane e fresco di qualsiasi traduzione, conversazione o analisi gli si possa dedicare. È per questo che lo amiamo? Perché in un centinaio di pagine riesce a raccontare la vita e la morte, la violenza e la grazia, la dannazione e redenzione di Testadicazzo (Fuckhead, in originale) attraverso undici storielle da bar, come le chiamava lo stesso Johnson?
Jesus’ son è come ricevere una coltellata nell’occhio e continuare a vederci. Che è, poi, quello che più o meno accade a un uomo nel racconto “Emergenza”: “è stata mia moglie, – ha detto il tizio. La lama era conficcata fino all’impugnatura nell’angolo esterno dell’occhio sinistro. Era un coltello di quelli da caccia”. Ad assisterlo, in ospedale, ci sono Testadicazzo e Georgie, che passano il tempo rubando pillole dagli armadietti e pulendo il sangue nelle sale operatorie, oltre a un’infermiera e un medico che farnetica di voler chiamare “un gran mago degli occhi”, “il migliore”, “un artista dell’etere”, anche se siamo in un ospedale qualsiasi e ciò non accadrà mai.
“Ci vedo” conferma il tizio sulla barella, “ma non riesco a stringere il pugno sinistro perché la lama mi sta facendo qualcosa al cervello”: ecco, è lo stesso effetto che fa Jesus’ son su chi lo legge, “qualcosa al cervello” per cui è difficile, se non impossibile, produrre un discorso di senso compiuto intorno alla sua materia, alla sua scrittura, alla sua enorme influenza letteraria.
Solo per dare una misura di quest’ultima, da quando è nato il New Yorker Fiction Podcast (in cui autori leggono e commentano racconti apparsi sulla rivista), Denis Johnson è stato letto ben tre volte e, in tutti i casi, per una storia che fa parte di Jesus’ son. (L’unico altro autore così letto è Barthleme.) L’ultimo ad averlo fatto è Donald Antrim, che sceglie di leggere “Lavoro”, la storia in cui Testadicazzo e il suo amico Wayne se ne vanno a staccare filo di rame dalle pareti di una casa abbandonata e poi a bersi i trenta dollari sudati giù al Vine. Antrim nota come la storia sia una somma di scene che non sembrano neanche collegate tra di loro: “Lavoro” inizia con un uomo e una donna che litigano fuori da un Holiday Inn, dopo che, registrati sotto falso nome, hanno passato tre giorni a bere, drogarsi e fare l’amore (“vomitavamo, piangevamo, ci accusavamo, ci imploravamo, perdonavamo, promettevano e ci portavamo in paradiso a vicenda”). Dopo il litigio l’uomo la abbandona là e, senza neanche mettersi la camicia, sale su un autobus che lo porta al Vine, dove poco dopo incrocia Wayne che gli propone l’affare del rame: che ne è della donna? che diavolo ci fanno in un motel, se l’uomo abita là attorno? Le domande restano senza risposta. Johnson è come se mettesse una pistola nella prima scena, commenta Antrim, ma poi decidesse di non farla sparare, contravvenendo a qualsiasi meccanismo narrativo, preso dalla foga di raccontare una storia o, forse, solo da una vita che non ha bisogno della linearità. “L’incoerenza dei suoi processi mentali ha, in fondo, una sua coerenza”, conclude Antrim.
“Lavoro” è forse uno dei più bei racconti di Jesus’ son: ci sono le lacrime, c’è la droga, una macchina scassata pagata sessanta dollari, il Vine, l’alcol, una rissa sfiorata. C’è, soprattutto, “uno di quei momenti”, come li chiama Johnson, in cui la realtà sembra trasfigurarsi in qualcos’altro:
mi ricordo di averne vissuto uno quando avevo diciotto anni e passavo il pomeriggio a letto con la mia prima moglie, all’epoca ancora la mia ragazza. La nostra pelle cominciò a risplendere, e l’aria prese un colore così strano che pensai che la vita mi stesse abbandonando, e mi ci aggrappai con ogni fibra e cellula del mio giovane corpo per strappare un altro respiro.
“I momenti migliori capitavano sempre quando c’era Wayne”, continua Testadicazzo, “Ma quel pomeriggio, per qualche motivo, è stato il migliore di tutti”: hanno i soldi, qualcuno sta pagando un giro, al bancone c’è la loro barista preferita, “vorrei tanto ricordarmi il suo nome, ma mi ricordo solo la sua grazia e la sua generosità”.
Sembra una piccola parabola: due tizi che, grazie al lavoro, trovano una specie di posto nel mondo, ma poi ecco che Johnson lo fa ancora – ci impedisce di concludere il pensiero, perché nel ricordare la ragazza dice “non ti dimenticherò mai. Tuo marito ti picchierà con la prolunga e l’autobus partirà lasciandoti lì in lacrime, ma tu sei stata mia madre”; chiude con questa immagine, che si specchia con quella iniziale, lasciandoci qui a chiederci come sia possibile che quella sia sua madre. È una metafora? C’è spazio per le metafore dentro un posto del genere? È sua madre, quindi?
Johnson, insomma, ha un vero talento nel non risolvere mai la tensione dei suoi racconti: lo dice anche Salvatore Scibona, parlando di “Due uomini”, un racconto che si apre con un ballo dei veterani e continua con una notte in macchina tra un sordomuto, un bordello e un inseguimento e che finisce con una scena di insensata violenza in cui il protagonista blocca a terra una donna, minacciando di ucciderla.
La donna non si era mossa. Era rimasta lì sul tappeto.
– Non c’è, è la verità – ha detto.
Lo sapevo. – Non mi importa. Te ne farò pentire.
“Johnson fa in modo che empatizziamo con un personaggio, che poi scopriamo capace di commettere qualcosa di atroce, e ci lascia col peso di averlo farlo” dice Scibona: seguiamo ogni singola azione di quest’uomo finché non ci troviamo in mezzo a un salotto pronti ad ammazzare qualcuno, insomma, attoniti perché non sappiamo né come ci siamo arrivati, né cosa accadrà dopo, se la donna verrà graziata o no. Johnson riesce a portare il lettore dove il lettore non sarebbe mai andato e poi lo abbandona lì, senza bussole morali a cui appellarsi.
Il libro si apre con un’epigrafe da “Heroin” di Lou Reed, pezzo da cui, tra l’altro, prende anche il titolo (“When I’m rushing on my run / And I feel like Jesus’ son”), e con la storia di questo innominato protagonista (che poi impareremo a chiamare Testadicazzo) che fa l’autostop, bagnato fradicio, sotto la pioggia battente. Una macchina lo carica, con moglie, marito e due bambini, ma poco dopo vengono coinvolti in un incidente: c’è sangue, ci sono morti, denti spaccati, le corsie di un ospedale. Testadicazzo prova a sottrarsi alle domande dei poliziotti, alle cure dei medici, come alla disintossicazione a cui dice di essersi sottoposto tempo prima: la scena si conclude con “e voi, gente ridicola, voi vi aspettate che io vi aiuti”. Non c’è, però, solo crudeltà e violenza in queste storie, non c’è solo gente che lascia gli amici nel pronto soccorso a prendersi le colpe per un affare andato male, c’è anche un senso di comunità per una tribù sghemba fatta di ubriaconi, tossici, ragazze zoppe e abbandonate, “tutti quei tipi strani, e io che in mezzo a loro stavo un po’ meglio ogni giorno. Non avevo mai saputo, mai immaginato neppure per un istante, che potesse esistere un posto per gente come noi”.
In uno di quei podcast del New Yorker, Deborah Treisman raccontava di quando una volta Denis Johnson al Brooklyn Academy of Music le aveva confidato che Jesus’ son non era altro che una scopiazzatura di L’armata a cavallo di Babel’ (ne parla un lungo pezzo su Millions). Una dichiarazione riduttiva, eppure, se anche i protagonisti di Babel’ sono i soldati russi che, come lo stesso autore, combatterono la guerra sovietico-polacca del 1920, e quelli di Johnson degli sfaccendati tossici e alcolizzati, entrambi i gruppi sono imbevuti della stessa sostanza spirituale, una bellezza sporca, priva di sentimentalismo, accecante. Pavel Novickij nel 1928 scriveva che “Babel´ percepisce la natura e la vita come un pittore. In lui c’è un colorito fulgente e una vivida luce, piena di splendore e di fuoco. Tra i prosatori non c’è un maestro pari a lui per vividezza pittorica delle tinte”. Novant’anni dopo possiamo sostituire Johnson a Babel’ e non perdere un grammo di verità.