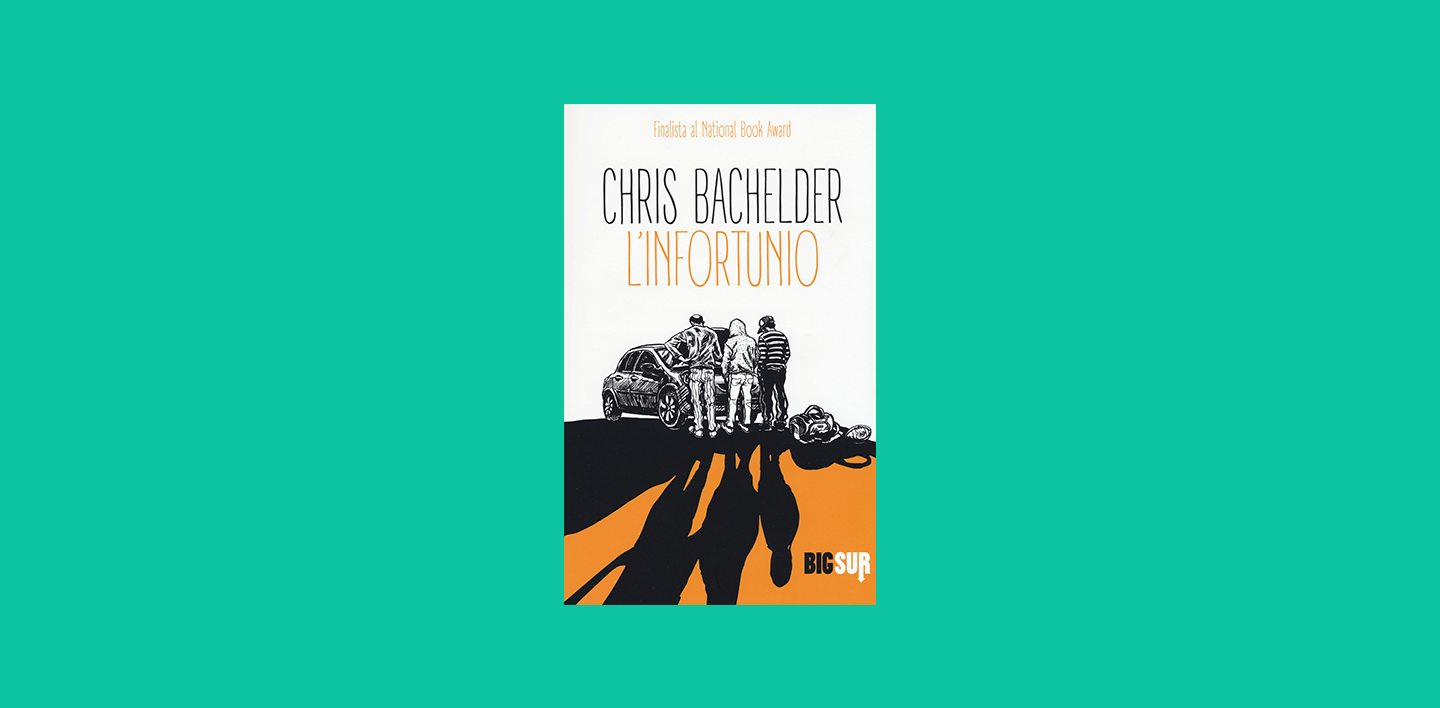
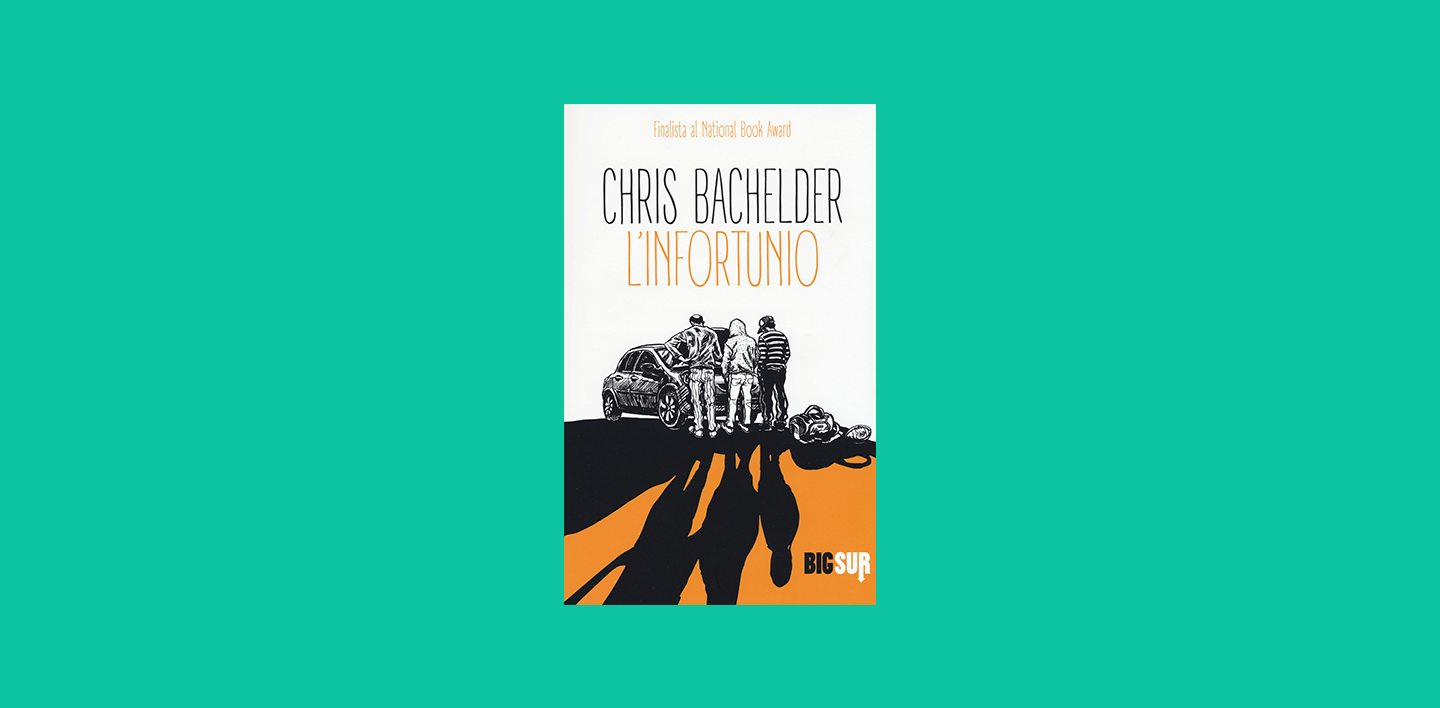
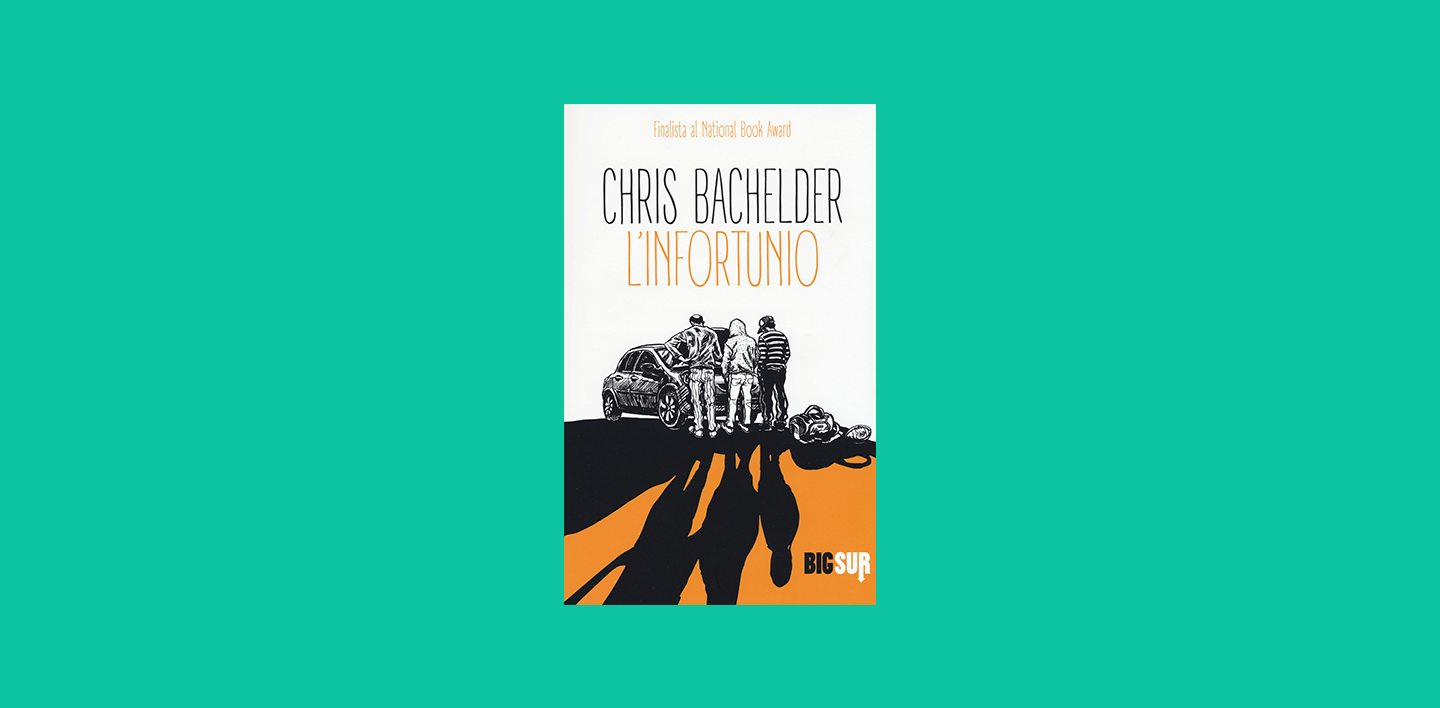
N el 1985, nel corso di una partita contro i Giants, il quarterback dei Redskins– Joe Theismann, un giocatore ritenuto straordinario – rimane coinvolto in un incidente violentissimo che comporta la fine della sua carriera. L’evento segna la storia del football americano e quella, privata, delle centinaia di migliaia di ragazzini che l’hanno visto: shockati da quella prima rappresentazione della violenza in diretta TV, sbigottiti dal primo contatto con l’idea che le cose possono andare storte – in modo imprevisto e irreparabile – anche all’eroe.
Trent’anni dopo, ventidue uomini si ritrovano ogni anno per un weekend in un motel di periferia per rimettere in scena – gesto per gesto, secondo un apparato di regole che non lascia nulla al caso – i cinque secondi di quella scena. Non sono amici, non si sentono realmente nel resto dell’anno. Ma sono uniti dal ricordo dell’infortunio di Theismann come momento cruciale della loro infanzia o prima adolescenza, e dalla consapevolezza – o dall’oscura speranza – che rievocandolo potranno dargli un senso: a quell’evento, e a tutto il tempo che, per ognuno di loro, è passato. Questa è la trama de L’infortunio, di Chris Bachelder, un romanzo breve, e triste e divertentissimo, appena pubblicato da SUR nella traduzione certosina di Damiano Abeni.
Nel frattempo erano arrivati anche altri. Tommy, Carl, Gil, Myron, Gary, Chad. Carl, in flagrante violazione di una regola non scritta ma accettata come ovvia dal gruppo, sbucò dal suo pick-up a doppia cabina con indosso la maglia da gioco dell’anno prima, quella di Jim Burt, il centrale della linea difensiva dei Giants. Come sempre, Gary si mise a girare lentamente per tutto il parcheggio, suonando il clacson come un matto e urlando frasi minacciose e improperi con l’obiettivo di cementare la comitiva. Un gruppetto s’allontanò a gambe levate dall’auto di Gary, e scavalcando due cordoli si diresse alla berlina verde di Derek. Dopo aver parcheggiato, Derek aveva alzato il cofano dell’auto ed era rimasto piegato ad angolo retto a guardarci dentro. Andy, seduto lontano nella sua auto con il motore ancora acceso, vide che gli amici convergevano verso il cofano alzato di Derek. Gli uomini si disposero tutt’attorno al motore, afferrando il bordo dell’auto, come zelanti spettatori intorno a un tavolo su cui si gioca a dadi. C’era giusto giusto lo spazio necessario perché tutti si schierassero al capezzale del motore caldo, e probabilmente guasto. I borsoni erano appoggiati a terra, ai loro piedi. Andy, che forse se ne stava nascosto, o forse no, nella macchina con il motore acceso, azionò il tergicristalli per poterli osservare. Guardavano tutti in basso, tutti annuivano. Oh, pistoni, oh, manicotti! Derek era di razza mista, il che vale a dire che era nero. Era l’unico nero del gruppo, anche se Andy aveva notato che la pelle di Derek era di un paio di tonalità più chiara di quella di Gil, che veniva dalla Florida. Il richiamo dell’annuale frequentazione interrazziale era tanto potente che Derek aveva quasi sempre attorno a sé un grappolo di uomini, anche con un gran brutto tempo. E stavolta c’era perfino il cofano alzato della macchina del nero che creava un’incredibile forza sinergica, il sogno del multiculturalismo fuso con il sogno dell’expertise automobilistica.
L’infortunio segue, in modo lineare, la storia di uno di questi weekend, che dopo quasi vent’anni di ripetizioni in molti sentono come forse l’ultimo. Gli uomini arrivano, si organizzano, si ubriacano; ripetono le tradizioni consolidatesi lungo gli anni (la sigaretta prima di dormire, la colazione insieme, le sbronze, il taglio di capelli); si scambiano vaghi aggiornamenti sulle loro vite – che a questo punto consistono in larga misura di divorzi e fallimenti commerciali e rigonfiamenti sospetti sottopelle; si distribuiscono i ruoli della rievocazione; e la eseguono, di notte, in cinque secondi che sono la ragion d’essere di quelle quarantott’ore e che si svolgono esattamente come tutti se lo aspettano.
Ovviamente c’è qualcosa di assurdo in una tradizione di questo genere. Ma i protagonisti ne sembrano vagamente consapevoli, e imbarazzati; non ne parlano volentieri, e il paragone con i fissati delle rievocazioni della guerra civile li mette a disagio. Non sono neanche tifosi sfegatati. In realtà – nonostante tutto il parlare di linebacker e flea flicker e caschi regolamentari – la rievocazione di quei cinque secondi di football sembra avere, per loro, relativamente poco a che fare col football. Ma allora perché lo fanno? Non viene mai detto chiaramente, né, in realtà, viene chiesto; ma la comprensione del senso profondo di questa tradizione apparentemente insensata – forse come ogni tradizione – è probabilmente l’argomento di fondo del romanzo.
Perché ventidue persone ogni domenica inseguono un pallone, o prendono a racchettate una palletta gialla, o sfrecciano giù dalle montagne con delle plance di plastica legate ai piedi? Perché ci si chiude in una cattedrale, o ci si orienta verso la Mecca, o si attraversa l’Italia in treno per il pranzo di Natale o Ferragosto? Ci sono ottime risposte a queste domande – divertimento, tradizione, affetti – eppure sembrano tutte in una qualche misura insufficienti. L’infortunio parla di questa misura.
L’infortunio è anche un romanzo che parla di uomini. I protagonisti, tantissimi, sono tutti maschi. Nel corso del weekend, il lettore riceve qualche lampo di introspezione sulle loro vite. Quello che ha chiuso il negozio e si vergogna a dirlo. Quello che ha una teoria sul matrimonio, formulata dopo il divorzio. Quello che ha paura che il figlio sia gay. Quello che è un avvocato di successo e pensa a quanto ciò sia inutile di fronte ai piccoli soprusi quotidiani. Quello muscolosissimo che soffre di essere chiamato, ironicamente, “panzone”. Quello che parla troppo. Quello triste. Attraverso i loro piccoli dialoghi, vedendoli negoziare con le dinamiche di gruppo e le microscopiche difficoltà logistiche di un weekend insieme, il romanzo mette in scena un canto corale su cosa significa essere un maschio adulto: il membro di un gruppo dominante che sente sfuggire di mano il proprio dominio; il rappresentante simbolico della potenza fisica colto nel momento della vita in cui la potenza comincia a venir meno. Hanno tutti quaranta, quarantacinque anni.
Quando Robert aiutava la moglie a preparare una cena coi fiocchi, inevitabilmente si metteva a pensare a tutti i piatti che avrebbero dovuto lavare dopo. Quando d’estate caricava la macchina per portare la famiglia al mare in vacanza, pensava a che palla tremenda sarebbe stato scaricare tutta quella roba una volta rientrati la settimana seguente. Anche se la vacanza di famiglia era “divertente” – e spesso conteneva, in effetti, momenti piacevoli per Robert – sarebbe presto finita. Mentre accadeva stava finendo. Non appena la vacanza cominciava, già si stava consumando. Come si fa a godersi una cosa che, per via del fatto stesso di essere cominciata, ha anche dato inizio alla propria fine? Come si fa, ad esempio, ad addobbare un albero di Natale? (Tutte quelle fragili decorazioni avvolte in carta velina…) Di fatto non esisteva nessun inizio, e neanche il mezzo. Tutto era fine.
L’infortunio è un romanzo “sperimentale”, nel senso che contraddice sistematicamente le regole che abbiamo imparato ad aspettarci da una storia: arco del personaggio, investimento emotivo, sorpresa finale. Nel farlo, mostra quanto siano strette e sterili queste aspettative.
Ne L’infortunio non c’è un vero protagonista: i ventidue uomini entrano ed escono di scena a intermittenza, con le loro psicologie e lotte personali, con le loro vite che aspettano in pausa la fine di quel weekend. Non seguiamo la traiettoria di uno in particolare – anzi, fatichiamo a ricordarceli tutti – ma Bachelder sembra dire che non è necessario: più che le loro individualità, lì, conta ciò che li accomuna. I dettagli individuali delle loro vite (la figlia anoressica, il lavoro in biblioteca) contano non tanto per ciò che dicono di ognuno di loro, ma per come si proiettano sull’esperienza di ognuno, dimostrandoli simili proprio nelle differenze specifiche: accomunati.
Non solo: da un certo punto di vista, L’infortunio non ha, propriamente parlando, una trama. Sin dall’inizio il romanzo promette in modo molto chiaro cosa dovrà succedere – nel weekend, come nei cinque secondi di rievocazione. Questa promessa viene mantenuta. In questo senso, il weekend narrato da L’infortunio è il contrario di una storia: è un arco narrativo il cui successo dipende non dal saper provocare delle sorprese, ma dalla loro assenza. È un tempo perfettamente controllato. L’unico tempo simile è il tempo delle tradizioni, delle messe. (Ovviamente, è anche il contrario della vita “normale”. Anche in questo è simile al tempo delle messe.)
Nella ripetizione, le piccole differenze fra un anno e l’altro diventano significative e degne di nota. La convezione di assegnare i ruoli in una precisa sala convegni è arbitraria, priva di senso; ma una volta stabilita, l’anno in cui salta perché la sala è già prenotata diventa particolarmente significativo e memorabile per la sua assenza. Allo stesso modo, il mio tifare la Roma o la Reggina è in fondo arbitrario (vaghe storie di famiglia, o di traslochi); ma sulla base di questa arbitrarietà posso costruire amicizie e fratellanze, rivalità e passioni profonde e sensate, che a posteriori la negano. Parlando di queste cose, L’infortunio parla di come troviamo un senso nelle cose, nelle scelte, nel tempo che passa. Lo facciamo in larga misura tramite i riti.
L’anno che Jeff si portò la fidanzata; l’anno che nessuno portò una palla da football; l’anno che Trent dormì nella hall; l’anno dell’influenza; l’anno dell’intossicazione alimentare; l’anno che avevano appena ridipinto la sala conferenze; l’anno che George fece Theismann; l’anno che George fece il commissario; l’anno che George fece Taylor; il 2001; l’anno che Myron si dimenticò di prenotare le stanze; l’anno che Vince prese la scossa con il tostapane; l’anno che i linebacker rimasero chiusi sul tetto; il primissimo anno; l’anno che i fumatori trovarono una grossa scatola di petardi vicino al cassonetto; l’anno che a Wesley cadde l’orologio nella fontana; l’anno che Steven si sbronzò di brutto e rubò una scala a pioli; l’anno che Tommy scomparve per un sacco di tempo; l’anno delle hostess; l’anno che Adam telefonò a Gil nel cuore della notte, fingendo di essere Theismann in persona; l’anno della neve; l’anno del fulmine; l’anno che Charles andò fuori di testa; l’anno che Michael Panzone perse la fede nuziale; l’anno che Randy si ruppe il polso; l’anno che Nate si lussò il gomito; l’anno del parrucchino di Michael Pelato; l’anno degli atti di vandalismo contro l’Urna Fru Fru; l’anno degli atti di vandalismo contro l’auto di Derek; l’anno che quel tipo, Danny, dovette fare da tappabuchi e non fece altro che cercare di vendere candele profumate, scolpite, ecc.; l’anno che sarebbe dovuto venire un giornalista; l’anno che venne la polizia e arrestò il portiere di notte; l’anno della gara delle ali di pollo piccanti; l’anno che Robert non arrivò per primo; l’anno che Carl fece cadere la palla prima ancora di metterla in gioco; l’anno che all’hotel finì la colazione; l’anno che all’hotel finì l’acqua calda; l’anno che la moglie di Nate ebbe le doglie; l’anno dei bebé; l’anno in cui Gary fece il suo grande annuncio; l’anno dei modellini d’auto che andavano a diossido di carbonio.
Per varie ragioni biografiche non ho mai imparato la grammatica dello sport televisivo. Non riesco a seguire la drammaturgia di una partita di calcio, mi perdo nella sintassi di una tappa del MotoGP; queste metafore linguistiche sono un modo raffinato di dire che lo sport in TV mi annoia, quindi non lo guardo. Ma passata qualche breve stagione di fiero secchionismo da scuole medie, non sono mai andato fiero di questa cecità selettiva. Era la causa dell’esclusione da un rito che sembrava legare tutti i miei coetanei, e più in generale i maschi, della mia cultura. Da ragazzo invidiavo la capacità dei miei compagni di unirsi ogni domenica per assistere insieme a quella celebrazione a distanza, litigando o affratellandosi in base a circostanze che mi sembravano arbitrarie. Rimpiangevo di non avere accesso a quel canale universale di intimità maschile, per cui fra due sconosciuti bastano tre frasi sullo scudetto per creare un arco di intesa che travalica la classe e l’origine geografica.
Leggendo L’infortunio mi sono reso conto, per la prima volta, che la mancanza più profonda era forse un’altra: il senso di una scansione ritmica nel mio tempo. Le partite settimanali di campionato; le ricorrenze biennali di mondiali ed europei: la doppia struttura di ripetizione e variazione è ciò che permette di dare un sapore al tempo, e quindi un senso. La variazione e la fissità costruiscono una griglia a cui attagliare le proprie esperienze personali, collocandole in una scansione lineare narrativa, una storia. Nella misura in cui questa griglia è condivisa da una comunità (i tifosi di cui parla Bachelder, ad esempio), questa storia sarà al contempo personale e collettiva, e cioè sarà il punto di contatto fra un individuo e il suo mondo.
L’infortunio parla di questo. È un romanzo che tratta lo sport non in quanto attività fisica competitiva, né in quanto allegoria della strategia bellica, né in quanto arte: tratta lo sport in quanto rito collettivo, che unisce le comunità e offre un posto agli individui al loro interno. Quindi, in realtà, è un romanzo che parla di religione, e cioè di senso del sacro, e cioè, volendo usare un’espressione un po’ pacchiana, è un romanzo che parla del senso della vita. Secondo Bachelder, una buona immagine per il senso della vita è offerta da ventidue americani di mezza età, con indosso divise da football sbrindellate e troppo strette, che si ubriacano in un motel sulla tangenziale. Dopo aver letto L’infortunio è molto difficile non dargli ragione.