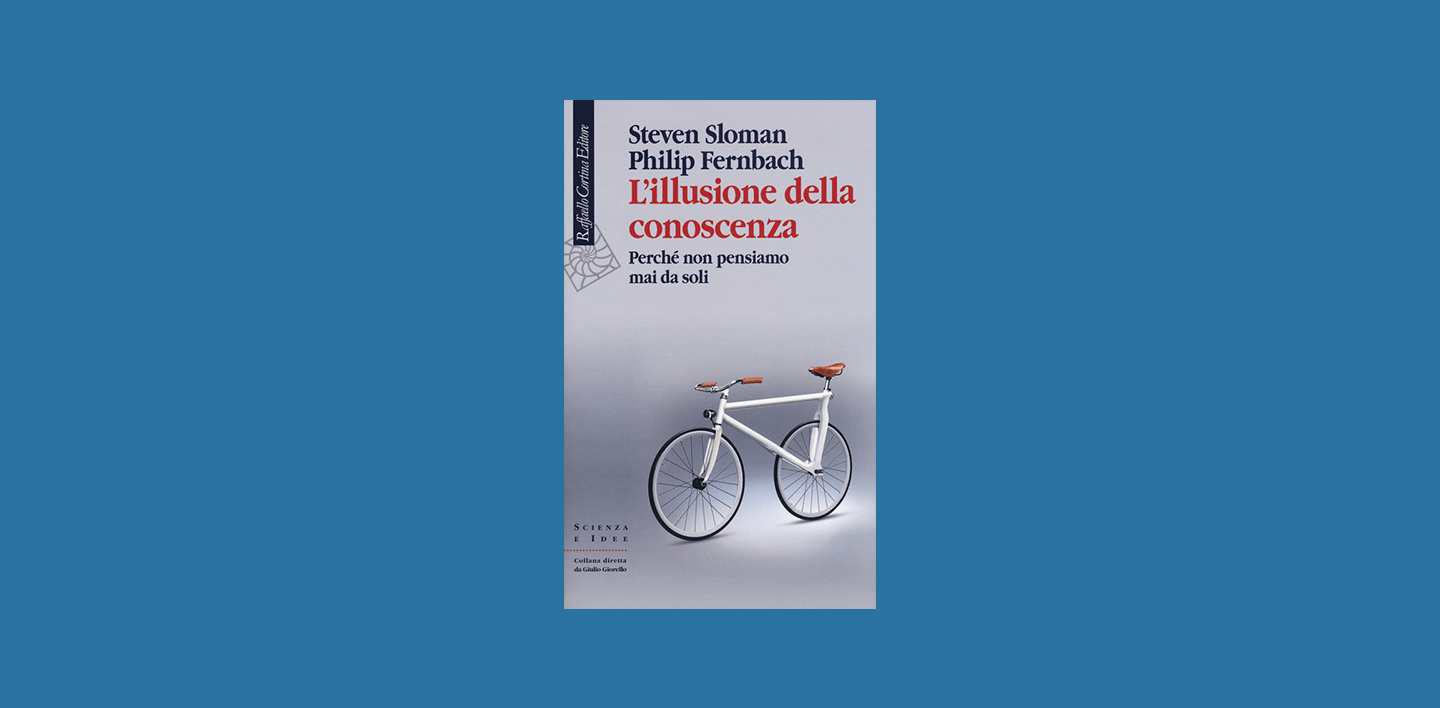A
lla base della cultura che l’umanità ha costruito e accumulato nel corso della sua lunga storia ci sono, secondo Steven Sloman e Philip Fernbach – due psicologi cognitivi americani –, almeno due caratteristiche basilari del comportamento dell’uomo: la collaborazione e una capacità di schematizzazione che assomiglia molto all’intuito. Per quanto riguarda la prima, un esempio piuttosto classico è l’aver mandato l’uomo sulla Luna. Nessun essere umano da solo potrebbe mai aver posseduto tutte le conoscenze necessarie all’impresa (anche ipotizzando di trovarsi una situazione in cui le risorse economiche non fossero un limite): troppe le diverse conoscenze specializzate necessarie, troppe le informazioni da maneggiare. Le missioni Apollo sono state possibili grazie alla collaborazione di una enorme quantità di persone che hanno perseguito un obiettivo comune. Probabilmente, argomentano gli autori, in modo analogo a come è andata nella preistoria, quando i nostri antenati erano cacciatori-raccoglitori e si sono resi conto che lavorando in gruppo potevano cacciare prede molto più grandi e pericolose di quanto non potessero fare da soli. C’è una condivisione del rischio, che ne abbassa la soglia individuale, ma c’è anche l’emersione di un metodo che non prevede il pensiero superiore. Ancora oggi, infatti, possiamo vedere animali predatori che in gruppo circondano la preda tagliandole le vie di fuga, proprio come è ipotizzabile abbiano fatto i nostri antenati.
L’altro aspetto, quello che abbiamo indicato approssimativamente come intuito, è anch’esso parte della spiegazione della nostra illusione di conoscenza. Quante volte ci capita che di fronte a un problema complesso, pensiamo a quelli di cui si dovrebbe occupare la politica, sbottiamo pensando che la soluzione sia evidente, semplicissima e facilmente individuabile ma che siano altri fattori a frenare l’applicazione di ciò che ci appare ovvio. Se proviamo, però, a calare questo tipo di esempio in un contesto più vicino a noi, per esempio un problema sul lavoro, quando il collega o la collega ce lo espogono abbiamo talvolta la netta sensazione che la soluzione sia evidente e chiara. Quando però andiamo ad analizzarne i dettagli ci rendiamo quasi sempre conto che non è così banale come ci appariva quando abbiamo intuito, più che capito, quale strada potevamo intraprendere per arrivare a un risoluzione del problema. Ci spiegano Sloman e Fernbach che questo avviene perché nella nostra vita quotidiana la schematizzazione e la semplificazione ci aiutano a prendere decisioni rapide. In moltissimi casi questo modo di ragionare e, di conseguenza, agire è utile a risolvere le situazione senza bloccarci a pensare troppo quando non è necessario. Questa caratteristica della nostra mente è alla base di un esperimento mentale in cui possiamo prendere come protagonista un comunissimo water.
Se ci chiedessero a bruciapelo di spiegare il funzionamento di un oggetto che usiamo tutti i giorni, infatti, saremmo in grado di fornirne una descrizione accurata? Certo sarebbe difficile per chiunque spiegare come funzioni lo smartphone che portiamo sempre con noi, tranne forse per chi lavora nel settore della progettazione di elettronica di consumo. Ma se la richiesta fosse di spiegare com’è fatto lo sciacquone del water probabilmente risponderemmo che sì, ne comprendiamo il funzionamento e sappiamo che ogni volta che premiamo il pulsante un flusso di acqua pulita si porta via nello scarico tutto quello che deve finire nella fogna. Per rispondere alla richiesta, probabilmente abbiamo visualizzato il water del nostro bagno di casa e il gesto che compiamo ogni giorno senza pensarci.
Siamo però davvero così convinti di sapere davvero quali meccanismi si nascondano sotto allo sciacquone? Siamo davvero in grado di spiegare la struttura a sifone dello scarico, il principio dei vasi comunicanti che determina il fatto che l’acqua defluisca nel verso desiderato, o come agisca il meccanismo a galleggiante (o simile) che ferma il riempimento della vaschetta di deposito dell’acqua pulita che useremo la prossima volta che premeremo il pulsante? Se mentre riflettiamo su questi dettagli siamo onesti con noi stessi, e a meno che non abbiamo studiato ingegneria o fisica all’università, probabilmente non siamo in grado di dare una spiegazione completa che sia, diciamo, in grado di reggere il confronto con quella di un esperto o di un libro di testo. Ma di primo acchito abbiamo pensato di saperlo. È questo l’esempio che Sloman e Fernbach hanno deciso di utilizzare per introdurre il lettore al fenomeno che loro chiamano “illusione della conoscenza”, quello per cui pensiamo di sapere molto di più di quanto, alla prova dei fatti, in realtà sappiamo. Il primo è docente alla Brown University e si occupa di capire come funziona il ragionamento causale; il secondo insegna alla Leeds School of Business della University of Colorado a Boulder, dove si occupa di marketing. Il loro libro si basa su studi sperimentali e su di un vastissimo corredo bibliografico che va da Descartes agli ultimi lavoro di psicologia cognitiva.
Se l’illusione di conoscere più di quanto in realtà non conosciamo è insita nella struttura della nostra mente e del nostro modo di ragionare, cosa si può fare per rompere il cristallo dell’illusione?
L’illusione della conoscenza non è la conseguenza di arroganza o saccenza ma, come scrivono gli autori del libro, di un meccanismo che si è venuto a costruire nella mente dell’uomo durante la sua lunga storia sulla Terra. Da un lato, infatti, abbiamo fiducia nella conoscenza che, per così dire, è immagazzinata nella mente di coloro che hanno progettato il water e di coloro che lo hanno installato a casa nostra. Si tratta di una constatazione non nuova, secondo la quale nel corso dei secoli la conoscenza che abbiamo accumulato è cresciuta in quantità, al punto che non è possibile che sia contenuta in una sola mente. Ne sono prova le estensioni della nostra memoria che usiamo per immagazzinare informazioni, come per esempio i libri e, oggi, la Rete. La conseguenza di questo stato di cose è che se si rompe lo sciacquone, così come la lavatrice o il forno di casa, non siamo quasi mai in grado di ripararli, ma siamo in grado di accedere a chi quella conoscenza la possiede, costruendo relazioni con altre persone, con “magazzini della conoscenza”, e avere la necessaria flessibilità per mettere tutto ciò in relazione con il caso specifico. È una concezione distribuita dalle conoscenza che, almeno in parte, dà spiegazione del sottotitolo del libro, “perché non pensiamo mai da soli”, ma che nella visione di Sloman e Fernbach va un po’ oltre all’idea “siamo come nani sulle spalle dei giganti” che tanto ha tenuto banco nella querelle des anciens et des modernes a partire dal XVI secolo.
La flessibilità è al centro anche del capitolo che i due psicologi dedicano al “pensare la tecnologia”, uno dei capitoli più interessanti del libro se messo in prospettiva con il dibattito sulle intelligenze artificiali di questo periodo. Infatti, secondo alcuni, come per esempio Bill Gates e Stephen Hawkings, il rischio che le macchine possano sviluppare una capacità di pensiero che permetta loro di sostituirsi a noi è un pericolo concreto nei confronti del quale bisogna prendere delle decisioni il prima possibile. Secondo Nick Bostrom la superintelligenza o singolarità tecnologica è dietro l’angolo e rischia di mettere a repentaglio le posizioni degli esseri umani. Sloman e Fernbach, su questo aspetto, sono più ottimisti: la loro posizione è che le tecnologie e le macchine non sono in grado di esprimere intenzionalità. Lo raccontano a proposito del funzionamento del GPS: ci sa indicare la strada più veloce per andare da un punto a un altro, ma non può decidere di passare dal lungomare per vedere il tramonto o suggerire una deviazione che allunghi la strada quando non vogliamo vedere nostra suocera.
Oppure, per usare un esempio che dia pieno merito alla flessibilità dell’uomo, quando tutti i sistemi elettronici che fanno funzionare una nave da crociera dovessero andare in tilt, il capitano della nave, a differenza delle macchine, conserverebbe quelle capacità di dare priorità a questa azione o a quella manovra in base a un obiettivo (salvare più vite, fare meno danni, ecc.): semplificando, il vero pericolo della tecnologia secondo gli autori è che le affidiamo troppi compiti senza conservare la nostra capacità di governarla. Se ne perderemo il controllo è perché avremo schematizzato troppo, avremo fatto eccessivo affidamento sulle conoscenze immagazzinate e non avremo previsto tutti gli scenari possibili. Ancora una volta, ci saremo illusi di sapere.
In generale, se l’illusione di conoscere più di quanto in realtà non conosciamo è insita nella struttura della nostra mente e del nostro modo di ragionare, cosa si può fare per rompere il cristallo dell’illusione? Di primo acchito diremmo che sia sufficiente essere consapevoli di questo stato di cose per evitare il problema. In realtà, anche dovessimo riuscire a farlo individualmente, non possiamo dare per scontato di riuscire a farlo collettivamente: come società prendiamo decisioni collettivamente e sembra irrealistico cercare di convincere larghi strati della popolazione mondiale di essere più ignorante di quello che crede. Intanto, grazie alla collaborazione degli esseri umani, la società diventa sempre più complessa, aumentando il rischio dell’illusione, apparentemente come un veicolo guidato da un pilota cieco. Dove andrà a finire è proprio una di quelle cose che ci illudiamo di sapere, ma in realtà non sappiamo.