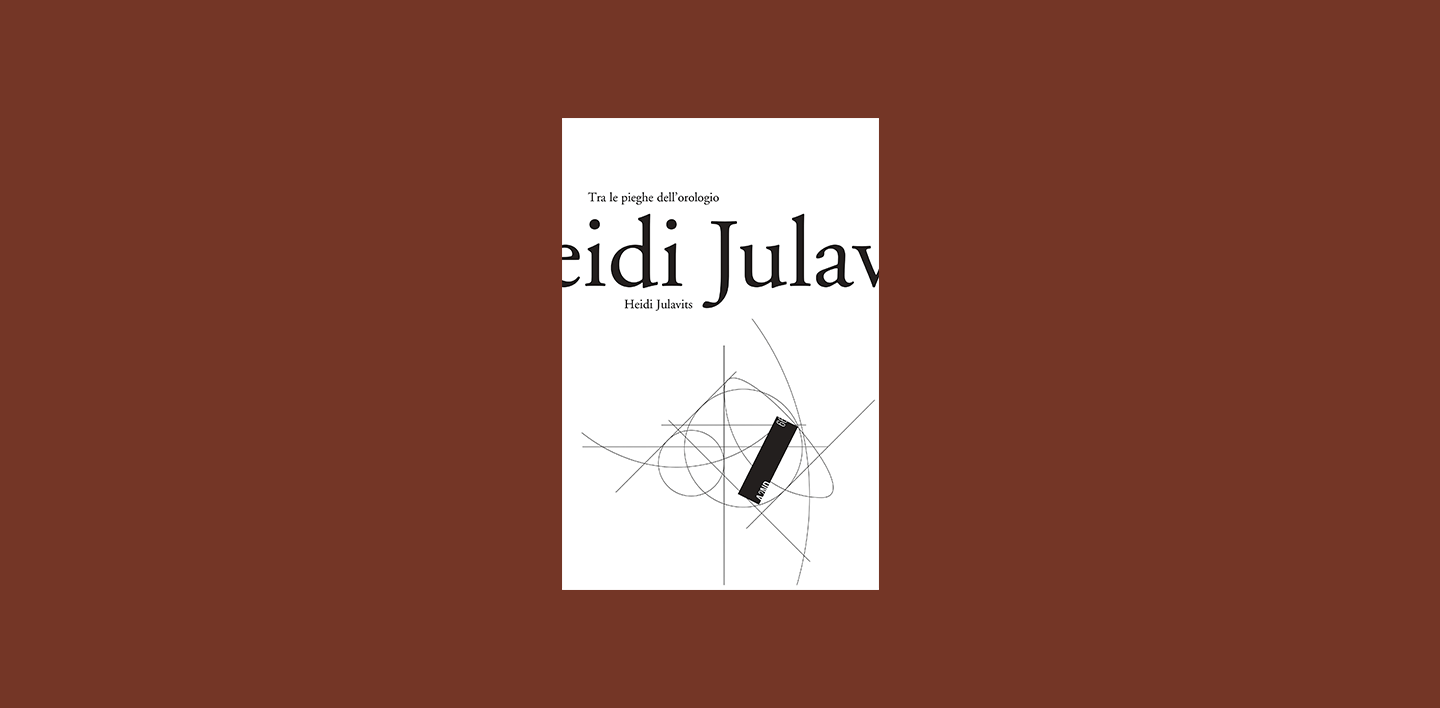
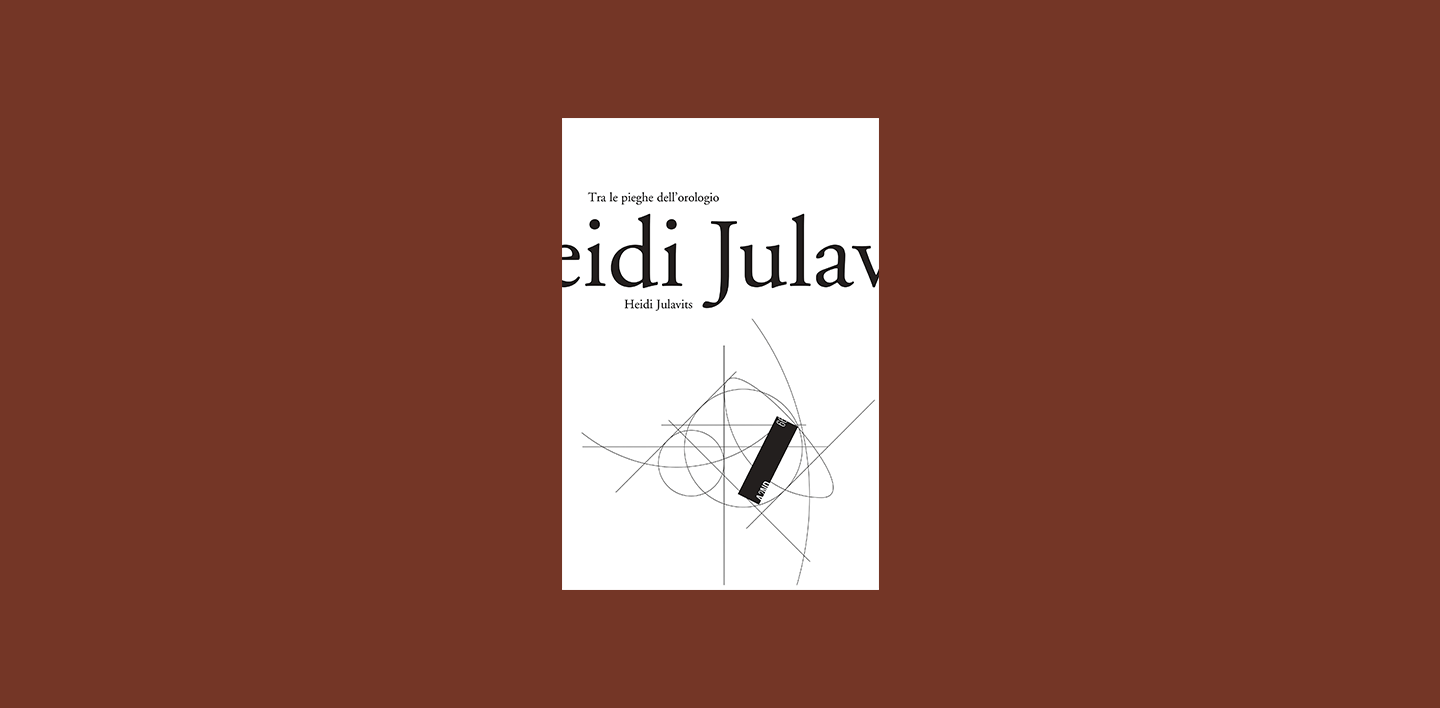
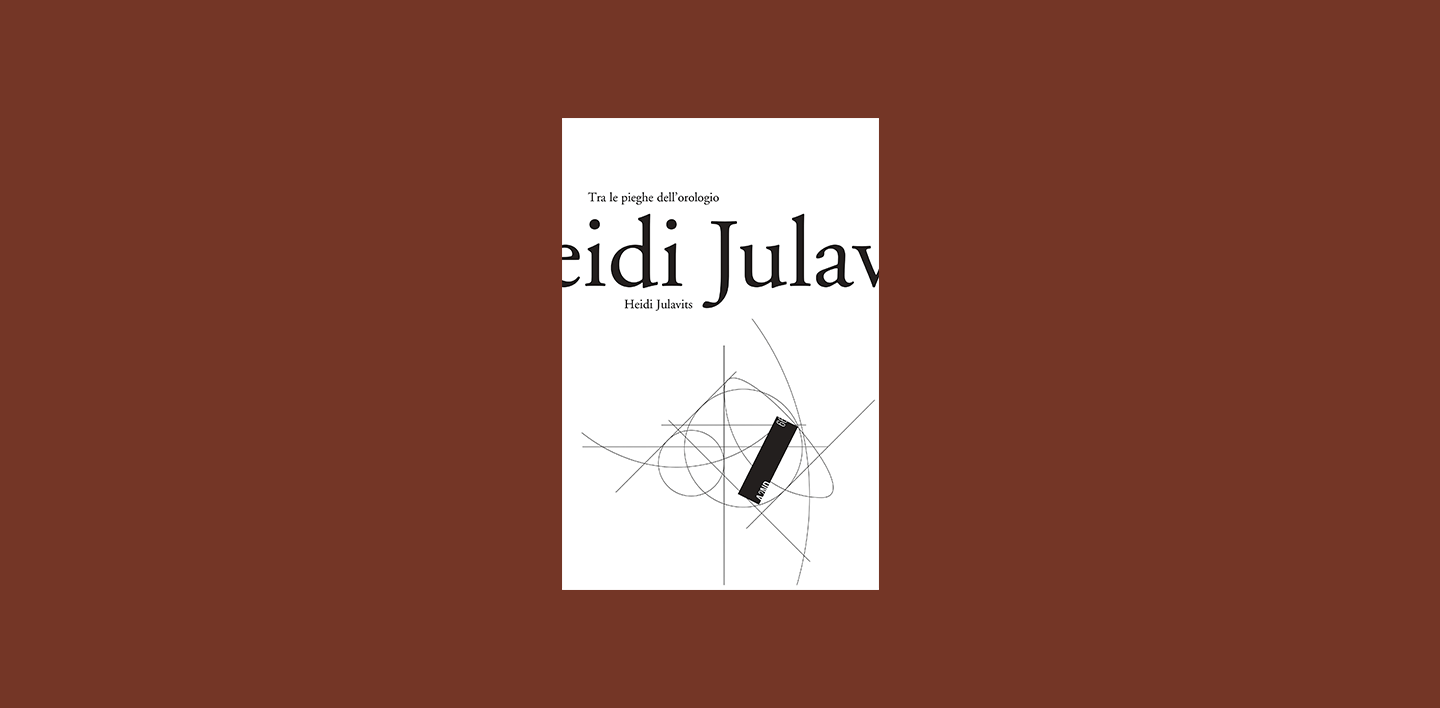
“M io fratello, per metà nel cappotto, è crollato. Non so se l’ho mai visto piangere negli ultimi trentacinque anni. Forse è la durezza dei tempi a renderci così tristi per compleanni persi e alberi morti. Tra qualche giorno ci saranno le elezioni e sono tutti tesi. La nostra città è scampata alla distruzione, ma per quanto ancora possiamo fuggire? Se non la rade al suolo un altro uragano, allora lo farà un attentato terroristico. L’impassibilità improvvisa di quel quartiere del centro ha associato nelle nostre teste gli attacchi umani a quelli meteorologici, passati e potenziali. Credo che stiamo tutti pensando: qui abbiamo i giorni contati. Le vecchie signore camminano per le strade facendo i loro proclami ottimisti-pessimisti. La città sta crollando.”
Quando a Miranda July è stato chiesto di leggere un racconto per il New Yorker Fiction Podcast, la scrittrice americana ha scelto “Prizes” di Janet Frame. Come molti, anche Miranda July aveva scoperto Frame attraverso Un angelo alla mia tavola, il film di Jane Campion sull’autrice neozelandese che attraverso la scrittura era riuscita a dar giustizia a una vita difficile, fatta di diagnosi sbagliate, ricoveri ed elettroshock. Questo film, raccontava July, era stato talmente fondamentale per la sua formazione che aveva insistito per mesi col marito perché lo guardasse; doveva considerarlo un modo per conoscerla meglio, o qualcosa del genere.
Quando finalmente aveva accettato, aveva commentato: “pensi che questa storia sia la tua, che anche per te la posta in gioco è alta, che anche tu hai dovuto attraversare l’inferno per poter scrivere le tue storie”. Quel commento doveva aver fatto più impressione a me che a lei che lo aveva accolto ridendo: d’altronde non era quello che chiunque doveva fare, sentire cioè, scrivendo, che in palio c’era la propria salvezza? A me pareva che dicesse questo: che stava usando quel film per avere conferma dell’importanza del suo lavoro, che si era riflessa nella vita di un altro per rileggere la sua. Scrivere poteva sì essere questione di vita o di morte, ma forse non era questo il caso.
Questa conversazione mi era tornata in mente mentre leggevo Tra le pieghe dell’orologio, il libro di Heidi Julavits che 66th2nd ha portato in Italia (traduzione di Gabriella Tonoli): le parole del marito di Miranda July mi parevano risuonare nella delusione provata dalla scrittrice il giorno in cui aveva riaperto i diari che aveva scritto a otto anni e non aveva trovato quella scrittrice in formazione che pensava di essere stata. Aveva trovato solo una bambina che compilava tutte le entrate del diario iniziando nello stesso modo: “oggi sono andata a scuola. Oggi sono andata a casa di Andrea. Oggi ho giocato al cimitero. Oggi non ho fatto nulla”. Scrive:
Ero convinta che il mio destino fosse la grandezza postuma. Spesso mi immaginavo più famosa da morta che da viva. I diari in sé, tuttavia, non riescono a confermare il mito che avevo architettato per me stessa. Non rivelano la mente di una futura scrittrice, ma di un futuro revisore dei conti paranoico. Non manifestavo alcuna immaginazione né traccia di stile, nessuna arguzia, nessuna personalità.
A portare Heidi Julavits a credere che rileggendo i suoi diari avrebbe avuto la conferma di essere destinata alla scrittura era lo stesso motivo che spingeva Miranda July ad amare Un angelo alla mia tavola: era la ricerca di un mito originario, di una linea sicura che attraversasse il passato fino al presente. Julavits desiderava un segno, un indizio: quando aveva scoperto che questo non c’era, lo aveva creato lei: Tra le pieghe dell’orologio inizia da qui. Scrive
vorrei storie chiare, immagino, se fossi a un passo dalla tomba, ridotta a un nome, una data, qualche virgola, una categoria (“moglie”). Così ho raccontato una storia lineare.
Il titolo italiano è l’impossibile traduzione di The folded clock, la deformazione di una didascalia trovata in un museo, e così folded, ripiegato su se stesso è il racconto delle ore, i mesi e i giorni: Tra le pieghe dell’orologio è il resoconto di due anni di vita di Heidi Julavits, in cui il tempo finisce per venir annullato: se il passato non racconta una storia lineare, allora si è liberi di affrancarsi dalla cronologie, così qui a giugno segue marzo, luglio, novembre e poi di nuovo luglio.
Inizia citando un’installazione di Christian Marclay, The Clock, (già apparsa ne Il mondo a venire di Ben Lerner, da cui prende anche il titolo originale, 10:04), “un film di ventiquattr’ore che costituisce un orologio del tutto funzionale (e visivo). Ogni minuto di una giornata di ventiquattr’ore è rappresentato da una scena di un film preesistente”; seduta nella sala del museo di Los Angeles con un’amica in procinto di partire, “abbiamo passato il poco tempo che ci rimaneva insieme a guardare una rappresentazione visiva del poco tempo che ci rimaneva insieme”, il desiderio di vedere quale film avrebbe ritratto il minuto successivo si scontra con quello che il tempo non passi “perché allora ce ne saremmo dovute andare, e allora avrei dovuto salutarla, e allora non avrei rivisto la mia amica per quella che mi pareva un’eternità, se misurata secondo gli standard temporali a cui eravamo sottoposte su quel divano”. Conclude: il tempo strisciava. Il tempo fluiva.
Heidi Julavits definisce la sua visione del tempo come narrativista, riprendendo una citazione di Julian Barnes, per cui “gli episodicisti vedono e sentono poco legame tra le parti diverse della loro vita, hanno un senso più frammentario della vita (..) i narrativisti sentono e vedono una costante connettività, un sé costante, e riconoscono il libero arbitrio come lo strumento che forgia il loro sé e il loro essere connessi”: è una distinzione morale, precisa Barnes. Eppure è l’impossibilità stessa di leggere il passato come continuo che fa apparire frammentario ed eternamente presente il racconto dei giorni, accomunato solo dallo stesso attacco “oggi ho fatto”, “oggi ho detto”, “oggi sono stata”. Ogni giorno l’attesa di un’epifania definitiva.
Quando scrivo, cerco di raggiungere la testa attraverso il movimento delle mie dita. Provo a costruire una scala di parole fino al cervello. Alla fine quelle parole mi aiutano ad approdare a un’idea, e allora riscrivo, riscrivo e riscrivo ancora quello che ho già scritto (quando non avevo alcuna idea di che cosa stessi scrivendo), finché il percorso del pensiero, a posteriori, sembra immediato. Quello che rimane sulla pagina sembra sprigionato dalla mia testa, sceso lungo le braccia, le dita e la tastiera per confluire poi sullo schermo. Ma non è andata così: non va mai così.
Julavits fruga nelle tasche del tempo e ci trova ricordi, promemoria, indicazioni che hanno perso i referenti: questo è il suo tentativo di riportare il tempo a una dimensione narrativista, di ricucire un’identità. Se anche l’affastellamento delle parole, dei ricordi non pare portare a un’identità fissa e la scrittura è una scala di parole che non concede nessuna pulizia al pensiero, è proprio in questa frizione tra chiarezza e contaminazione che sta la bellezza di questo libro, capace di raccontare una storia, usandone solo i materiali preparatori.
L’indagine che porta avanti Tra le pieghe dell’orologio si muove contemporaneamente in diverse direzioni: la prima è verso il mito originale, quella mappatura dei desideri che è il primo motivo per cui Julavits scrive. Dichiara “voglio volere l’urgenza”:
A volte penso che questa sia la ragione per cui sono diventata una scrittrice. Avevo trovato un modo per esercitare regolarmente il mio desiderio. Potevo desiderare di fare questa attività che nessuno fa perfettamente, e facendola e rifacendola avrei potuto imparare a desiderare di più, e meglio. Ecco un’attività che mi avrebbe sempre lasciato insoddisfatta.
E, ancora, in direzione del futuro e persino all’oblio. Attraversando il ponte di Brooklyn, con sua figlia, ripensa a quando si era messa a rincorrere un ragazzo su una passerella sospesa, sempre più veloce: “oltre la passerella c’era l’aria e poi l’acqua. Se fossimo caduti non ci avrebbe protetto nulla. Le auto scorrevano a meno di un centinaio di centimetri dalle nostre teste”. Nella fretta, lui aveva battuto la testa su una trave bassa ed era caduto a terra, privo di sensi e lei lo aveva soccorso.
Le racconta la storia perché “anche quando mia figlia non mi troverà più interessante, il che succederà presto, non potrà respingermi del tutto; avevo corso sotto i ponti; avevo salvato la vita a un uomo. In mia presenza mi disprezzerà, ma alle sue amiche potrebbe raccontare con orgoglio questa storia, che aveva sentito prima di capire perché gliela stavo raccontando”. E perché quella storia appartiene a un periodo in cui si sentiva slegata, talmente priva di radici a New York da sposare un ragazzo che aveva la sola funzione di ricordarle casa, “al punto che spesso attraversavo il ponte a piedi per appoggiare la fronte sulla pietra degli archi e per toccare la terra da cui ero venuta. Se quelle pietre erano in grado di perdurare in questa città, e mantenere la loro forma, allora avrei potuto farlo anch’io”.
E, dunque, scrive attraverso il tempo, riportando a una forma unica tutte le manifestazioni di sé finite tra le pieghe dell’orologio, con la pazienza un po’ severa di chi conosce la resilienza dell’identità: quando un giorno, fuori dall’università in cui insegna scrittura creativa, vede una ragazza in preda a una crisi di nervi che urla “Fanculo la Columbia University!” e non si ferma a consolarla, ma rientra nel suo ufficio a lavorare:
e se qualcuno si fosse messo a piangere nel mio studio per ragioni non legate – ma forse in qualche modo anche sì – al racconto imperfetto che aveva scritto, gli avrei detto che scrivere storie fa piangere, che comunque le storie che leggi più spesso sono le storie di merda che scrivi e che ti fanno piangere, e avrei anche pensato, “Povero te, non hai idea di che cosa ti aspetta. Ti aspetta una vita, una cazzo di vita seria”. È questo che avrei voluto dire. E poi sarei tornata a casa alla mia cazzo di vita seria, e sarebbe stato tutto così ridicolamente poco serio.