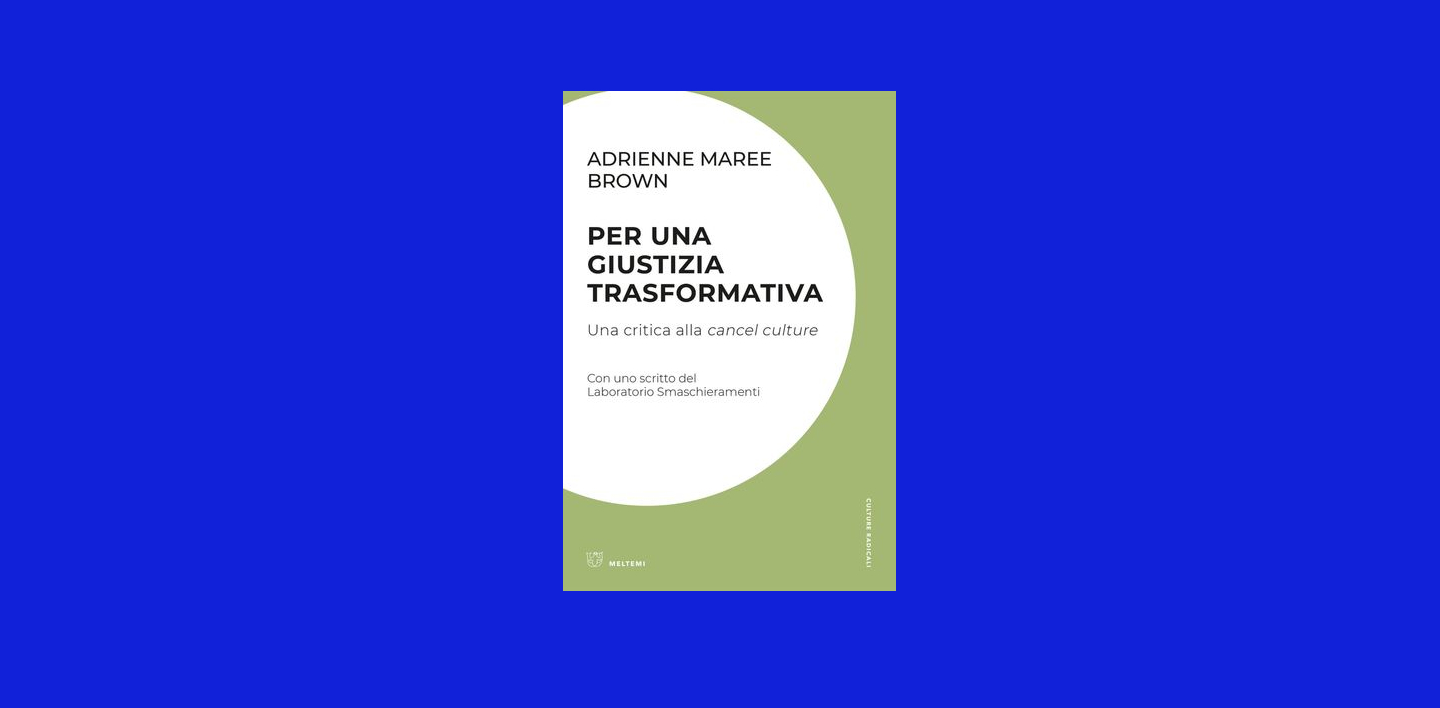
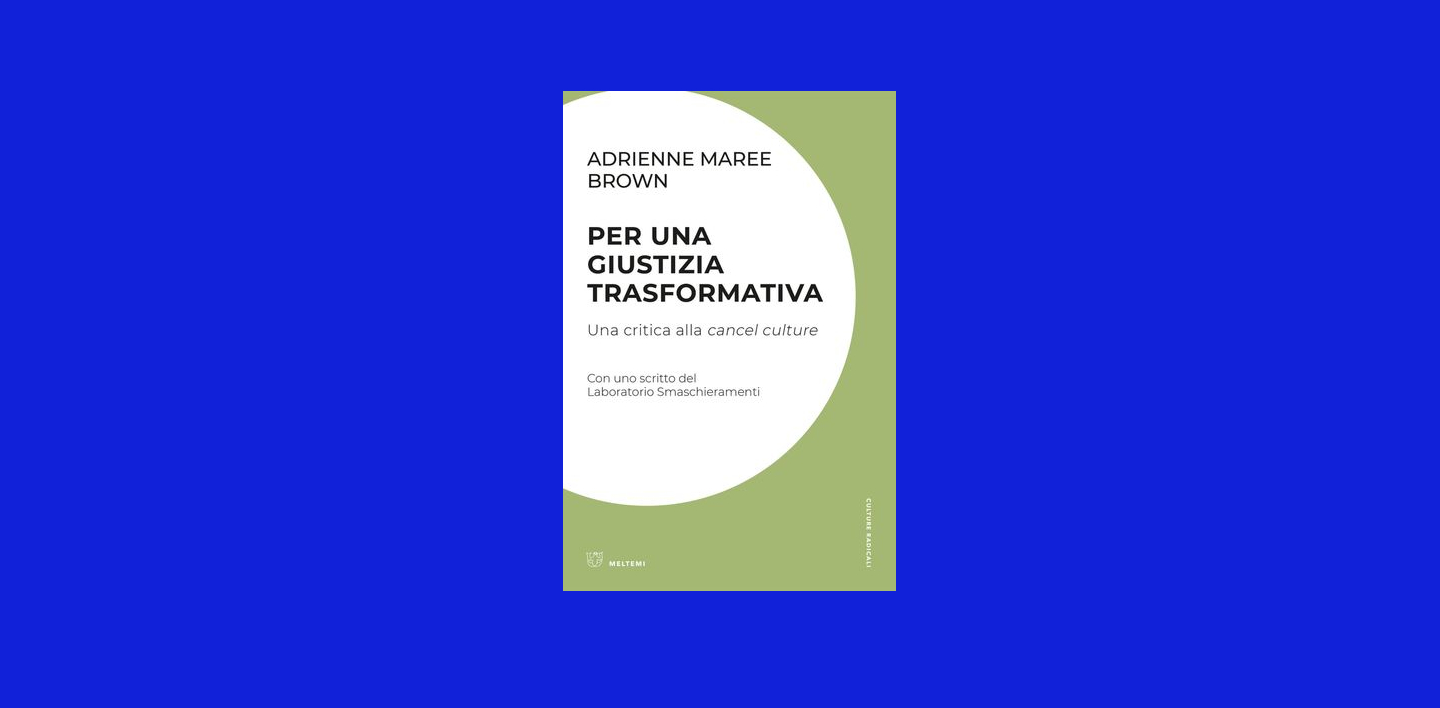
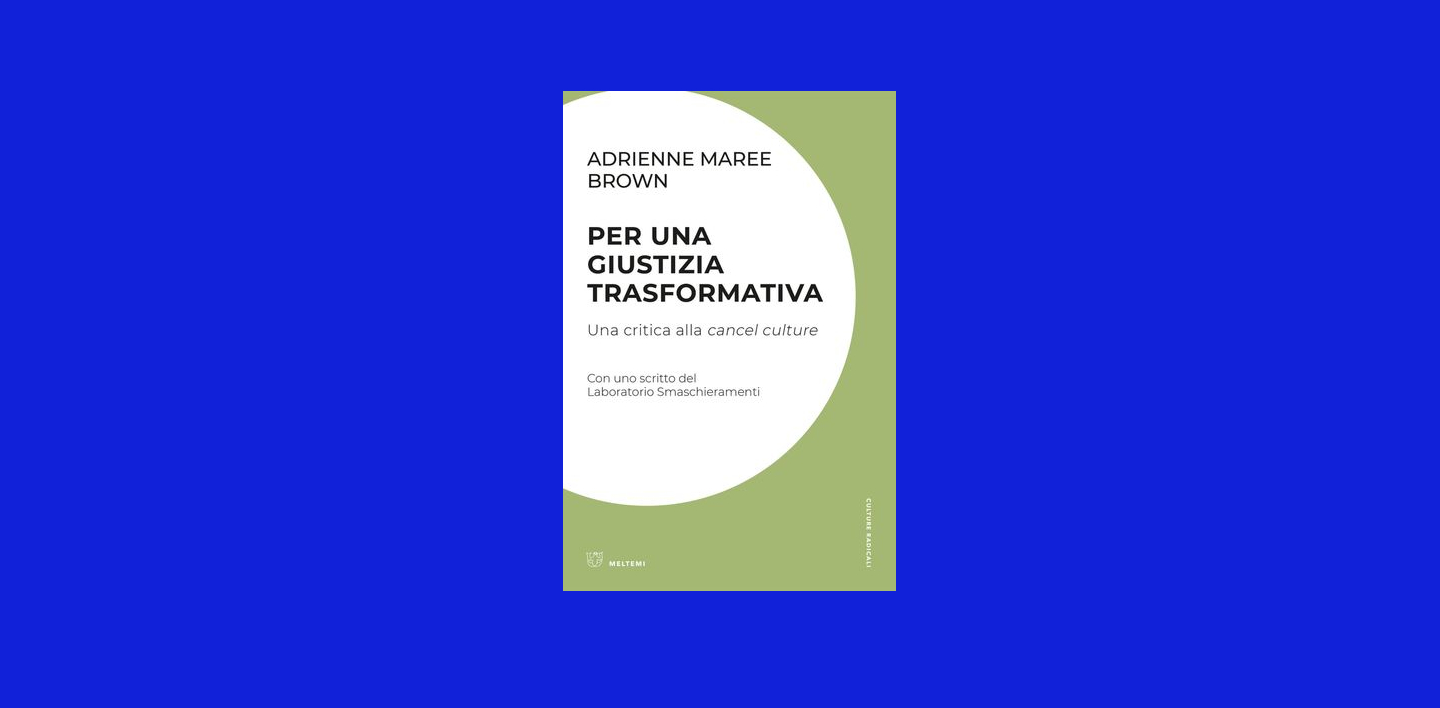
N egli ultimi anni si parla sempre più frequentemente di femminismo anche in Italia, nei giornali, in televisione, negli spazi culturali, ma spesso senza approfondire realmente cosa significhi o quali siano le sue implicazioni concrete. A livello di dibattito pubblico le posizioni che emergono e ricevono maggiore visibilità sembrano essere quasi sempre quelle legate a (presunte) pratiche censorie, che finiscono per appiattire la complessità dei discorsi. I femminismi, così, vengono spesso ridotti a una questione di normazione linguistica o formale, trascurando e oscurando le lotte e le pratiche portate avanti dai movimenti, in particolare quelli più radicali, che rimangono relegati ai margini della narrazione pubblica.
Questa visione semplificata tende a rendere invisibili gli sforzi per affrontare le sfide più profonde e complesse: la pluralità dei posizionamenti politici, le pratiche di cura collettiva, la gestione dei conflitti, sia interni che esterni ai movimenti, e i tentativi di superare il punitivismo come unica forma di giustizia possibile. Spesso si ignora il lavoro collettivo di chi cerca di comprendere e affrontare le questioni difficili, come la gestione dei casi di molestie e violenza all’interno dei movimenti stessi. Perché, sì, nessuna di noi è esente: siamo tutte figlie di un sistema violento, patriarcale e intriso di dinamiche di oppressione.
Nel 2024, all’interno della collana Culture Radicali, curata dal Gruppo Ippolita, è uscito Per una giustizia trasformativa. Una critica alla cancel culture di adrienne maree brown, a cura del collettivo bolognese Dalla Ridda. brown si definisce “facilitatrice, mediatrice, scrittrice, donna nera meticcia, sopravvivente queer, pensatrice visionaria, guaritrice, doula”, e tra il 2022 e il 2023 la casa editrice Nero aveva già pubblicato la traduzione (in due volumi) del suo libro Pleasure Activism. Il volume edito da Meltemi contiene la traduzione italiana del libro We Will Not Cancel Us And Other Dreams of Transformative Justice, pubblicato da AK Press con la postfazione di Malkia Devich Cyril, e un testo del Laboratorio Smaschieramenti. Con questo libro – che è soprattutto una riflessione sulle pratiche politiche collettive ma anche sulla propria pratica di scrittura, in cui l’autrice fornisce anche un glossario-riflessione – brown afferma la sua speranza di creare “un piccolo volume in grado di donarci più opzioni, più pazienza, più gentilezza e spazio per guarire insieme”.
L’espressione cancel culture negli ultimi anni è stata molto presente nel dibattito pubblico – e dal dibattito statunitense è stata calata in quello italiano – e viene usata in sostanza per implicare che certe lotte politiche avrebbero il solo scopo di silenziare o cancellare persone, esperienze, realtà, a favore di un “pensiero unico” che vorrebbe normare tutto ciò che non è politically correct. Il testo di brown dimostra che non è così: le attiviste e i collettivi politici riflettono moltissimo sui call out, ovvero quelle pratiche di accusa pubblica nei confronti di persone che agiscono violenza, o che portano avanti comportamenti, pratiche commerciali e culturali abusanti o tossiche.
I femminismi vengono spesso ridotti a una questione di normazione linguistica o formale, oscurando le lotte portate avanti dai movimenti, in particolare quelli più radicali, che rimangono relegati ai margini della narrazione pubblica.
Questa pratica, tuttavia, soprattutto a partire dal 2020, con l’inizio della pandemia da Covid-19 (anno in cui adrienne maree brown scrive i testi nel volume di cui stiamo parlando), sembra essersi diffusa anche all’interno di contesti politici non istituzionali, spesso adottata da attiviste nei confronti di altre attiviste o da collettivi verso altri collettivi. Questo spostamento rende evidente come il call out, sebbene possa essere uno strumento utile per affrontare squilibri di potere, possa essere potenzialmente deleterio quando viene usato “orizzontalmente”, tra persone o gruppi che condividono obiettivi politici comuni o affini. Il tentativo di brown, in questo contesto, è riflettere criticamente su tali pratiche e metterne in evidenza i limiti, proponendo un approccio alternativo al punitivismo. La sua posizione si allinea alle pratiche di giustizia trasformativa, un paradigma che più che punire, cerca di affrontare i danni e le ferite in modi che promuovano la cura, la responsabilità e la trasformazione collettiva. Sebbene il libro non entri in un’esposizione dettagliata di queste pratiche, offre comunque alcuni spunti significativi, incoraggiando a immaginare modalità di gestione dei conflitti che non perpetuino le stesse dinamiche oppressive contro cui i movimenti lottano.
Ci troviamo in uno stato di “affaticamento apocalittico”, afferma brown: abbiamo molta paura, viviamo nella precarietà economica, sociale e “pensiamo che riuscire a identificare con chiarezza un nemico, qualcuno fuori da noi che possiamo biasimare, che è colpevole, che è l’origine del danno, ci metterà al sicuro”, spesso dimenticando che il trauma, la fatica, la paura, possono alterare la nostra comprensione di cosa è abuso e di cosa è conflitto, portandoci lontano da un senso di appartenenza reciproca, di interdipendenza, di possibilità di far parte di qualcosa di “collettivo e decolonizzante”. Alzare la voce non significa essere ascoltate e ricevere cura, e non è sufficiente per costruire un futuro in cui il danno smetta di ripetersi ovunque intorno a noi. Ci spaventa quanto il danno sia diffuso e costante, e questo ci spinge a voler puntare il dito e “cancellare” rapidamente le persone che identifichiamo come “cattive”, ma questo alla lunga rischia di prosciugare tutte le nostre energie, le nostre speranze, i nostri desideri di una vita migliore e collettiva. “In quanto movimenti che cercano di interrompere i cicli di danno e abuso, come facciamo a sostenere, dopo che hanno parlato, le persone sopravviventi e coloro che hanno causato danni in quanto membri della comunità?” si chiede brown.
La rabbia è un’emozione legittima, a volte protegge, è motore di ribellione contro le ingiustizie, ma chi può dirsi davvero priva della possibilità di sbagliare, chi può affermare di non aver mai ferito, avuto comportamenti tossici e abusanti, in un mondo sempre più basato sulla violenza? Questo non significa mettere tutte le violenze sullo stesso piano, e nemmeno evitare che le persone si prendano le responsabilità delle loro azioni, ma anzi trovare nuovi modi, creare nuovi spazi in cui questo sia possibile. Concentrarci sulle origini degli abusi, affrontarli collettivamente senza eliminare le persone bensì chiamandole a prendersi davvero la responsabilità dei danni che hanno agito, chiederci perché e, come afferma Giusi Palomba ne La trama alternativa, provare a “tenere tutto insieme […] contemplare due o più tensioni nello stesso momento […] stare in uno spazio – sicuramente scomodo e non sempre semplice e possibile da concepire – necessario alla riparazione e alla trasformazione, e riempirlo con tutto ciò che serve a questi due processi”.
Il call out, sebbene possa essere uno strumento utile per affrontare squilibri di potere, può essere potenzialmente deleterio quando viene usato “orizzontalmente”, tra persone o gruppi che condividono obiettivi politici comuni o affini.
Il punto di partenza di questo testo, però, pare essere una riflessione a partire dal concetto di “soggettivazione vittimaria” proposto da un importante saggio di Daniele Giglioli, Critica della vittima. Il collettivo bolognese si chiede perché “sembra sia scomparsa la possibilità di prendere parola, di prendere spazio, di rivendicare potere a partire da una condizione marginalizzata senza ricorrere al meccanismo vittimario”, e sembri invece sempre più presente la necessità di costruire un’identità partendo da una posizione di subalternità e impotenza, definendosi in base a ciò che ci è stato inflitto, piuttosto che in base alle possibilità di azione e cambiamento che possiamo intraprendere, a ciò che possiamo fare invece che subire. Il discorso vittimario, sostiene il collettivo, indebolisce le persone o i gruppi che si identificano come vittime, ma anche chi è chiamato a intervenire o a rispondere a tali accuse. Questo, di nuovo, non significa rinunciare a segnalare abusi, violenze, difficoltà o vissuti, e nemmeno appiattire i privilegi e normare le condizioni materiali, ma punta piuttosto a cercare una prospettiva meno individualista e più collettiva, collettivizzando le vulnerabilità e i traumi per rendere potenti i soggetti. Non definirsi come vittime, ma piuttosto come persone sopravviventi. Ciò che caratterizza e che rende importante il libro di brown – e che si ritrova anche in Emergent Strategy, e in generale nei suoi interventi e nelle sue interviste – è una forte spinta verso un futuro luminoso, di desiderio e di collettività futura, in cui “ogni persona ha del lavoro da fare. Il nostro lavoro è luminoso. Non abbiamo alcuna morale perfetta su cui fondarci, modellate come siamo da questi tempi complessi e tossici”.
Sarebbe importante che anche chi è fuori dai movimenti politici, chi non frequenta le assemblee e i collettivi, riuscisse a non fermarsi alle notizie delle censure, che spesso inducono a credere che le lotte politiche siano solo una questione di decoro e normazione. È fondamentale provare a entrare nella complessità dei dibattiti politici contemporanei: solo così si può sviluppare una visione critica e consapevole, capace di andare oltre la superficie delle narrazioni dominanti. Dovremmo riuscire a non ridurre tutto utilizzando l’espressione cancel culture ma fermarci a riflettere su quali percorsi stanno dietro alle pratiche politiche.
All’interno dei movimenti sarebbe importante invece riuscire a trovare dei modi diversi di creare e superare conflitti, fermarsi a riflettere insieme, prima di porgere il fianco alle strumentalizzazioni, all’indebolimento delle nostre lotte. Dovremmo forse trovare modi per non utilizzare il meccanismo della punizione, della gogna pubblica, ma cercare confronti diretti e collettivi, sinceri, mettere in atto pratiche che ci portino a migliorare insieme. Modi più gentili, più radicalmente teneri, senza punizioni ma come comunità che si organizzano e condividono. Il libro di brown ci stimola a farlo “prima che non rimanga più alcuna persona da denunciare, da cancellare, da richiamare, da chiamare ‘noi’, o semplicemente da chiamare”. Altrimenti, a forza di cancellarci a vicenda, non resterà più nessuno a lottare per noi, con noi.