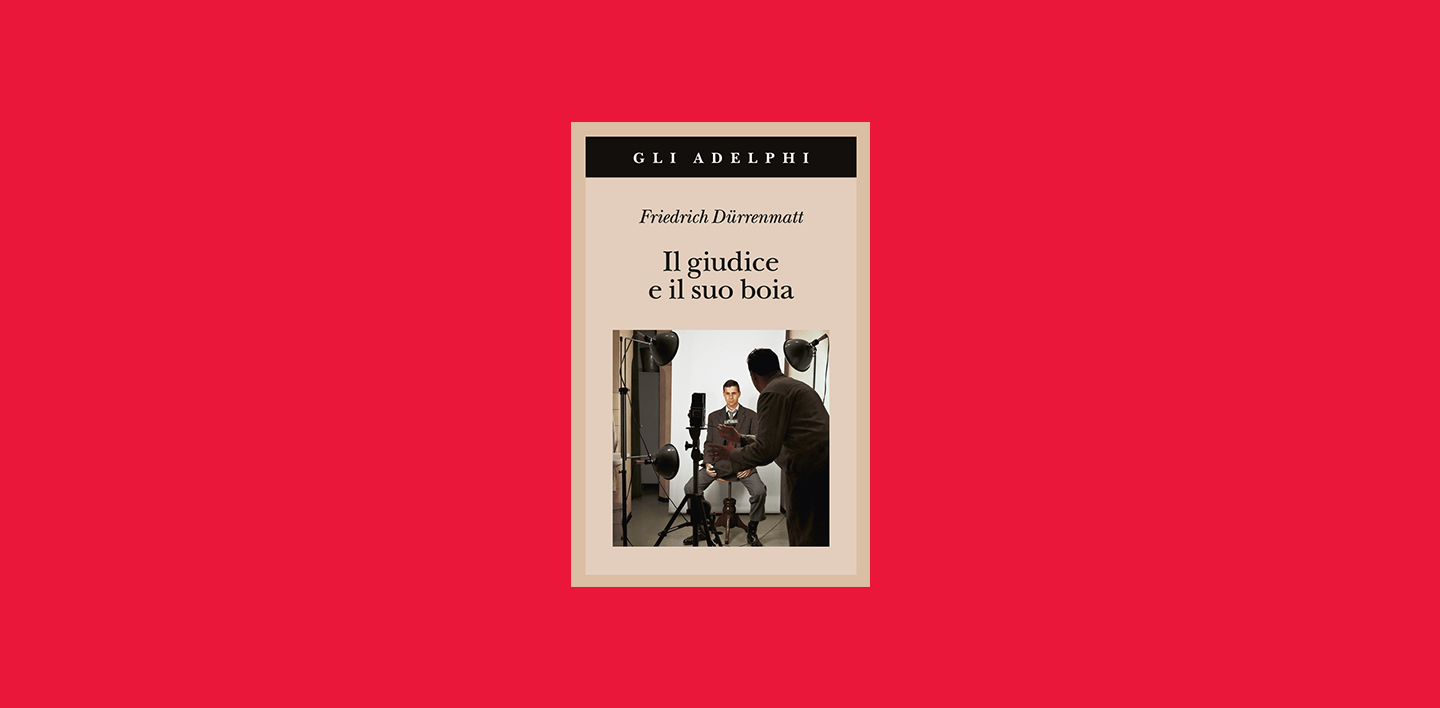
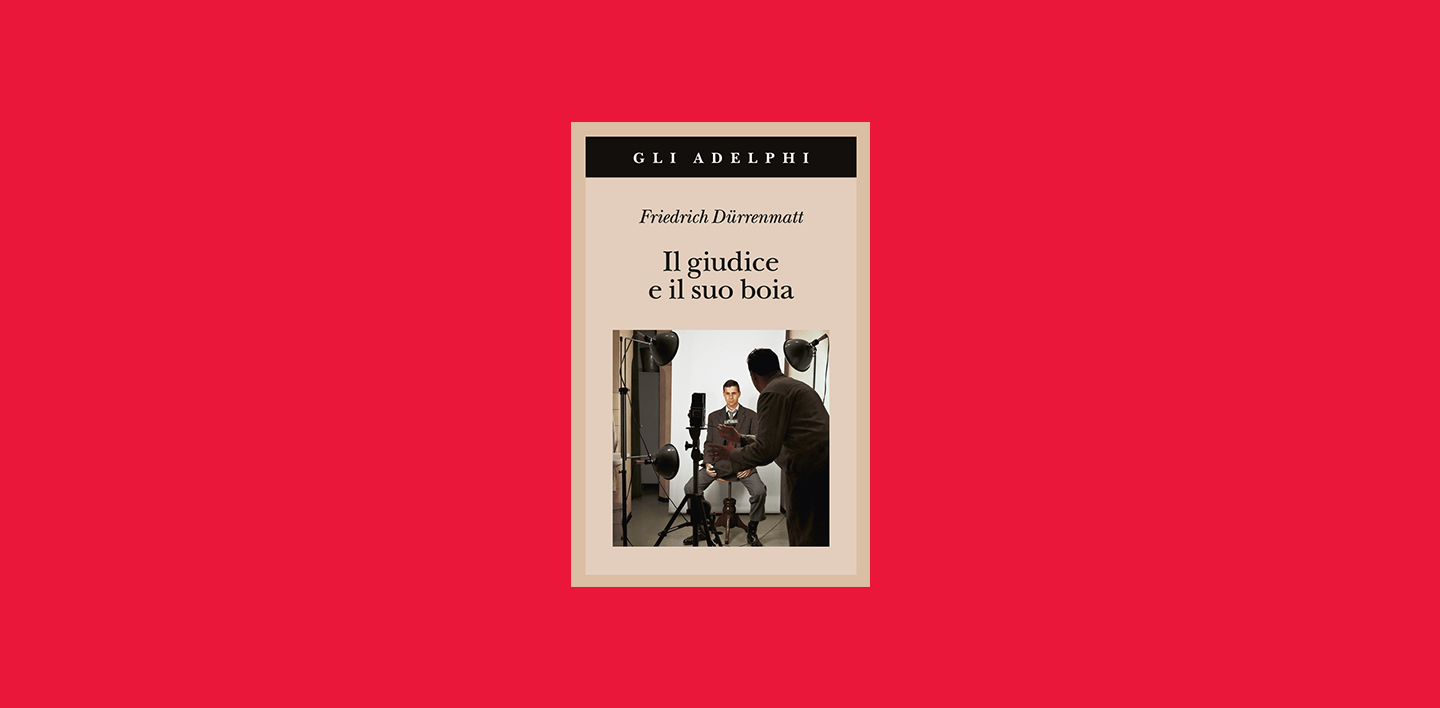
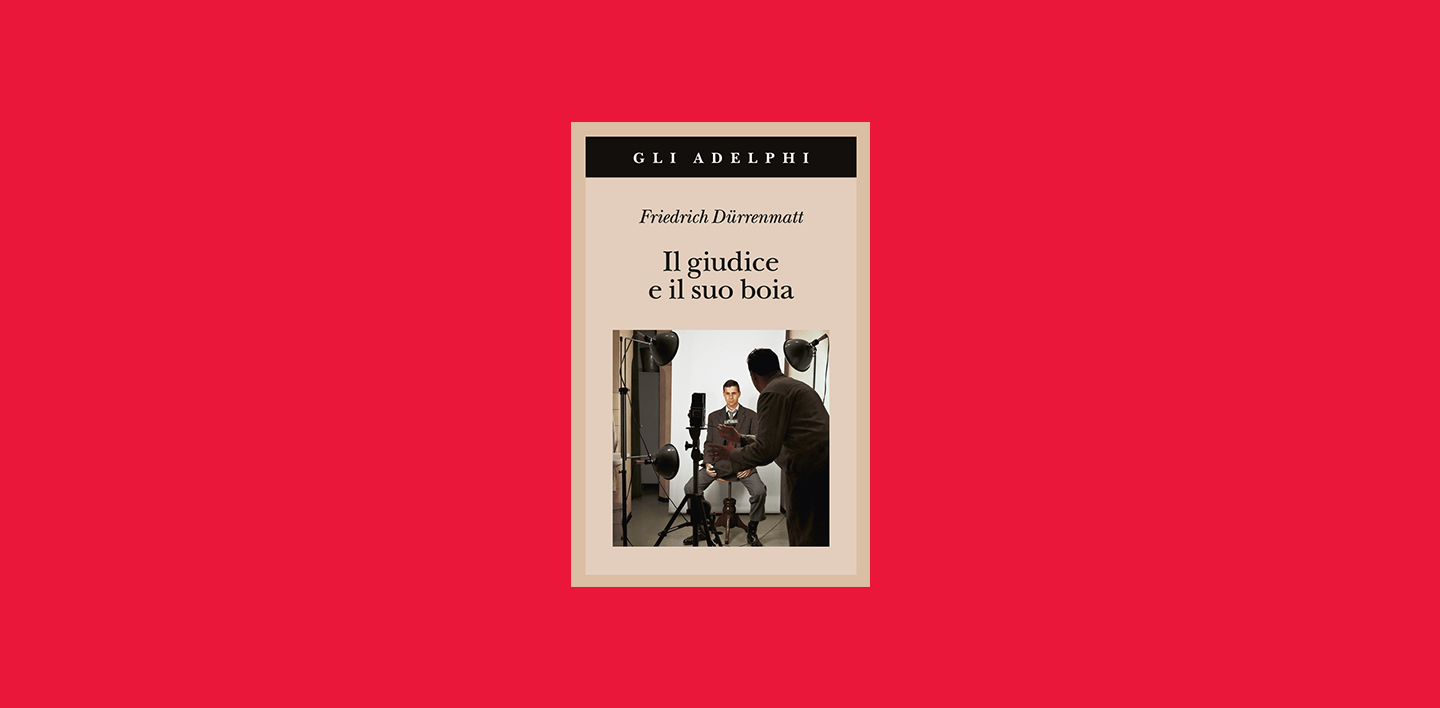
P erché il male?
A questa domanda, che attraversa e squarcia la letteratura del secolo mostruoso che è stato il Novecento come “sfida senza pari” (così la definiva Paul Ricoeur), tante risposte sono state tentate. Di tutte, quella di Friedrich Dürrenmatt resta una delle più scandalose e angoscianti. E se il male non fosse che un esperimento giocoso, una tenzone, un’empia scommessa sulla mera possibilità dell’empietà stessa?
Lo suggerisce lo scontro, lungo una vita, tra il “nichilista” Gastmann e il suo avversario Bärlach ne Il giudice e il suo boia, primo romanzo filosofico più che poliziesco. I due si incontrano la prima volta in una bettola di Costantinopoli, dove legano le proprie vite a una sfida improponibile e mortale. Così la ricorda Gastmann, demone dostoevskijano dei più depravati, con parole dirette a Bärlach che sfuggono a qualsiasi ulteriore parafrasi:
Secondo la tua tesi, l’imperfezione umana è il motivo per cui la maggior parte dei delitti viene inevitabilmente alla luce: siamo incapaci di prevedere con sicurezza come agiranno gli altri, e nei nostri ragionamenti non riusciamo a integrare il caso, che in tutto mette lo zampino. Dicevi che è da stupidi compiere un delitto, perché non è possibile muovere gli uomini come figure su una scacchiera. Io allora per contraddirti, ma senza vera convinzione, sostenni che proprio il garbuglio dei rapporti umani ti permette di compiere delitti che
non si possono scoprire.
Mosso da questi pensieri, Gastmann, “astrazione diventata realtà”, compie il suo primo omicidio sotto gli occhi di Bärlach e lo sfida a incastrarlo con prove che vadano oltre la sua semplice ed esterrefatta testimonianza. In altre parole: lo spettacolo del male è davvero di fronte ai nostri occhi; dovremmo negare l’evidenza per sostenere che non esista. Ma riusciamo – e in questo sta la sfida – a dichiarargli scacco matto con le forze della filosofia, della logica, della scienza? Siamo in grado di spiegarci la sua esistenza, e non semplicemente di constatarla?
Passano gli anni e i sentieri di Bärlach, commissario di polizia in Svizzera, e Gastmann, divenuto da allora il più dissoluto omicida, si incrociano di nuovo, e per l’ultima volta. La loro sfida definitiva orbita attorno al ritrovamento del corpo di un poliziotto nella sua auto al ciglio della strada, attraversato da un proiettile.
Bärlach, debilitato da gravi problemi di salute, non può seguire le indagini sul campo. Di fatto, non ne ha bisogno. Investigatore metafisico, che trascura “le grandi acquisizioni della moderna criminologia scientifica”, ha già la soluzione del caso. Le prove empiriche schiaccianti sono un preteribile sovrappiù.
Perché Bärlach sa che la vera lotta è nel pensiero, ed è un lottare invano. A differenza di Hercule Poirot, dandy psicologista che con sprezzatura può risolvere un delitto senza uscire dalla sua stanza, o di Padre Brown, al quale anche nelle più spaventose incursioni nel territorio del maligno non manca la fede nel bene, Bärlach è un uomo logoro, impotente e solo. Assediata dall’atrocità di un mondo incomprensibile, la mente umana, in Dürrenmatt, trema, perché, tra bene e male, che sono “sempre in potenza”, “a decidere è il caso”. E ciò vanifica ogni sforzo.
Quello che evocano lo scrittore svizzero e i suoi personaggi è un enigma ancor più sproporzionato della vecchia teodicea. Se Dio è morto e il cielo è vuoto, non per questo il male è ‘meno male’ di quanto fosse in precedenza (o il bene è meno bene). Tuttavia, in assenza di schemi o disegni sullo sfondo atti a contenere o a generare il senso, “il fascino del male” si rivela come “espressione” della “libertà del nulla”. Il risultato, tutt’altro che liberatorio, non è un alleggerimento psichico: è il peso insostenibile del vuoto.
Per questo il modo di procedere di Bärlach è del tutto atipico, quasi irrazionale, distratto, negligente. Solo a tratti sembra una rincorsa alla cieca e a capofitto, contro il tempo che lo uccide e il suo avversario che lo insidia; altre volte, invece, il suo “metodo” è ozioso, dispersivo, rassegnato. Poiché sa già la soluzione, non può fare altro che attendere – o fingere di attendere – il manifestarsi indipendente della soluzione, se il caso vuole che si manifesti. Quale altro modo per oltrepassare lo strapotere del “puro caso”, infatti, che dare l’impressione di assecondarlo?
Quasi ad anticipare la riedizione de Il giudice e il suo boia, qualche mese fa per Adelphi usciva La promessa, dello stesso autore, che del primo romanzo costituisce il completamento ideale. Qui incontriamo il commissario Mätthai, che per incastrare un misterioso uccisore di bambine mette in atto una trappola perfetta, logicamente parlando, ma il cui piano impeccabile si scontra con un mondo dove nulla funziona per logica, dove tutto, anzi, è in balia delle oscillazioni del caso – persino la verità, scherzo beffardo.
Ciò che Dürrenmatt tenta – con il successo senza argini dello stillicidio – è in entrambi i casi “una critica” del detective, “questa tipica figura ottocentesca” ossia positivista e scientista. Come, ne La promessa, il dottor H. rimprovera a uno scrittore di gialli,
tutti i romanzi polizieschi si basano su un inganno […]. Non alludo al fatto che i vostri colpevoli vengono sempre puniti, questa bella favola è moralmente necessaria […]. No, ciò che davvero mi irrita […] è la trama. Qui l’inganno diventa clamoroso e troppo spudorato. Le vostre storie sono costruite secondo logica, come in una partita a scacchi: […] basta che il detective conosca le regole e le applichi al gioco ed ecco che arresta il criminale e la giustizia trionfa. Un imbroglio che mi rende furioso. Alla realtà si accede solo in parte con la logica. […] gli elementi di disturbo che ci mettono i bastoni fra le ruote sono tali e tanti che troppo spesso solo la fortuna o il caso intervengono in nostro favore. O in nostro sfavore. Invece, nei vostri romanzi il caso non interviene mai. […] voi scrittori […] non cercate di misurarvi con la realtà, che ci elude sempre, ma costruite un mondo in cui tutto è spiegabile. Un mondo simile può anche essere perfetto, d’accordo, però è una menzogna.
Sta in questo la vertigine che si percepisce in Dürrenmatt: scrivere del male, in un mondo fattosi caso, significa (e richiede) scrivere senza menzogne. Il problema del male, diceva Ricoeur, “mette in questione […] un modo di pensare sottomesso all’esistenza della coerenza logica, vale a dire nello stesso tempo della non-contraddizione e della totalità sistematica”. Pensare e scrivere il male, allora, si fa “un invito a pensare meno o una provocazione a pensare di più, addirittura a pensare [e a scrivere] altrimenti”.
Così, forse, anche il metodo di Bärlach, che del male subisce il potere ogni volta che, come tutti, si sente “irrimediabilmente chiamato a risolvere” il suo enigma, non è infine del tutto inefficace. Né lo sono gli sforzi di Dürrenmatt di mettere in evidenza la realtà paradossale delle cose, ordinate o disordinate che siano, buone o malvagie “secondo il ghiribizzo”.
Dopotutto, pur “senza poteri, senza Stato, senza leggi e senza prigioni alle spalle”, anche lo scrittore è, a modo suo, “una specie di investigatore” del mistero senza fondo dell’esistenza. Non solo: ne è anche, talvolta, giudice e boia. Come Dürrenmatt.