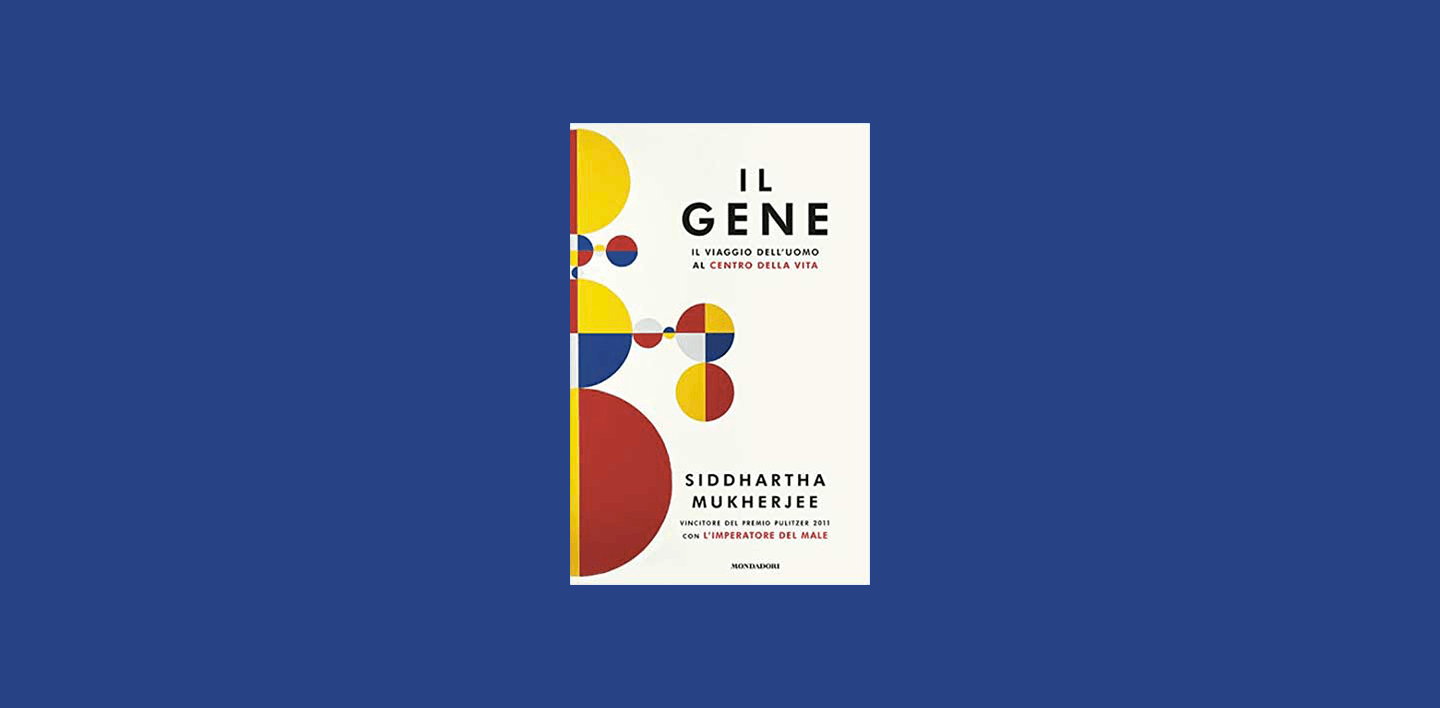
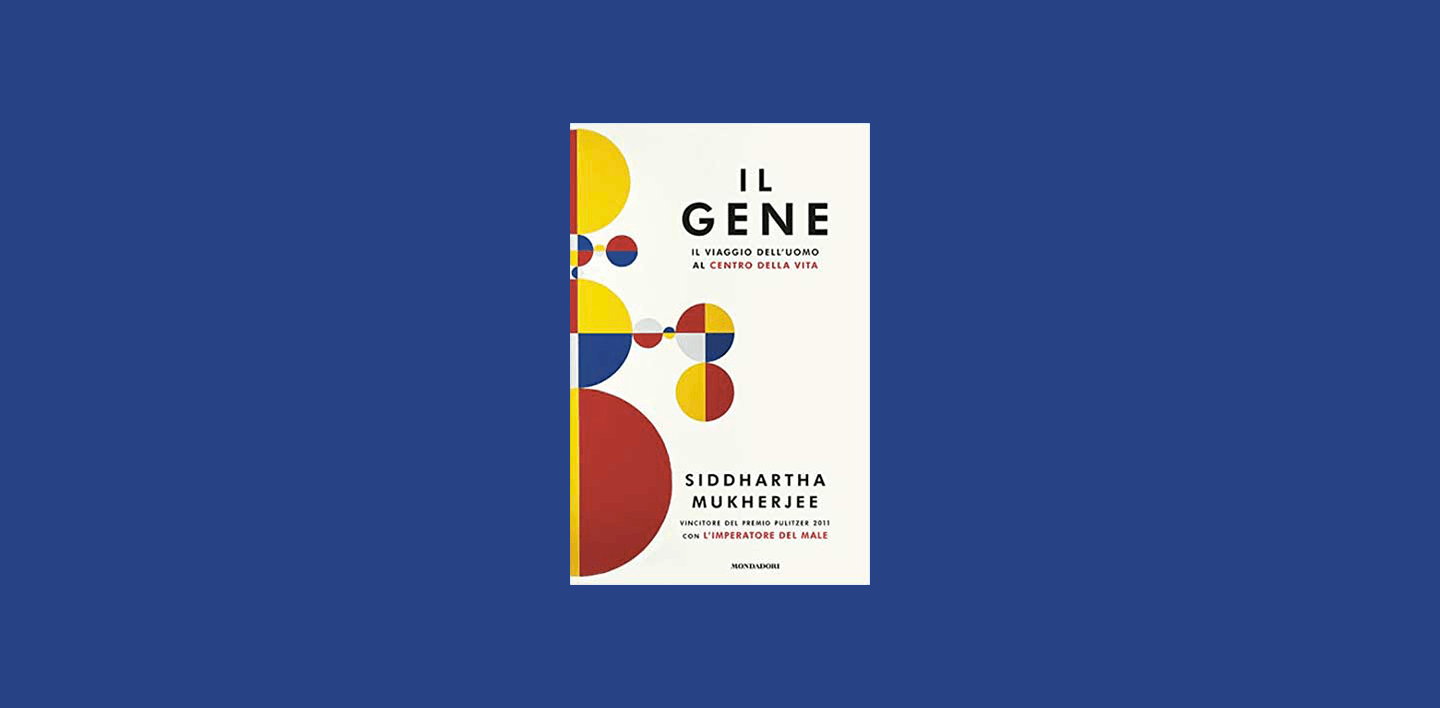
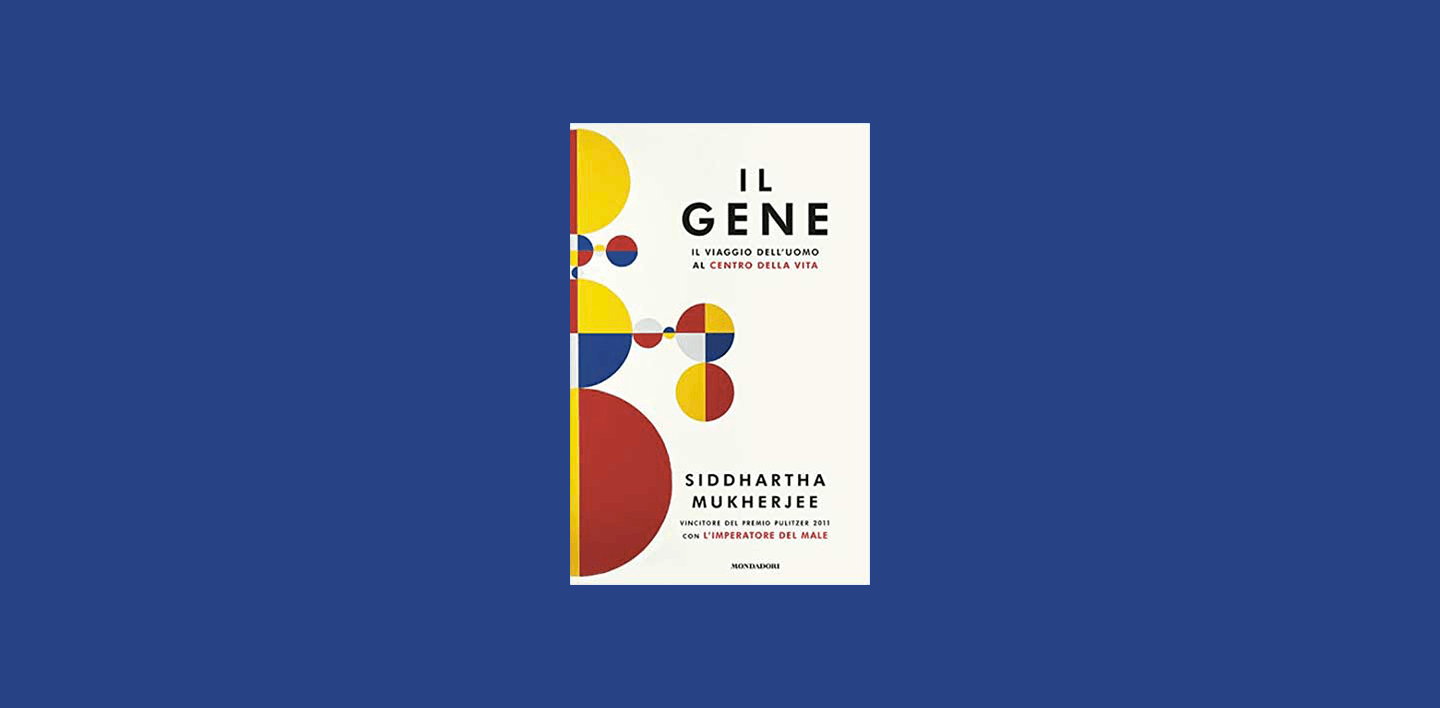
“Q uando nel maggio 2010 terminai l’ultima stesura de L’imperatore del male, non avrei mai pensato di riprendere la penna in mano e scrivere un altro libro”. Fortunatamente Siddhartha Mukherjee ha cambiato idea. Dopo il suo racconto epico sul cancro, con Il gene (Mondadori, 2016) ci offre ora l’antefatto: la nascita e lo sviluppo della genetica. Ha avuto coraggio. Il cancro è per lui un nemico che incontra ogni giorno in corsia; i geni, impalpabili, richiedono impegno e dedizione a un medico che voglia raggiungere la padronanza dell’argomento.
Ma anche quando l’esperto cede il passo allo studioso, da Mukherjee si impara comunque tanto. La morte di Jesse Gelsinger, in una delle prime sperimentazioni di terapia genica, è per esempio una vicenda nota, ma non era ancora capitato di leggerne un racconto così accurato, umano, esemplare. Sono tante le cose andate storte in quella vicenda: una malattia troppo blanda per mettere a rischio la vita di un ragazzo di diciotto anni, un consenso informato lacunoso, degli effetti collaterali minimizzati o ignorati, degli interessi economici non dichiarati. L’intervista al padre, infine, ancora dolentissima dopo quasi vent’anni, è un richiamo a umiltà e cautela.
In generale Mukherjee dà il meglio di sé nei racconti che richiedono vaste, sintetiche pennellate. Non rifugge, per esempio, dall’imbarazzo per l’eugenetica: “tre generazioni di imbecilli sono abbastanza”, frase crudele e memorabile, che pesca dall’autorizzazione made in USA del 1927 a una procedura di sterilizzazione obbligatoria per inetti. Regala immagini sublimi, come quella dei commessi viaggiatori a riposo presi in prestito per descrivere frammenti un tempo salterini di DNA, derivati da antichi virus, inseriti nel genoma in un lontano passato, oggi perlopiù disattivati e messi a tacere. Sparsi qua e là, l’autore raccoglie aneddoti memorabili che fanno capire come vivevano e pensavano i pionieri dello studio dei geni:
Li aveva tenuti nella propria stanza, perlopiù di nascosto, per cercare di produrre ibridi di topo. Ma l’abate, benché in genere avesse un atteggiamento tollerante verso le sue stravaganze, era intervenuto: che un monaco spingesse i topi ad accoppiarsi per capire il meccanismo dell’ereditarietà era un po’ troppo audace, anche per degli agostiniani. Mendel era passato allora alle piante e aveva trasferito i suoi esperimenti nella serra fuori dell’abbazia. L’abate aveva acconsentito. Aveva vietato la copula dei topi, ma era disposto a dare una possibilità di riprodursi ai piselli.
Altre frasi danno in poche righe l’idea del vuoto genetico in cui galleggiavamo fino a poco più di un secolo fa: “né Bateson né Johannsen avevano la più pallida idea di che cosa fosse il ‘gene’. Non sapevano che forma avesse, quale fosse la sua struttura fisica o chimica, dove fosse localizzato all’interno dell’organismo o delle cellule e nemmeno come funzionasse. Il termine era stato creato per designare una funzione ed era un’astrazione”.
Un po’ più deboli sono le parti lontane dalla medicina, come la genetica delle popolazioni. Il libro perde poi in definizione quando perlustra territori in rapida e caotica trasformazione, come l’ingegneria genetica più recente. Ma è il destino inevitabile delle mappe, anche le migliori, e fermarsi prima non si può. Quando The gene è uscito negli USA, a primavera 2016, ha suscitato qualche polemica, soprattutto per le parti dedicate all’epigenetica, disciplina che rinvigorisce la vecchia dicotomia tra natura o ambiente. Difficile dire, oggi, che cosa facciano di preciso i fattori epigenetici e quanto pesino (tanto? tantissimo? un po’?).
Nonostante questo, Il Gene resta un libro opportuno e tempestivo. Giunti al culmine di un certo tipo di sapere, si vedono cime ancora più impervie: i geni spiegano molto, sì, ma non tutto.
Una particolare combinazione di geni (un genotipo) potrebbe predisporci a una particolare configurazione del naso o a una certa personalità, ma la forma esatta o la lunghezza del naso che avremo resta impredicibile. Una predisposizione non può essere confusa con la disposizione: una è una probabilità statistica; l’altra una realtà concreta.
In conclusione una menzione per l’ottima traduzione di Laura Serra e Roberto Serrai (anche se Alison Gopnik, presa per un maschio, è proprio donna). Peccato solo per l’annientamento del sottotitolo originale, An intimate story, a favore di un più insipido Il viaggio dell’uomo al centro della vita. Era infatti a quell’intimate che l’autore aveva affidato la molla personale per comprendere l’origine, forse genetica, dei mali della sua famiglia.