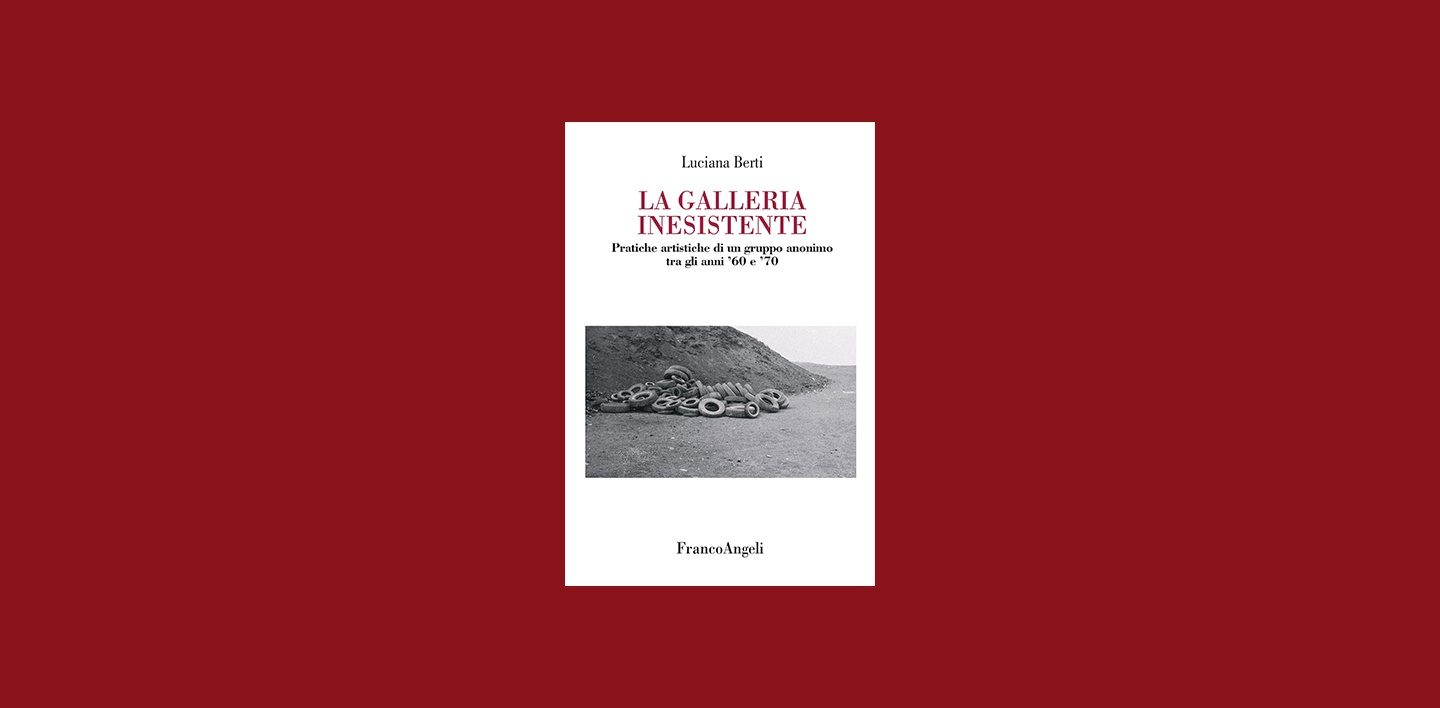
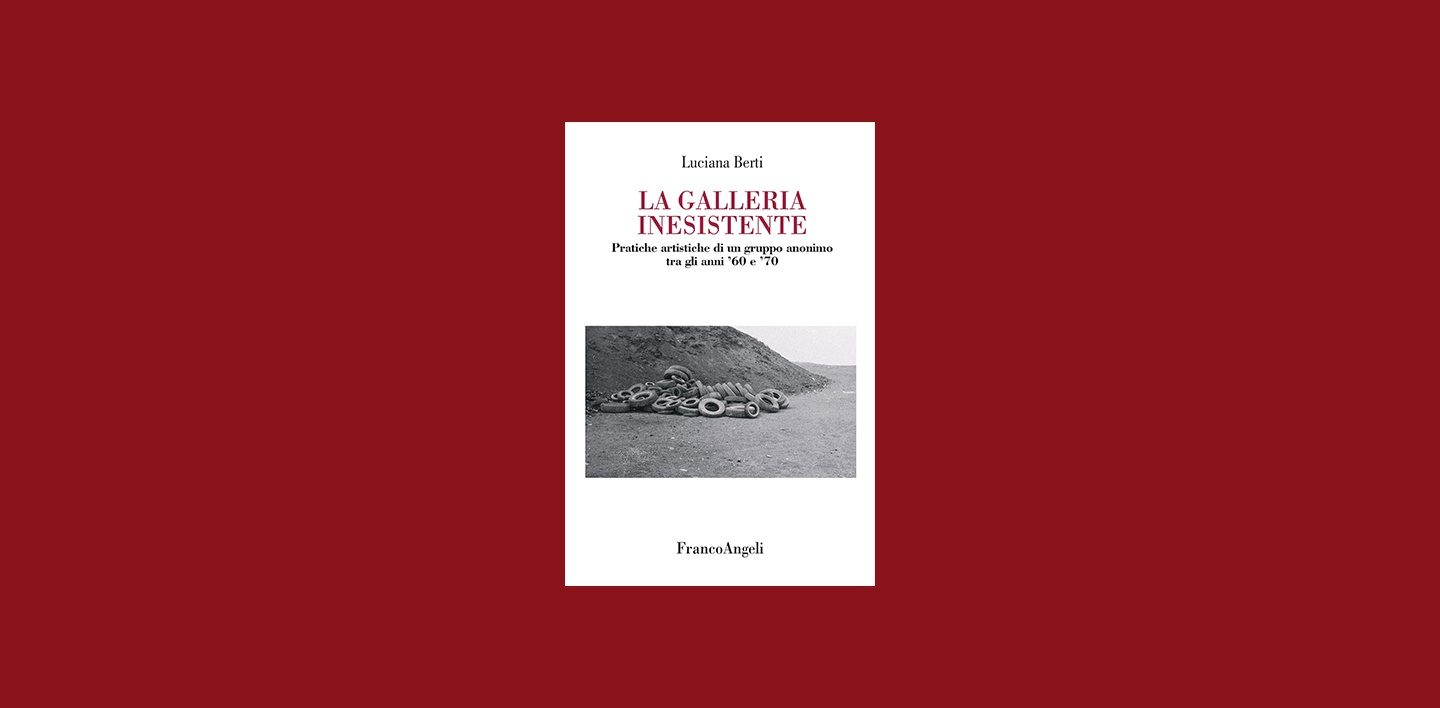
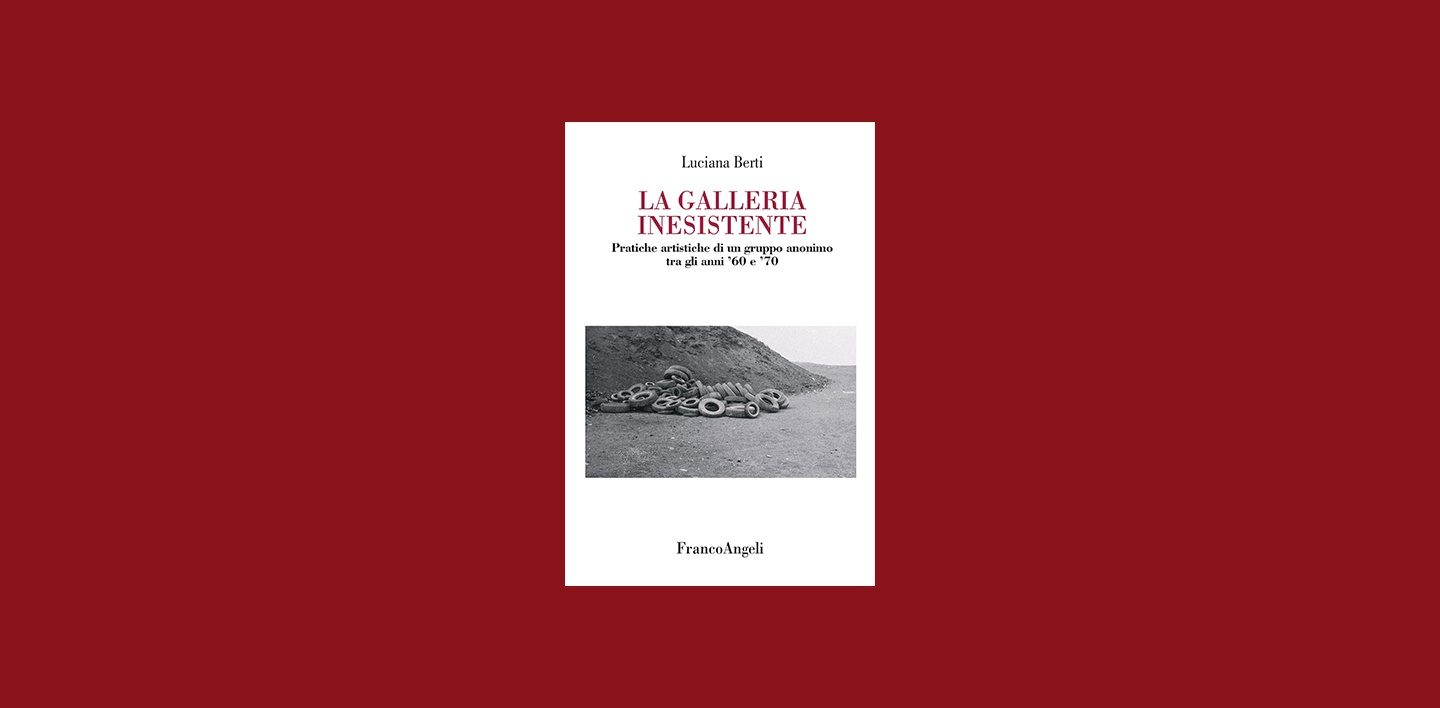
A lle 13:30 del 15 aprile del 1969, in una giornata in cui tutto sembrava andare come doveva andare, in cui il cielo era terso, il mare era azzurro e nei bar si discuteva della Fiorentina avviata verso il suo secondo scudetto, il Vesuvio chiamò. Più che un richiamo, un sussurro: un piccolo, flebile pennacchio di fumo nerissimo, che s’alzò verso il cielo accompagnato da minuscoli boati. Solo in pochi capirono cosa stesse succedendo, e quei pochi probabilmente avevano letto un volantino che era circolato, in mattinata, a Napoli e in alcuni paesi vesuviani: lì si faceva riferimento a una profezia, a uccelli che annunciavano un evento catastrofico e intimavano di rivolgere lo sguardo al vulcano. Un foglio un po’ criptico, a dire il vero, tant’è che tra gli osservatori prevalse più lo sconcerto che la meraviglia.
Nulla di grave; ma ci vollero i giornali del giorno dopo a decifrare l’enigma: “Panico nella zona per uno scherzo di pessimo gusto”, titolò Napoli Notte. E Il Mattino: “Quando i ‘filosofi’ scherzano col fuoco. Allarme per un’improvvisa eruzione del Vesuvio ‘creata’ da un gruppo di singolari personaggi”. L’azione, svoltasi nell’arco di due ore, con un centinaio di copertoni portati in cima al Vesuvio per mulattiere contadine e poi dati alle fiamme da fuochisti esperti, era stata partorita dalla Galleria Inesistente, un gruppo anonimo di artisti che nella sua breve esistenza – dal 1969 al 1974 – ruppe le scatole a chiunque potesse romperle.
Il gruppo, fondato a Napoli da Vincent d’Arista e Bruno Barbati, è stato tra le esperienze più innovative del panorama dell’arte di quegli anni. Non era avanguardia, ma faceva “movimento” – nonostante l’età di chi vi partecipava fosse non certo giovane; era un po’ happening e un po’ performance. Col proprio nome sintetizzava un manifesto: rifiuto consapevole dell’autorità e di collocazione sul mercato. Tra i suoi membri, in tempi diversi e tra una scissione e l’altra, ci sono stati Gianni Pisani, Errico Ruotolo, Maria Palliggiano, Giannetto Bravi, Maria Roccasalva, Gerardo Di Fiore. Le loro azioni – dall’eruzione simulata del Vesuvio alla pioggia di braccia di plastica in strada, alle mostre dove non si presentava nessuno ad un annuncio in cui si cercavano “filosofi veraci” – erano antagonismo puro; progettate in un modo che oggi può sembrarci un po’ goffo e persino puerile, ma pensate davvero per essere immerse nel tessuto cittadino, a contatto diretto con i suoi abitanti.
Dal 1960 al 1965 aprirono, in punti strategici di Napoli, spazi che avrebbero fatto la storia dell’arte.
Nel suo La Galleria Inesistente. Pratiche artistiche di un gruppo anonimo tra gli anni ’60 e ’70 (FrancoAngeli, 2016), la storica dell’arte Luciana Berti ripercorre le tracce di una compagnia alla Amici Miei che poteva esistere, forse, solo in un’epoca come quella. E di cui si è perso quasi tutto: l’emigrazione e la morte prematura di alcuni membri hanno gettato l’intera esperienza nell’oblio, materiali, tracce biografiche, documentazioni. Non tutto scomparve, però. Nel 2014, il modesto Forum delle Culture che quell’anno si tenne a Napoli pensò di omaggiare la Galleria con una piccola mostra; è così che l’autrice ebbe modo di contattare qualche curatore e superstite, organizzare interviste, recuperare testimonianze preziose. E dal flusso dei ricordi, a volte un po’ confusi e contraddittori, riemerge un periodo irripetibile per il capoluogo campano e per l’Italia.
Dal 1960 al 1965 aprirono, uno dopo l’altro, in punti strategici di Napoli, spazi che avrebbero fatto la storia dell’arte: Galleria Centro, Libreria Guida, la Modern Art Agency di Lucio Amelio. Ai quali si aggiunse, nel 1966, la Rassegna di Pittura ad Amalfi curata da Marcello Rumma, la galleria di sua moglie Lia nel 1971, e poi gli studi Morra e Trisorio. E pare fantascienza, ma la città che oggi lotta con una ristrettezza di budget quasi venezuelana, che si abbellisce con neon da festa di paese, quarant’anni prima ebbe tra i suoi residenti abituali artisti come Dan Flavin, Janis Kounellis, Cy Twombly, Hermann Nitsch, Michelangelo Pistoletto, Josef Beuys e Andy Warhol, giusto per citarne qualcuno.
La Galleria Inesistente – che in questo contesto si muoveva un po’ con la rabbia degli esclusi, un po’ con la gigioneria di chi sa imporsi e farsi dare del tu da chiunque – aveva come centro nevralgico il colto professor Vincent D’Arista, fumatore accanito, bevitore di un litro al giorno di caffè, matematico e insegnante d’inglese a tempo perso. Sempre frettoloso e irrequieto, elegante in un completo bianco o beige, in cammino verso la cinquantina, un tantino volatile e vago, era conosciuto per il suo carattere burbero e stimato per la sua intelligenza. Chi mi fece per primo il suo nome fu il musicista Daniele Sepe, che così lo descrisse:
Un personaggio alla Kerouac, una grande capa ‘e mmerda. D’Arista a Napoli fece cose epocali: un giorno venne al comitato di Autonomia Operaia e ci disse che aveva bisogno di noi per una mostra che doveva fare alla galleria Trisorio. Noi la sera andammo, ma non sapevamo che dovevamo fare, la galleria era vuota e il gallerista continuava a chiedere a Vincent che cosa avrebbe portato per la mostra. Era preoccupatissimo. Vincent gli diceva con un accento italoamericano fortissimo ‘non ti preoccupare’. A mezz’ora dall’inaugurazione ci diede una corda e ci ordinò di catturare il gallerista, legarlo e buttarlo sotto il muro. Così facemmo e lui poi incise la sua firma nella parete al fianco del povero Trisorio.
Nato a New York nel 1927, padre di cinque figli, D’Arista non aveva nulla della biografia di un tipico artista di sinistra di quegli anni. Aveva iniziato a lavorare da piccolo nel negozio dei genitori, che importavano cianfrusaglie kitsch dalla Sicilia. Dopo la seconda guerra mondiale si era laureato in matematica alla Columbia University ed era andato in giro per l’Europa in autostop. Trasferitosi a Napoli con la moglie Ginetta nel 1961, d’Arista non avrebbe sviluppato un serio interesse per l’arte se non alla metà dei Sessanta, quando con l’amico Barbati riempì il salotto di casa di appunti e schizzi per il futuro progetto della Galleria. Il suo egocentrismo finiva col fargli difetto, portandolo a sfuriate memorabili con parenti, amici e colleghi, e quasi a molestare i galleristi e i critici di cui esigeva l’attenzione. Ognuno dei membri della Galleria aveva qualche caratteristica che l’accomunava agli altri, pur avendo ognuno la sua vita, il suo lavoro, la sua famiglia; e il più irruente era sempre D’Arista, che dominava e disfaceva ogni cosa, con ondate di energia e poi di malinconia improvvisa. Al centro di tutto c’era il mercato dell’arte, che agli occhi della Galleria Inesistente aveva due peccati capitali: la compromissione con il sistema capitalistico – insita proprio nell’essere galleristi – da un lato; e dall’altro l’apertura alla scena internazionale, che secondo alcuni chiudeva colpevolmente, in maniera pregiudiziale, gli occhi sull’attività dei napoletani.
Dieci anni fa circa, chi scrive partecipava ad un collettivo che andava di notte per le strade di Milano ad incollare versi, citazioni e frasi ad effetto – cosa che noi, con un po’ d’ingenuità guascona, chiamavamo “guerriglia poetica”. A quei tempi, prevedibilmente, avevamo per modello le birichinate di Maurizio Cattelan e Luther Blissett, le loro teorie sull’anonimato, la guerra psichica, eccetera, forse per provincialismo all’incontrario, senza sapere che la Galleria Inesistente ci aveva già anticipato tutti su un bel po’ di temi. Però, al di là dei contenuti, c’erano le pratiche: fisiche, tangibili – tutti giù per strada, col buio! – e senza saperlo ci ricollegavano all’esperienza di d’Arista e della Galleria. E a confronto con l’attivismo di oggi, tutto online, al quale pure mi sono abituato, quei dieci anni già mi sembrano trenta.
Nel libro di Berti, che forse pecca di scarsa organicità in alcuni capitoli e di ripetizione in alcune interviste, l’aspetto esaltante della storia traspare tra le righe: nella distanza tra ciò che era quel mondo e il sistema dell’arte attuale. Qui abbiamo un gruppo di signori e signore che iniziarono a fare arte tardi, con pochissima preparazione teorica; eppure diventarono amici di Beuys – che si fece fotografare vicino a dei leoni di cartongesso che la Galleria aveva piazzato all’esterno della sua esposizione. Era un rapporto di provocazione lucida, in fondo effimera, non si sa con quali lasciti, ma impensabile oggi; ed è questo che, in fondo, resta.