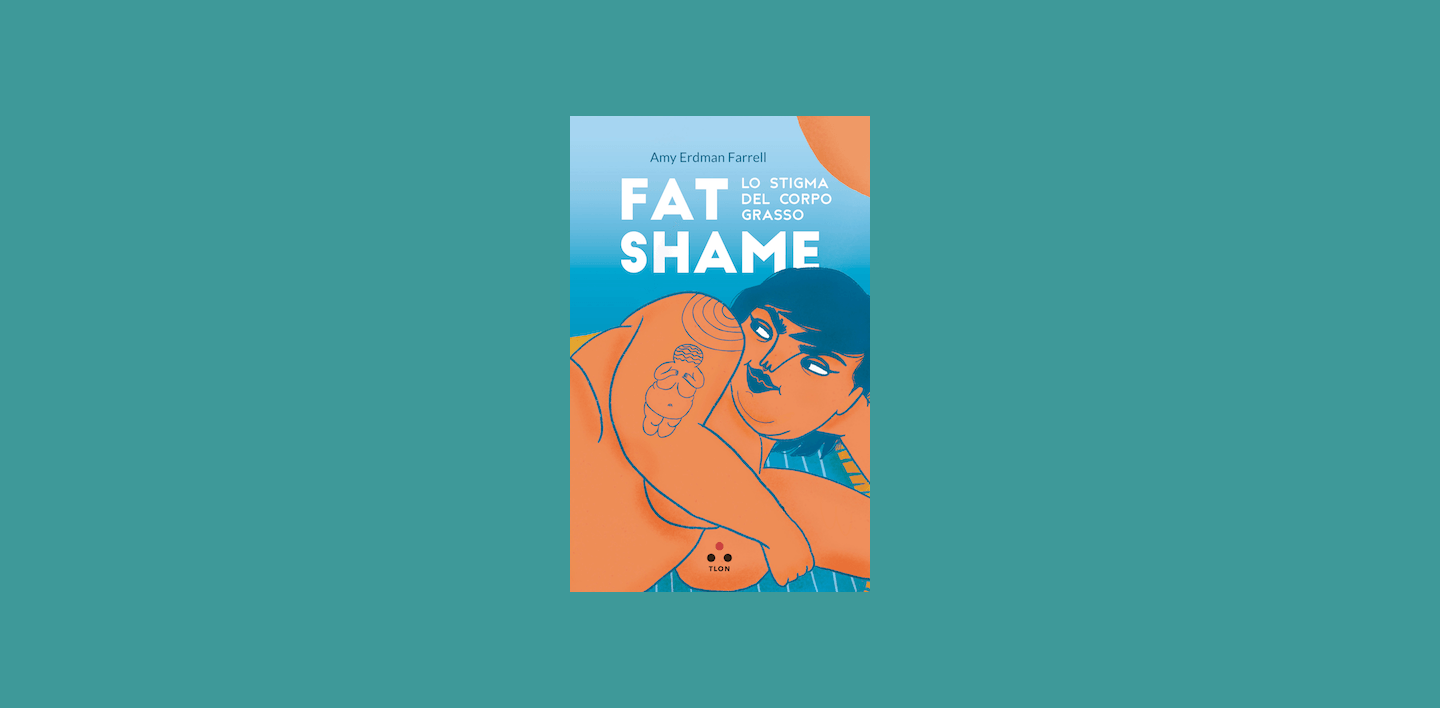
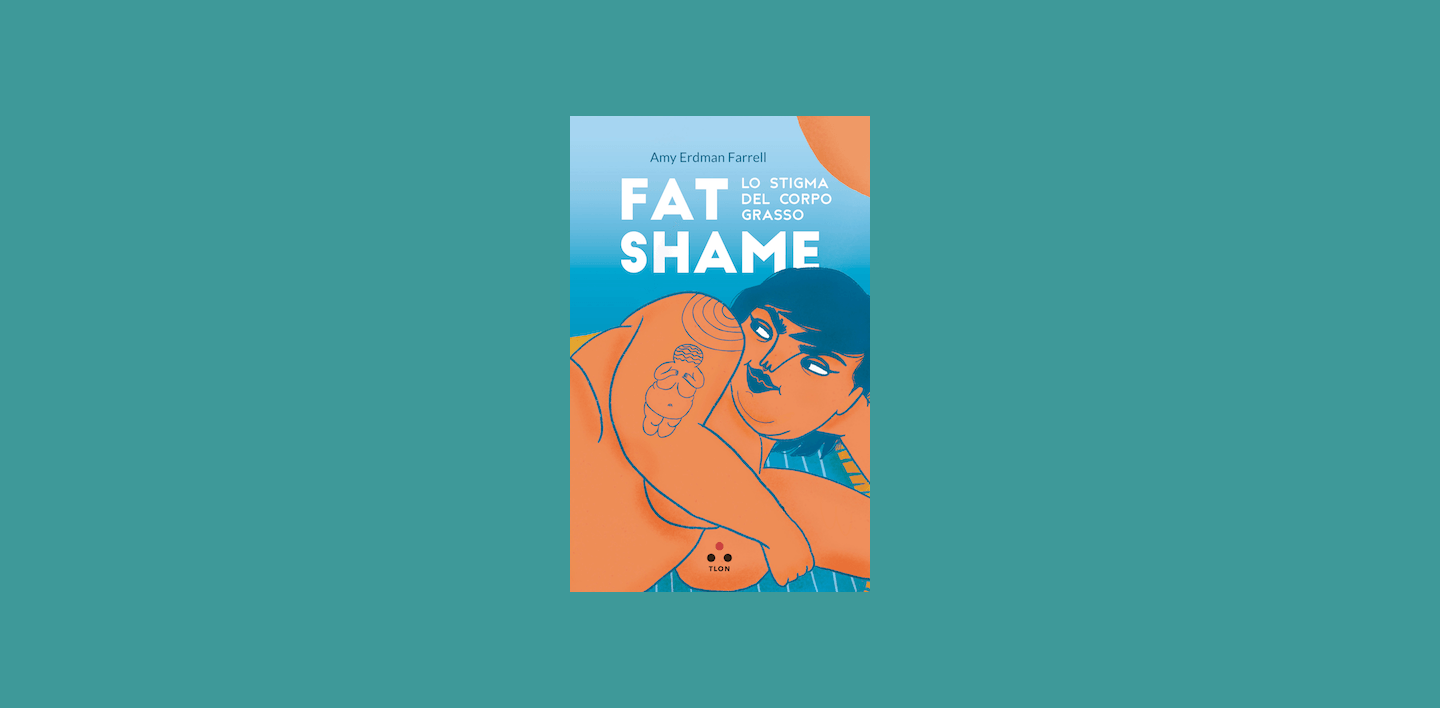
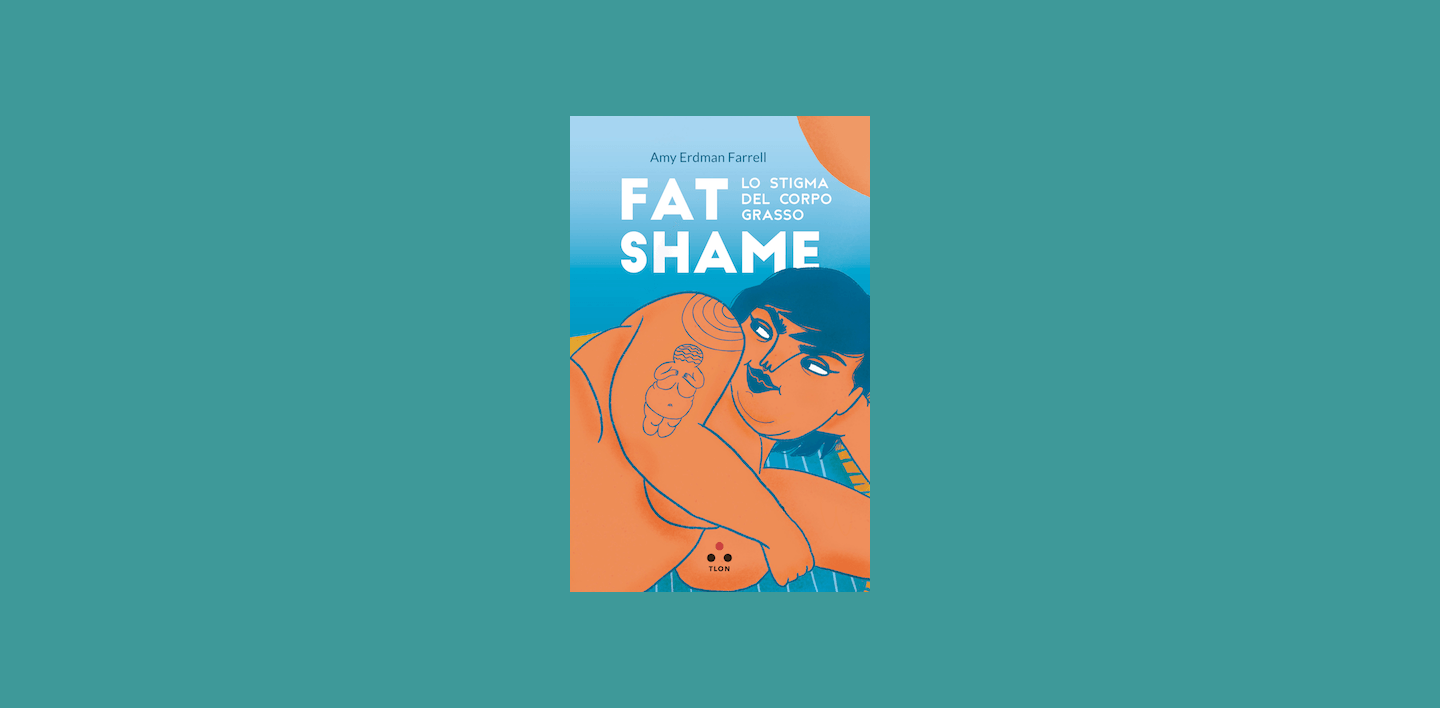
S e negli Stati Uniti Fat Shame di Amy Farrell aggiunge un tassello di valore all’ambito già nutrito dei fat studies, la sua traduzione italiana va a colmare una lacuna significativa; è infatti il primo saggio sulla grassofobia pubblicato in Italia (edizioni Tlon, traduzione di Dorotea Theodoli). Sebbene il testo abbia come punto di riferimento la cultura americana, è comunque un ottimo apripista per una riflessione sull’origine dello stigma del grasso e sulle connessioni tra peso e nozioni di cittadinanza.
Scritto nel contesto di una crescente ansia pubblica nei confronti dell’obesità – definita come una “epidemia”, una “minaccia nazionale” e un “nemico pubblico” – Fat Shame indaga la nascita e l’evoluzione della grassofobia nella cultura americana, allineandosi alla diffusa percezione che la storia culturale del grasso si divida in una fase premoderna, in cui questo era apprezzato e sfoggiato come simbolo di ricchezza, e una moderna in cui è stato progressivamente patologizzato e associato a immagini negative (ad esempio E. Levy-Navarro, The Culture of Obesity in Early and Late Modernity, 2008). In questa cornice, Farrell identifica il cambio di paradigma nel corso dell’Ottocento, in anticipo rispetto all’opinione diffusa che lo colloca negli anni Venti del Novecento, in relazione all’avvento delle industrie dietetiche.
Attraverso una notevole ricerca d’archivio tra pubblicità, articoli, vignette politiche e cartoline, Farrell documenta come la grassezza sia stata progressivamente interpretata come segno e sintomo di pigrizia, ingordigia, avidità, mancanza di autocontrollo, bruttezza e primitività, e come abbia determinato (e continui a determinare) il livello di accesso alle risorse culturali ed economiche e ai diritti politici.
I pregi del libro sono molti, ma i contributi a mio avviso più interessanti riguardano l’analisi di come lo stigma del grasso si sia sviluppato anche in relazione alle idee di razza, civiltà e evoluzione e quella del rapporto tra femminismo e grassofobia. Fat Shame fa emergere come la stigmatizzazione del grasso si leghi a nozioni di appartenenza al/ esclusione dal corpo politico e sociale.
La lettura critica del rapporto tra femminismo e grassofobia, in particolare, mette in evidenza quanto profondamente sia introiettata l’angoscia suscitata dal grasso. Nonostante il femminismo abbia riconosciuto il corpo come terreno di scontro politico, secondo Farrell, non è comunque riuscito a evitare la trappola del culto della magrezza.
Nel capitolo “Femminismo, Cittadinanza e Stigma del Grasso” ricostruisce come già i metodi propagandistici del movimento suffragista, “rappresentando donne magre, bianche e di bell’aspetto spesso sopraffatte da poliziotti corpulenti”, abbiano contribuito a definire il legame tra snellezza, civiltà e bianchezza:
Come quelle degli antisuffragisti, le vignette delle suffragette usavano il lessico a disposizione, che considerava il grasso come una degenerazione e il magro come civilizzato, per rappresentare sé stesse come dignitose e virtuose.
Di fronte alla propaganda antisuffragio, che le dipingeva come grasse e mascoline, anziché contrastare l’idea che il corpo abbia significato in termini di idoneità alla cittadinanza, hanno scelto di rifiutare le accuse autorappresentandosi come più belle e più snelle dei loro avversari.
Facendo un clamoroso salto dagli anni Venti agli anni Settanta, e lasciandoci a bocca asciutta per il lungo periodo compreso tra la Grande Depressione e il consumismo degli anni Cinquanta, Farrell prosegue l’analisi della triade grasso-cittadinanza-genere, spostandosi sulle posizioni del femminismo di seconda ondata. Anche quest’ultimo, pur avendo combattuto in prima linea il culto della magrezza ha finito per soccombervi
(le femministe) pur sapendo quanto le idee sul peso vengano esercitate proprio contro le donne, volevano evitare le connotazioni di una “volontà debole” e una primitività che la grassezza comportava. Per alcune di loro il corpo magro fu una strategia – e un “desiderio” – per mitigare la discriminazione e l’associazione a uno status inferiore in quanto donne.
L’ambivalenza del femminismo nei confronti del peso messa a nudo da Farrell non dovrebbe stupire, quanto piuttosto far riflettere su quanto sia profondamente radicata la vergogna che il grasso suscita e le discriminazioni che si porta dietro.
Fat Shame ha molti meriti e la sua traduzione, oltre a offrire un contributo in termini di consapevolezza e di conoscenza della fat shame e del fat activism, rappresenta un invito a rimboccarsi le maniche e approfondire il modo in cui la magrezza, il biancore e le idee di cittadinanza si sono intrecciate, non soltanto negli Stati Uniti.