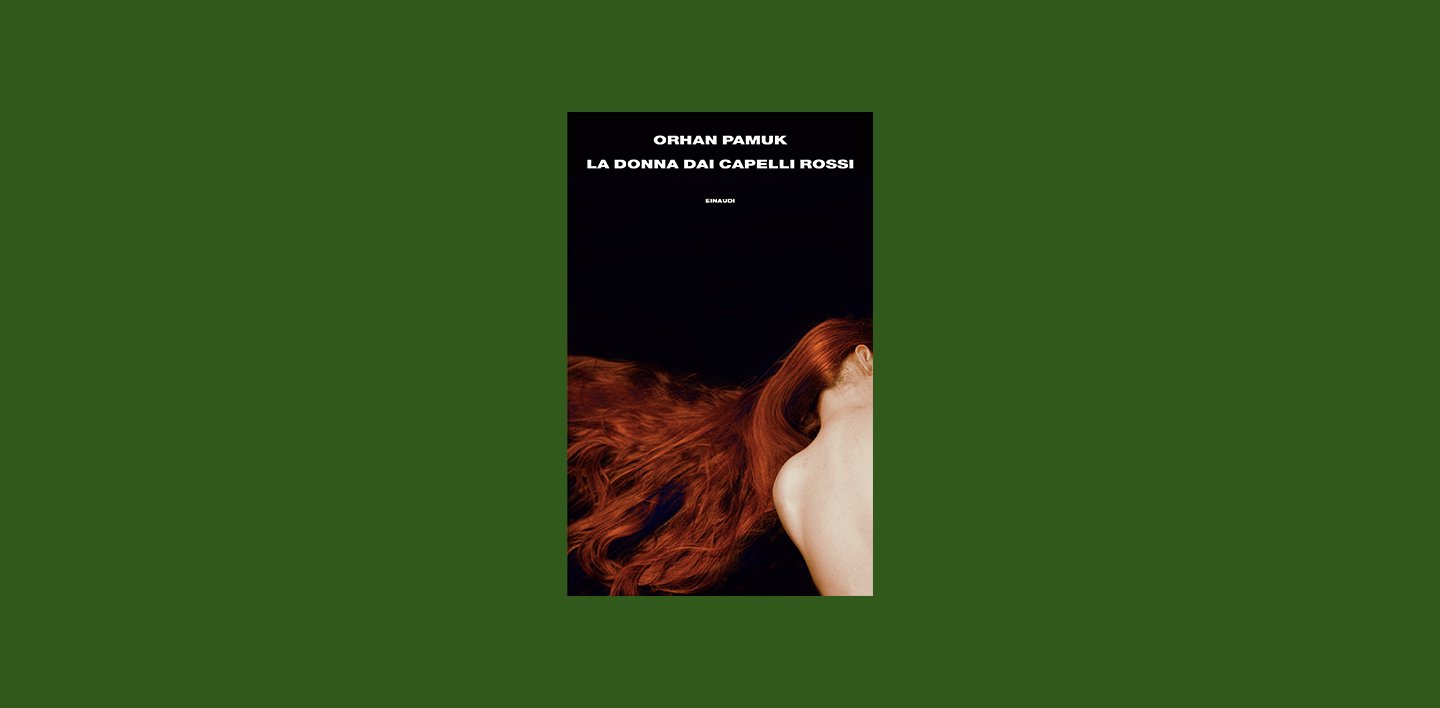
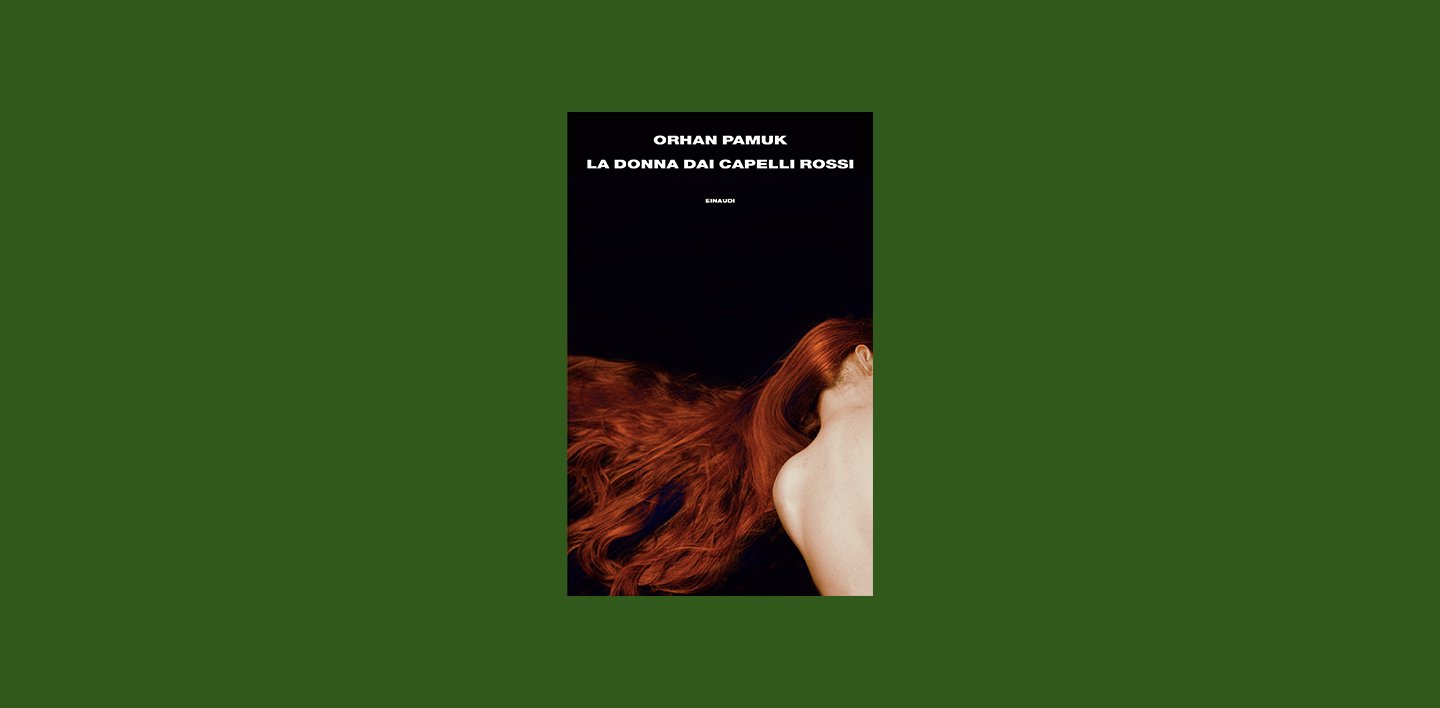
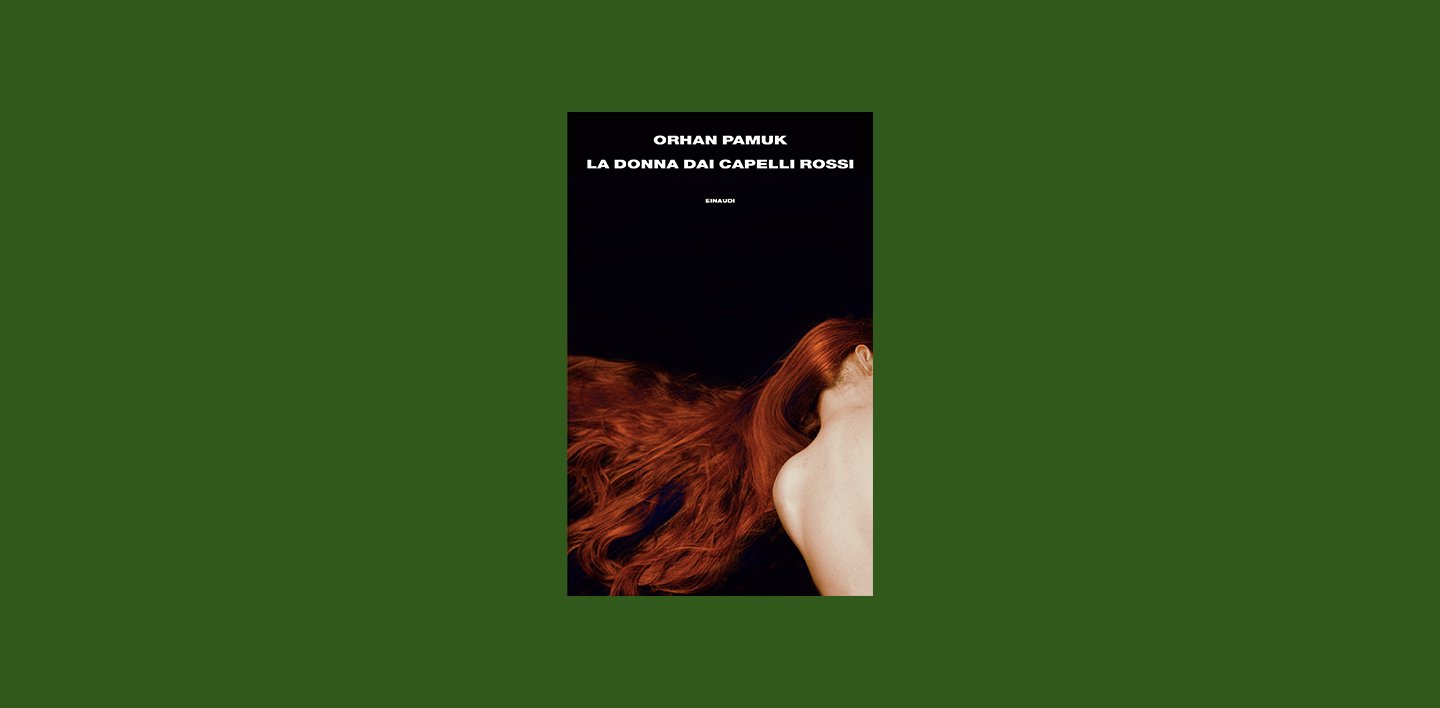
G iorgio Manganelli consigliava agli aspiranti romanzieri di iscriversi a geologia o ingegneria piuttosto che a lettere: ne avrebbero ricavato materiale utile a produrre buone metafore – così diceva, più o meno. L’ultimo romanzo di Pamuk inizia nel modo seguente: “Volevo fare lo scrittore. Ma, dopo i fatti che mi accingo a raccontare, sono diventato un geologo e un costruttore”. Il lettore scoprirà andando avanti che le cose non sono come sembrano: il narratore però, che in qualche maniera è diventato scrittore, ha tratto certamente beneficio (e belle metafore) dalla geologia e dall’ingegneria civile, come voleva Manganelli. Siamo tra la fine degli anni Settanta e i primi Ottanta, la periferia di Istanbul è ancora campagna e in quella campagna si muovono discretamente i pochi rappresentanti rimasti di un lavoro antico: gli scavatori di pozzi. Accanto a uno di questi ultimi rabdomanti il giovane futuro geologo trascorre un’estate come assistente.
Il padre è un militante marxista che ha conosciuto carceri e tortura, poi è scomparso non si sa bene dove né come. Il ragazzo, cresciuto solo con la madre, pur essendo di estrazione borghese deve contribuire al bilancio domestico e perciò finisce a lavorare come assistente scavatore. Scavare un pozzo senza trivelle è un lavoro duro, pericoloso e affascinante. La crosta terrestre mette a nudo la sua profondità stratificata, i tempi geologici riemergono dalla terra sotto forma di fossili, gas, minerali, e più si procede più l’impresa diventa rischiosa. Nulla garantisce che anche dopo trenta metri di scavo si troverà l’acqua, e affondare dentro un buco buio profondo come un palazzo di sei piani non è una cosa da poco. Una sera, dopo una giornata di intenso lavoro, il ragazzo rimane folgorato da un’attrice che recita in un teatro tenda dove si offrono spettacoli per i militari di stanza in una caserma del vicino paese.
Pamuk è oggi uno dei romanzieri viventi più letti e importanti: in questo libro sono presenti tutti gli ingredienti noti e apprezzati della sua poetica.
Entrare in contatto con quella donna significa addentrarsi in un circuito di eventi che lo porteranno molto lontano, verso il mito e in particolare verso la mitografia dei rapporti tra genitori e figli che attraversa in lungo e in largo la cultura occidentale e orientale. Il romanzo di Pamuk attinge a piene mani da questa tradizione narrativa, tra Edipo e il persiano Libro dei re, dove nel celebre episodio di Rostam e Sohrab, a differenza della tragedia sofoclea, è il padre ad ammazzare il figlio. Crescendo, il giovane diventerà sempre più ossessionato dal tema del parricidio e del figlicidio, raccoglierà immagini, documenti, ricorrenze del motivo nell’arte e nella letteratura, ne ragionerà insieme a una moglie con cui non riesce ad avere figli. Nel frattempo la città di Istanbul conosce quell’espansione anarchica e mostruosa che Pamuk ha raccontato in altri suoi libri, come nel precedente La stranezza che ho nella testa, e il paese dove il ragazzo ha incontrato la donna dai capelli rossi lascia il posto a un quartiere residenziale dove palazzinari senza troppi scrupoli fanno affari d’oro. Il ragazzo stesso, come già annunciato nell’incipit, diventato uomo si farà strada nella speculazione edilizia fino a interessarsi al terreno del vecchio pozzo.
Pamuk è oggi indiscutibilmente uno dei romanzieri viventi più letti (cosa per la quale non basta vincere il Nobel) e allo stesso tempo importanti, e in questo libro sono presenti tutti gli ingredienti noti e apprezzati della sua poetica: l’amore, la storia e la memoria, il collezionismo, la trasmissione dei saperi tra generazioni, i rapporti tra occidente e oriente. L’impressione tuttavia è che Pamuk, così perfettamente padrone dei propri strumenti, così abile nel costruire solide trame e forti connotazioni in racconti allo stesso tempo sentimentali ed eruditi, questo volta non sia del tutto all’altezza delle aspettative. La donna dai capelli rossi sembra meno ambizioso di altri suoi libri, o meno riuscito: non osa come Il libro nero, non coinvolge come Il mio nome è rosso, non è sentito e sofferto come il bellissimo e malinconico Istanbul, non impressiona e stupisce come il lavoro letterario-espositivo de Il museo dell’innocenza.
Certamente siamo di fronte a un romanzo sostanzioso e ben fatto ma la generosità di Pamuk nel maneggiare e rielaborare i grandi temi, le metafore narrative e le figure ancestrali dell’immaginario, sembra quasi andare da sé. Il virtuosismo con cui lo scrittore tiene insieme i diversi livelli del racconto conduce a qualcosa di fin troppo costruito: il rischio è che ciò che ha da dire vada a confondersi nella facilità con cui lo dice, che la motivazione si smarrisca nel mestiere. Insomma, si chiude La donna dai capelli rossi ammirati e lo si dimentica rapidamente. Sentiamo poco l’attrito, poca contraddizione, troppa fiducia nei propri mezzi, troppa immediatezza, manca quella tensione e quel rischio che pure sono così ben rappresentati nel lavoro antico e metaforicamente artistico dello scavatore di pozzi, e viene quasi da pensare che un romanzo del genere sia stato scritto con la mano sinistra, tra un impegno maggiore e l’altro. Con una doverosa precisazione, tuttavia: che per quanto minore o occasionale un romanzo di Pamuk si muove pur sempre nello stretto ambito dell’eccellenza.