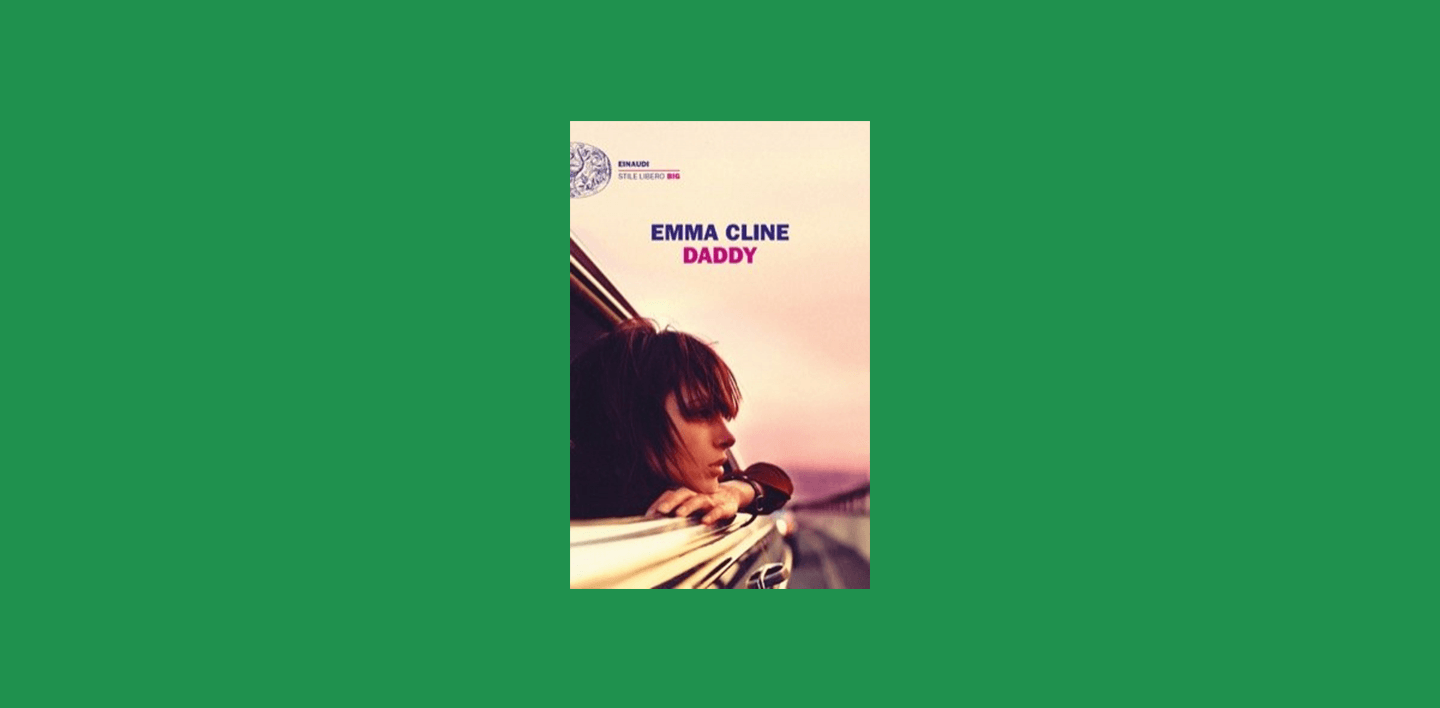
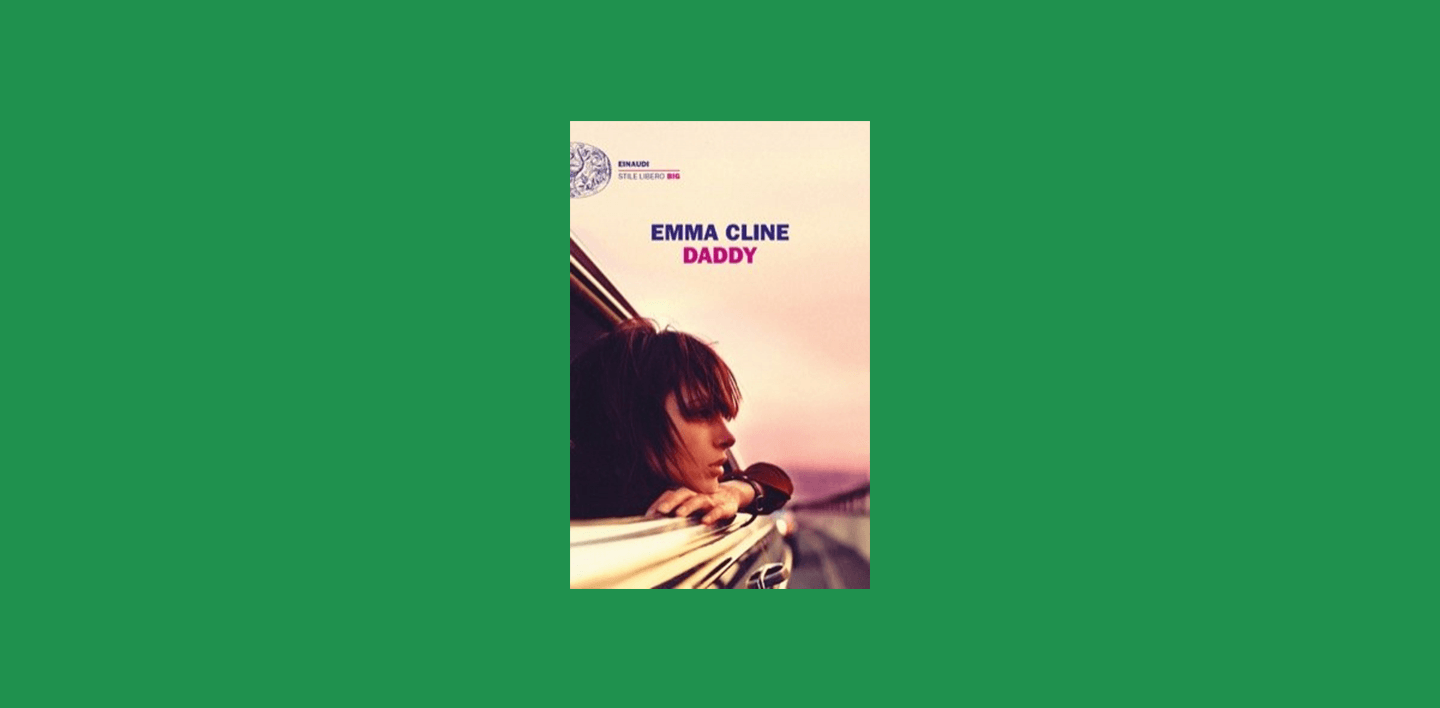
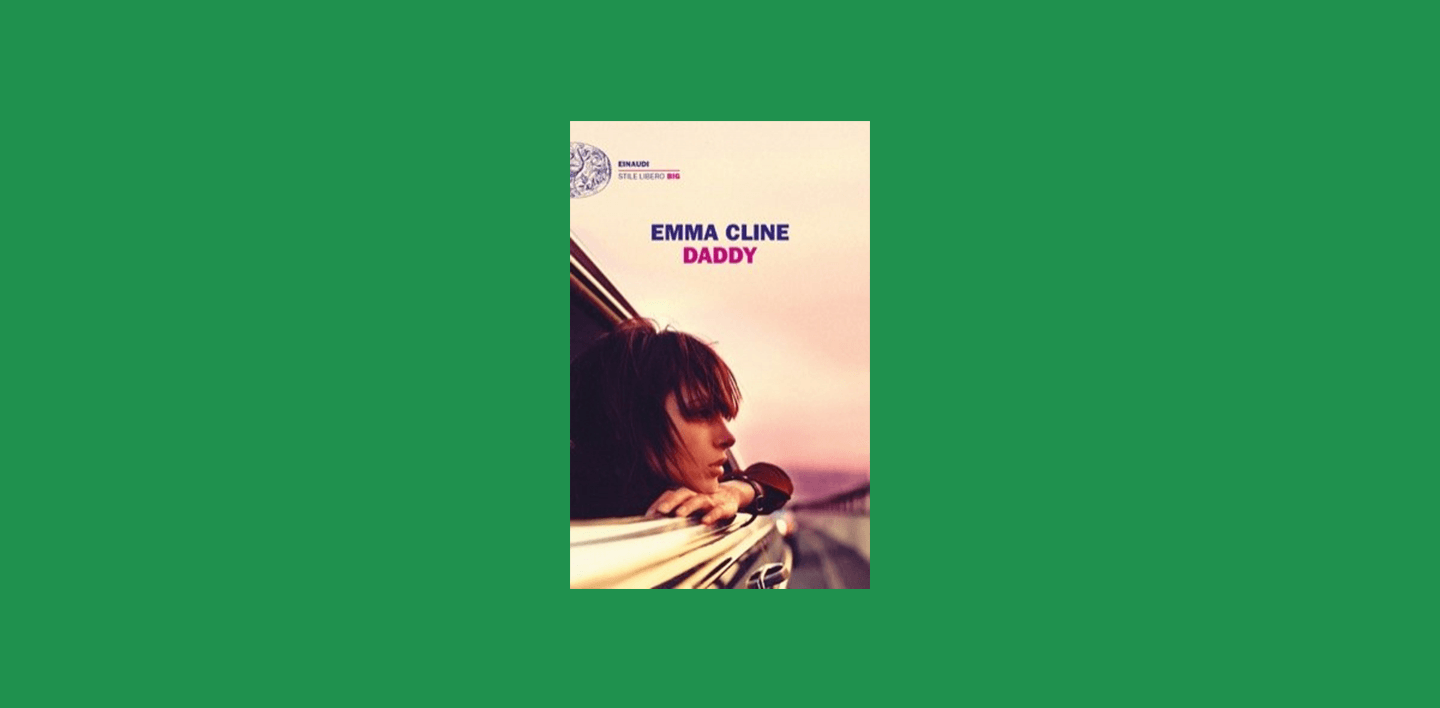
I n assenza di un oggetto d’affezione specifico, essere guardati è la cosa più simile a essere amati che mi viene in mente – è per questo che in Daddy (Einaudi, traduzione di Giovanna Granato), Emma Cline gioca con il nostro esibizionismo e con quello degli altri.
Guardami guardami guardami, dicono le protagoniste dei suoi racconti, vieni da papà, fanno eco gli uomini: ogni pagina uno spiraglio lasciato aperto intenzionalmente, un buco della serratura in cui due sguardi di incontrano per realizzare una fantasia. È come leggere Cappuccetto Rosso, ma con la protagonista che sa che sua nonna in realtà è un lupo travestito e il lupo che di fronte al suo desiderio non sa cosa fare.
Sembrava impossibile scrivere una raccolta di racconti sul #metoo mentre il #metoo stava ancora accadendo, ma in qualche modo Emma Cline ci è riuscita, forse perché quella è una storia più antica di quanto non siamo stati disposti a credere – e insieme meno risolvibile: è la storia del piacere, del consenso, della violenza, di quel pozzo senza fondo che sta al centro della vita e che ogni tanto si apre sotto ai nostri piedi e ci fa desiderare che ci vengano inflitte cose terribili. I racconti di Daddy assomigliano alle storie di Mary Gaitskill, ma con gli uomini spaesati di Szalay: sono, insomma, racconti su cos’è il desiderio oggi, su come non sappiamo cosa farcene.
Nel racconto che chiude il libro, A/S/L (una sigla usata nelle chat che significa age, sex e localization), una trentacinquenne finisce in una clinica di riabilitazione perché per troppo tempo online ha finto di essere una sedicenne che voleva essere istruita dagli uomini su cosa fosse il sesso: a ognuno di loro aveva inviato foto del suo seno e, se anche non assomigliava affatto a quello di un’adolescente, nessuno le aveva mai chiesto se era davvero una cheerleader, a conferma che il desiderio è il più potente degli autoinganni e che ognuno vede principalmente quello che vuole vedere – soprattutto quando è riprovevole farlo.
In Los Angeles, Oona, la collega di Alice, al lavoro indossa top microscopici e accetta di farsi fotografare dal marchio da cui è assunta in cambio non di soldi ma di altri vestiti; quando un giorno in negozio un uomo la blocca in un angolo, Alice la chiama con una scusa qualsiasi per permetterle di liberarsi, ma Oona si limita a riderle in faccia. “Questi uomini non le facevano né caldo né freddo, e spesso compravano una caterva di vestiti mentre Oona li faceva marciare verso la cassa come un’allegra infermiera volontaria”, del resto sono tutte vendite su cui ottenere una percentuale. Per arrotondare, o forse per noia, Oona vende mutandine usate a uomini che conosce online per sessanta o settanta dollari: le contrattazioni avvengono su internet, gli scambi nei parcheggi. “Non hai paura che faccia qualcosa di strano? Che so, che ti segua fino a casa?” le chiede Alice quando lo scopre, ma Oona risponde che le piacerebbe che qualcuno le facesse la posta. “Fare la posta” è una traduzione ben strana per l’originale e più connotato stalk (soprattutto in bocca a una diciassettenne), ma è comunque chiaro che Cline sta facendo qui quello che non molti altri autori sono disposti a fare: parlare di capitale sessuale e di come venga usato per provare il proprio potere o per mettersi deliberatamente in pericolo, anche quando la posta in gioco è troppo alta, e che in questo gioco delle parti le giovani donne hanno spesso la peggio senza sentirsi per forza solo delle vittime.
Dopo anni in cui siamo stati troppo spiazzati, imbarazzati per parlarne (la viralità di un racconto come Cat person mi pare più una prova di quanto spaesanti siano diventate le relazioni che un vero segno del talento di Rouperian), il sesso e il desiderio stanno timidamente tornando al centro delle nostre riflessioni: lo vediamo nella moda, lo vediamo nei saggi, lo vediamo persino nella nostalgia per American Apparel, il marchio non citato ma a cui allude chiaramente il racconto di cui sopra.
Che le immagini del brand di Dov Charney sessualizzassero eccessivamente o no corpi troppo giovani non è un vero argomento di dibattito, ma neanche qualcosa che ci è stato svelato all’improvviso, scuotendoci da un’ipnosi durata troppo a lungo: tutto il punto di AA era far sorgere il dubbio, titillare. Il brand permetteva di indugiare all’interno di quella incertezza, del desiderio, al limite tra il pericolo e il comfort, come se si trattasse solo di un gioco – e lo faceva attraverso il corpo dei suoi dipendenti.
In uno dei saggi Tonight I’m someone else, Chelsea Hodson scrive che durante i turni da AA lei e i suoi colleghi mettevano la musica a tutto volume, bevevano e fumavano nel magazzino; “eravamo attraenti, i fichi, quelli che venivano pagati due volte quello che pagava l’Urban Outfitters dall’altra parte della strada. Dovevamo essercelo meritato, pensavamo”. Anche se il negozio era sempre pieno, nessuno di loro era lì davvero per lavorare: passavano il tempo a vendere l’idea di giovinezza e di sesso che loro stessi impersonavano.
Non c’è nostalgia di quel mondo, che si limitava a reagire alla complessità delle diseguaglianze di potere con un’alzata di spalle, ma i racconti di Emma Cline si impegnano a recuperare quell’attrazione un po’ sconcia che avevamo messo da parte nel tentativo di fare chiarezza rispetto alle dinamiche entro cui viviamo, una sconcezza a cui ci siamo quasi disabituati, tanto che quando riappare sembra appartenere a un’altra era. Un esempio estremo è Marion (che non a caso risale al 2013 e che più di tutti ricorda le atmosfere di Le ragazze), la storia di due amiche di undici e tredici anni che passano il tempo in costume da bagno a guardare i ragazzi passare e sbirciano i Playboy nelle loro stanze; per loro il sesso è qualcosa di ipotetico e, insieme, una minaccia incombente. Quando Jack – che invece non è per niente un adolescente – gli racconta la storia di Polanski, la loro reazione non è di sgomento, ma di curiosità:
Una tredicenne. Ne parlammo molto, di come doveva essere stata quella ragazza, di come Roman Polanski l’aveva conosciuta, di com’erano andate le cose. Aveva le tette? Aveva già le sue cose? C’ingelosiva immaginare che il tuo ragazzo ti desiderasse al punto di infrangere la legge.
Leggere questo racconto ora è sconcertante, niente affatto liberatorio – la più grande ha solo tredici anni, è una bambina – ma del resto persino leggere Lolita oggi è un’esperienza diversa, o almeno credo.
Quello che intendo è che quando Daddy parla di #metoo non lo fa direttamente, ma che i suoi personaggi vivono e reagiscono in base a una sensibilità che è cambiata, che vivono nel mondo in cui viviamo, con tutte le sue contraddizioni. E ciò che è affascinante di Cline è che non sente la necessità di sgomberare il tavolo dalle ambiguità, ma che anzi obbliga chi la legge a restare in un punto in cui nessuno vorrebbe stare, a guardare, a subire pulsioni che vorremmo dirci aliene – anche in racconti meno estremi rispetto a Marion, che appunto forse è un’eccezione.
A leggere La bambinaia, la storia di una tata a servizio di un attore famoso che finisce a letto con l’attore famoso provocando uno scandalo, vengono in mente le vicende di Ethan Hawke o Jude Law, ma Cline è sempre attenta a non mimare troppo la realtà, a non fare fiction dai gossip, ma a raccontarne le dinamiche interne, le stesse per cui rispetto a queste storie proviamo un’attenzione un po’ morbosa. Alla ragazza del racconto insomma probabilmente era piaciuta più l’idea di conquistare il proprio capo, rovesciare la dinamica di potere, parteciparvi, che l’uomo in sé: con lui si era sentita desiderata allora come si sentiva ora che i paparazzi l’avevano costretta a rifugiarsi a casa di amici di sua madre, in attesa che la tempesta mediatica si calmasse. Mentre è là, per caso l’uomo a casa di cui dorme la vede seminuda e arrossisce, si sbriga a dirle che lei è più di questo scandalo, ma alla ragazza, come succedeva a Oona in Los Angeles, probabilmente viene da ridere, perché c’è una parte di lei che gode nel vedere un uomo grande e grosso che non sa come reagire, che si dimena nel suo imbarazzo:
se non altro aveva rinunciato all’idea di farle la paternale. Di convincerla che quella storia aveva qualcosa da insegnarle. Non era così che andava il mondo e non era un po’ tragico che Dennis ancora non lo sapesse?
Ecco, forse è questo il punto di tutto Daddy, che non ci sono punti, lezioni dell’esperienza, che se dobbiamo sperare in qualcosa è nella continua e infinita complessità delle interpretazioni, che tutte le storie che abbiamo sentito in questi anni ci insegnino a trarre meno lezioni e a fare più distinguo, non perché siamo di fronte al rischio della storia unica (buffo ma neanche paradossale come quella talk di Chimamanda Adichie sia diventata la storia unica sulla storia unica, come ci piacciono le interpretazioni semplici!) ma perché esplorare il desiderio significa aprire la porta alle contraddizioni, ai mostri, a tutto quello che non è semplice. Mentre leggevo La bambinaia mi sono chiesta se avessi mai sedotto qualcuno per pura noia o solo perché potevo: Daddy ci invita a porci queste domande e ad accettarne la risposta. Come dicevo prima, Daddy non è Secretary di Mary Gaitskill o un libro di Bret Easton Ellis in cui tutti sono orribili, è piuttosto un libro in cui tutti sono orripilati da quello che potrebbero fare, se solo fosse permesso, se solo non ci fossero conseguenze.
Harvey, la novella di Cline uscita come libro a sé lo scorso autunno, parla proprio di questo: di cosa saremmo in grado di fare, se non dovessimo mai confrontarci con le conseguenze delle nostre azioni. Il racconto si concentra sul giorno prima del processo contro Weinstein: confinato in Connecticut, un Harvey ancora sicuro di scamparla si fa istruire dallo staff su come apparire patetico a sufficienza all’udienza (un deambulatore, vestiti che cadono male) da conquistarsi il benvolere del giudice. Con la schiena a pezzi e le figlie che lo odiano ottenere quell’effetto è piuttosto facile – mi pare sia stata Joann Wypijewski, l’autrice di What We Don’t Talk About When We Talk About #MeToo, ad aver detto che una delle ragioni che avrebbe portato alla rottura dell’omertà nei suoi confronti è che Weinstein è stato un cattivo patetico, un abusatore creepy di cui si è derisa la forma fisica.
In Harvey, il Weinstein di Cline ricorda un episodio avvenuto in Giappone che coinvolgeva quella che, a suo avviso, era un’assistente troppo schizzinosa: “quando lui l’aveva circondata con un braccio si era ritratta, rincattucciandosi sulla panca. L’avevano lasciata nel locale, così, per scherzo. Per come la ricordava lui.” “Per come la ricordava lui”: Harvey è un uomo la cui visione del mondo non è mai stata messa in discussione – che sa che ogni persona ha un punto di rottura, basta insistere. “Tutto stava nello stabilire quanto ci sarebbe voluto, come sarebbero stati quegli istanti fra la pretesa di lui e la capitolazione di lei”. “E alla fine era sempre soddisfatto, mentre l’altra persona annaspava”, fin quando questo non smette di accadere, arriva il conto da pagare e Harvey Weinstein è solo un uomo che sta per finire in prigione e che pensa che il suo vicino di casa sia il grande scrittore Don De Lillo. Cline lo immortala così, un produttore che pensa di riscattarsi traendo un film da Rumore bianco (buffo, ma a quanto pare accadrà davvero) e che si illude di sfuggire alla giustizia. C’entra e non c’entra, ma a febbraio è uscita di prigione Anna Delvey, la ragazza che si era finta un’ereditiera tedesca raggirando l’alta borghesia newyorkese (a proposito di fantasie e autoinganni), e per prima cosa ha dedicato una lunga lettera a Weinstein. Una straordinaria testimonianza del lato oscuro: “Non lo detesti quando le persone provano a essere tue amiche? Quando si comportano in modo così fottutamente comprensivo, come se potessero capire la tua vita costruita su pilastri di nichilismo e amoralità? Come se avessero anche solo una remota idea di quanti sacrifici e scelte difficili ci sono voluti per diventare quello che sei ora?”. Delvey sta scrivendo un libro e se fossi un editore lo comprerei oggi stesso.
Se le sta scontando anche Weinstein, figuriamoci cosa ne è delle conseguenze per le persone normali. E infatti se in Daddy non accade mai niente, è solo perché tutti si obbligano all’inazione. Sarà la California forse, l’atmosfera di lenta e implacabile decadenza delle cose (nel racconto Arcadia ci sono persino i frutteti, l’azienda lasciata in mano a due fratelli, e se non apparisse un sito internet potrebbe benissimo essere ambientato negli anni ’70) ma sembra di leggere un libro di Joan Didion, uno a cui però sono stati tolti gli avvenimenti salienti, in cui tutto stava per accadere oppure è accaduto ma non è poi così grave. È un libro di atmosfere e di non sequitur: in Northeastern Regional il figlio del protagonista viene cacciato dalla scuola esclusiva che frequenta a seguito di una non meglio specificata rissa, ma potrà comunque andare all’università, in Menlo Park un produttore invita un autore a scrivere le sue memorie, ma poi per vari motivi lo licenzia, dandogli però un cospicuo assegno. Se l’assenza di eventi significativi non intacca la qualità della raccolta, che è mediamente alta, è forse perché quest’inconsequenzialità è la caratteristica intrinseca del presente in cui viviamo, la ragione per cui vogliamo tutti essere visti e vogliamo vedere tutto, nella speranza che qualcosa prima o poi accada e che sia abbastanza forte da dare senso alla confusione che ci portiamo dentro.