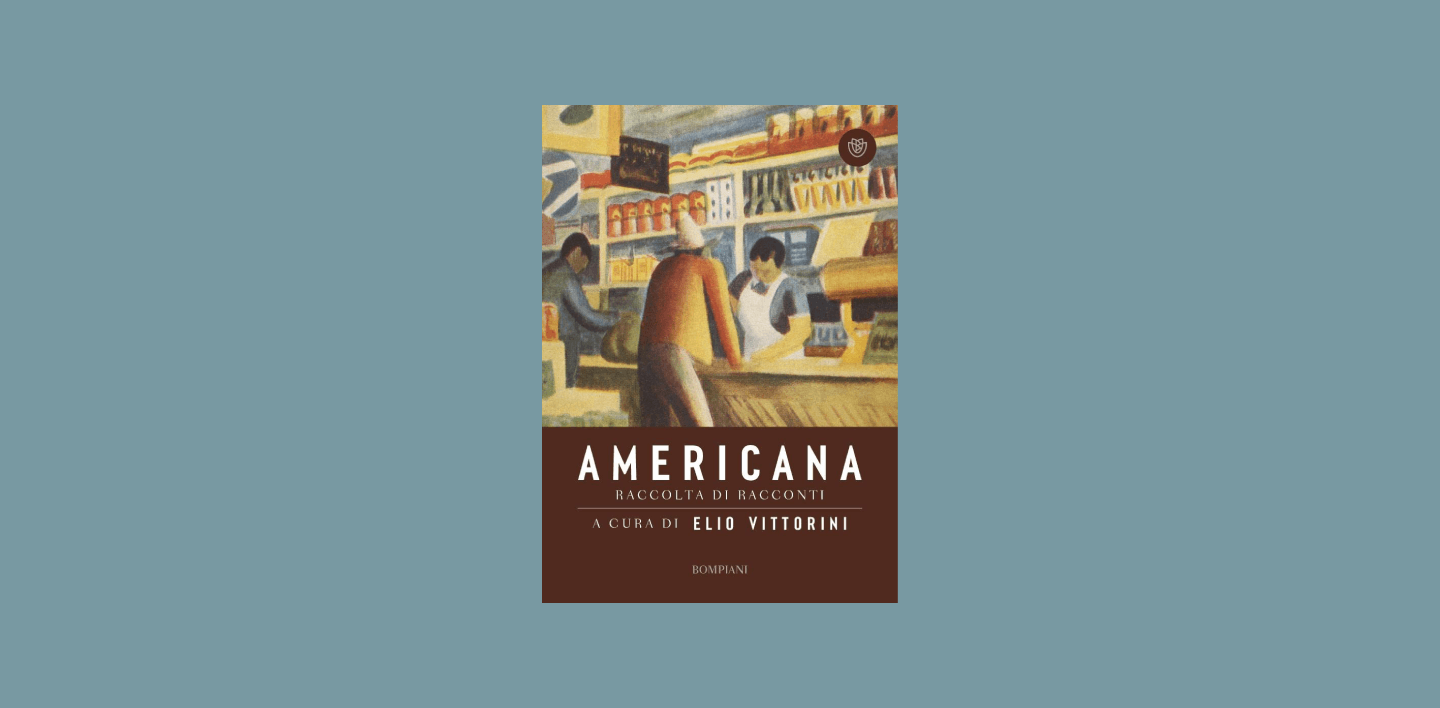T
utti i libri fortunati si assomigliano ma ogni libro sfortunato è fortunato a modo suo. È questo il caso evidente dei pochissimi romanzi di Kafka pubblicati in vita, del Gattopardo rifiutato dall’Einaudi di Vittorini o dell’Americana, la leggendaria antologia voluta da Valentino Bompiani e curata proprio da Vittorini, prima condannata dalla censura fascista e poi, dopo mesi di estenuanti trattative, presentata per la collana Pantheon all’inizio degli anni Quaranta presso lo stesso editore milanese. Una pubblicazione che oggi viene rieditata, a cura di Giuseppe Zaccaria (Bompiani, pp. 1290, 30 euro), con una splendida appendice, arricchita dalle lettere che ne accompagnarono il travagliato processo di pubblicazione che merita d’essere raccontato.
Sarà infatti proprio l’Americana a rappresentare in Italia l’opera attraverso la quale gli italiani poterono conoscere quegli Stati Uniti che poco prima s’erano impegnati a combattere; come se scoprendo la letteratura americana si fosse davvero riscoperta l’America. L’Hudson e i tubi di scappamento, il Kansas e il bridge venivano raccolti per la prima volta nei racconti di trentatré firme del nuovo mondo. Da Melville a Faulkner, da Poe a Twain passando per Hemingway e Fante, tradotti in italiano da dieci autori, tra questi Pavese e Montale, Piovene e Moravia.
Tutto comincia nel 1938 quando Valentino Bompiani scrive a Elio Vittorini. Ha appena letto una recensione apparsa su Terre Basse di un volume di Turpin e vuole sondare la disponibilità dello scrittore siciliano ad occuparsi della sua traduzione. Intanto, Pavese ha appena tradotto lo stile canagliesco dello Steinbeck di Uomini e Topi e Montale si appresta alla traduzione di In Dubious Battle (La battaglia), seguiranno le traduzioni di Budd e Hawthorne. Emilio Cecchi, già nel ‘31, si era occupato di Poe e Melville rimanendone talmente colpito da arrivare a scrivere sulla rivista L’italiano che chiunque avesse cercato altrove avrebbe certo perso tempo. È questo il clima in cui gli intellettuali e gli accademici riescono a leggere, non senza difficoltà, la nuova letteratura americana. La passano di mano in mano, l’aspettano, la contendono.
Serve allora qualcuno che cominci a raccogliere quel mondo, qualcuno che quella letteratura la comprenda davvero, che la sistemi, che la parli. Perché la letteratura, per essere amata, deve essere anche parlata. Principia in quel momento il proposito dell’antologia Americana cui lavorerà instancabilmente, per conto di Valentino Bompiani, Elio Vittorini. Ha da poco pubblicato Conversazione in Sicilia, la storia di un viaggio di ritorno che ha tutto dell’archetipico. E, proprio di ritorno da questo viaggio letterario, Vittorini comincia a collezionare; a raccogliere, a incaricare amici scrittori delle traduzioni dei nuovi narratori americani. Suggerisce a Bompiani di leggere The Chute di Albert Halper e poi si lancia su Tortilla Flat, vuole tradurre anche lui Steinbeck di cui apprezza particolarmente il picaresco Red Pony. Sarà però Gadda Conti, cugino dell’ingegnere, a tradurre La quaglia bianca, l’unico racconto di Steinbeck presente in quell’antologia che lentamente prende forma. Nel frattempo il Ministero della Cultura Popolare guidato da Pavolini nega ogni pubblicazione del Caldwell de Il piccolo campo, stessa sorte toccherà alla ristampa di Furore “incompatibile con le nostre idee e col nostro costume”.
Come se scoprendo la letteratura americana si fosse davvero riscoperta l’America.
I tempi si fanno pesanti ma l’Editore sceglie di andare avanti e, sia pure con le tante interferenze, l’antologia si va completando. Giansiro Ferrata traduce Henry James, Moravia Lardner, Pavese Stein, Linati e Vittorini portano Hemingway in un italiano un po’ edulcorato. Montale, che intanto aveva espunto “due spiacevoli allusioni all’Italia e ogni accenno al comunismo” per La Battaglia di Steinbeck, traduce Wakefield – la più bella novella di Hawthorne –, poi riporta in lingua con un titolo assolutamente personale: L’uomo che corruppe Hadleyburg di Mark Twain, traduce Fitzgerald e il Billy Budd di Melville, più probabilmente tradotto dalla segreta interprete Lucia Rodocanachi, la gentile signora di Gadda, traduttrice di molte pagine inglesi per il Montale lontano dal Gabinetto Viesseux.
Le traduzioni sono ora completate e l’antologia è pronta. Ma, come ogni storia che si rispetti, anche questa porta con sé le sue attese, e proprio quando tutto è finito e la macchina comincia a girare le copie dell’antologia vengono ritirate in fretta. È la dimostrazione che quella letteratura mostra la faccia di un paese che non può più essere mostrata. L’Italia è pronta ad entrare in guerra e l’America è appena divenuta cappio e nemico. Il Ministero ribadisce: “per ogni ristampa di opere e autori stranieri è indispensabile ottenere la preventiva autorizzazione”. Vittorini corre al riparo e, dopo aver parlato “con tutti i medii calibri: tutti persuasi, tutti d’accordo”, scrive all’Editore Bompiani che Emilio Cecchi è “pronto a sostenermi”. Non basta. Vittorini incassa, avvicina il fratello del Ministro Pavolini che intanto si era espresso sull’opera invitando a non “usare delle cortesie all’America, nemmeno letterarie”. Arnaldo Frateili, autore Bompiani e responsabile della pagina culturale di Tribuna, scrive allora ad Amedeo Tosti a capo della Divisione libri del Ministero, riporta il volume sul tavolo del Ministro. È un lumicino. Pavolini è risoluto a non incoraggiare “la ventata di eccessivo entusiasmo per l’ultima letteratura americana”. Passano nove mesi e il 2 ottobre del ’41 Pavolini riscrive a Bompiani: per l’uscita dell’Antologia bisogna che Vittorini si faccia da parte, serve un’introduzione “dell’Eccellenza Cecchi”, accademico d’Italia (ma anche firmatario del manifesto degli intellettuali antifascisti!).
Il 20 marzo 1942 Cecchi consegna le bozze dell’introduzione che rimpiazza quella di Vittorini, firmerà anche la “specie di antologia critica” che sostituirà tutti i corsivi introduttivi di Vittorini mal sopportati dalla censura (“inopportuni al momento attuale”). Reso il testo più simile a un saggio che non a un’antologia il volume ha buone possibilità di riuscire. Si sceglie una frase da apporre sulla ‘fascetta’, la pensa Pavolini in persona e Bompiani non può che accettare. Licenziata l’introduzione, espunti i corsivi di Vittorini e apposta una fascetta incomprensibile (“Trent’anni fa era stato abdicato all’ineffabile dell’anima slava; ora si abdicava a un ineffabile dell’anima americana. Ed incominciava un nuovo baccanale letterario”), il libro ottiene l’imprimatur dal Ministro che intanto chiede i dettagli sulla redazione di un nuovo volume da dedicare ai Narratori Tedeschi, quasi – davvero – la guerra non fosse che un gioco. Intanto, gli italiani hanno cominciato a leggere l’antologia, e divorano l’America per quel che è con tutto il peso delle sue contraddizioni, quelle stesse incoerenze che il fascismo – attento più all’accento che non al senso delle parole – neppure aveva compreso.
Leggendo Americana ritroviamo l’America fuori dalle sue pagine, nel pieno convulso della sua contraddizione.
L’Americana non era infatti una raccolta di autori, ma rappresentava quel viaggio mai fatto da Pavese e Vittorini: America siderale, l’America nel tempo dell’America, degli emigranti e del ferro. L’America di Faulkner: un po’ vittoria un po’ delusione, un po’ leggenda (Whitman) un po’ contraddizione (Hawthorne). Del resto – e questo forse Cecchi lo aveva capito – da “una civiltà che ha come postulato supremo il benessere era ovvio potesse nascere soltanto un’arte di disillusioni”. E, infatti, l’Americana è anche disillusione: una confessione durissima, più terribile della Medea e del Re Lear. Non è allora vero che una raccolta di testi stranieri, resi “attraverso una traduzione d’arte”, possa acclimatarsi perdendo “le accidentalità e i veleni esotici”. Pure nelle lingue imperfette in cui è riportata dai suoi traduttori l’Americana è velenosa, è davvero – forse – il superamento della letteratura ermetica (come bene coglie Pavese).
Dobbiamo immaginarli: un gruppo di giovani prende a tradurre quanto fatto al di là dell’Atlantico, scoprendo non “un nuovo inizio della storia” ma il teatro in cui, “con maggior franchezza, veniva recitato il dramma di tutti”. È in questo senso che il libro diviene, più che un’opera antologica, un romanzo unico; solo corredato dalle note di Vittorini, dai suoi astratti furori. È questo il racconto di un’America fatta di terra: immensa ma non infinita. Quella terra che non può essere utopia per il desiderio ostile, e americano, d’essere continuamente tutto il mondo. Eccola tradotta, l’America di conquista che ancora serba nel cuore l’idea vaga di un ovest immaginario, di un Seicento di uomini lupi pronti ad ammassare grano, ad uccidere uno schiavo, non avendo – con Hemingway – il coraggio di chiamarlo “negro”. Ed ecco Melville o la giustizia, “la simmetria formale che si può raggiungere in una novella di immaginazione”, la libertà di Gordon Pym, il divertimento e il terrore di un Faulkner che in America si può trovare, in natura, “così bell’e pronto”.
Leggendo Americana ritroviamo l’America fuori dalle sue pagine, nel pieno convulso della sua contraddizione, e i suoi protagonisti diventano compagni di viaggio, e le sue storie, le sue follie, una mai scalata verità. “Wakefield non è pazzo” ora lo sappiamo. E proprio come lui, come ce lo traduce Montale, riattraversiamo noi la strada: “incastrati in un sistema; e in sistemi così connessi l’uno agli altri in un tutto… scivolando via per un attimo al rischio di perdere il nostro posto per sempre”. Con un occhio vigile, beninteso, cercando – per quanto possibile – di non cadere più nei “multiformi pericoli dell’inflazione americana”.