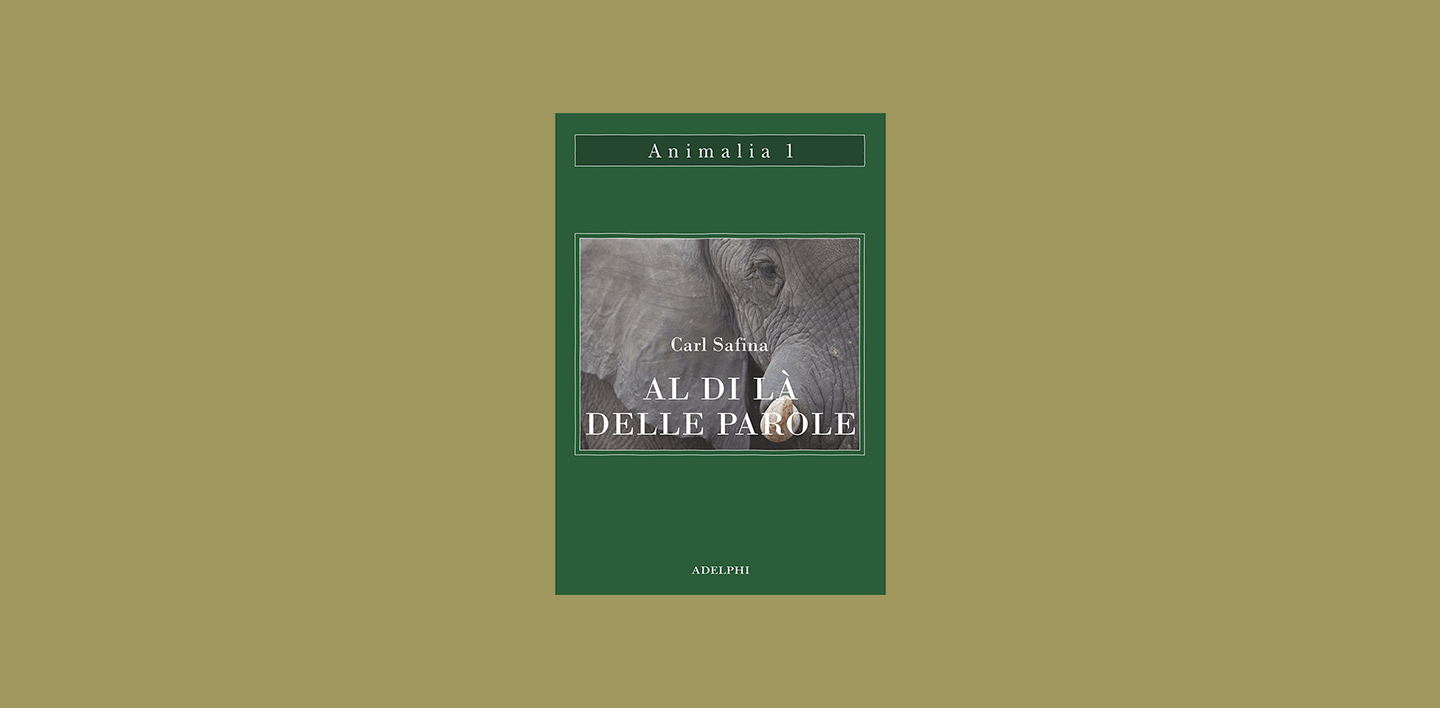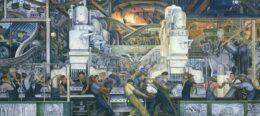E
cho era facile da riconoscere: aveva un’andatura maestosa e due lunghe zanne che quasi andavano a toccarsi alle estremità. Era la matriarca di una delle famiglie di elefanti che meglio abbiamo potuto osservare e studiare, se non altro da quando abbiamo iniziato a non considerare questa specie come mera attrazione per il circo o come fonte di avorio per palle da biliardo e tasti di pianoforte. Lo studio della sua vita iniziò nei primi anni Settanta e proseguì ininterrotto fino alla sua morte, nel 2009. A 65 anni, Echo era ancora una regina saggia, forte, in grado di garantire sicurezza e protezione a tutta la sua stirpe. Nel cuore del parco nazionale di Amboseli, in Kenya, l’epopea dell’elefantessa Echo ha mostrato al mondo la vera indole dei giganti della savana: animali dotati di profonda intelligenza, empatia, sensibilità. Probabilmente ben consci dei concetti di vita e di morte e perfettamente in grado di distinguere le emozioni che passano per la testa non solo dei loro simili, ma anche degli esseri umani che entrano in contatto con loro.
Inizia con la storia di Echo Al di là delle parole dello scrittore – e biologo – Carl Safina, da poco pubblicato per i tipi di Adelphi, primo numero della nuova collana “Animalia”. Pur trattandosi di un libro molto recente, Al di là delle parole si è inserito di prepotenza in un filone di opere di divulgazione dedicate allo studio del comportamento animale, in compagnia di mostri sacri come Konrad Lorenz (L’anello di re Salomone), Nikolaas Tinbergen (Naturalisti curiosi), Edward O. Wilson (Sociobiology) e delle più recenti opere dell’olandese Frans de Waal. Meno scientifico dei classici del comportamento di Donald R. Griffin, John Alcock o Robert Hinde, meno empirico di Jane Goodall o dei nostrani Mainardi, Celli e Alleva, Al di là delle parole punta molto sul grande talento narrativo dell’autore, è un sorprendente mix di approfondimento ed emozionalità, di studio scientifico unito a una prorompente forza descrittiva. Ed è questo quello che rende questo libro così sorprendente: invece di non lasciarsi andare all’emotività per preferire il rigore scientifico, Safina cerca di essere sia scientifico sia emozionalmente coinvolto perché alla fine sì, noi siamo animali, e con alcune specie condividiamo abilità cognitive ma, soprattutto, la capacità di provare sentimenti.
Siamo ossessionati dal proposito di riempire lo spazio bianco nella frase: “A renderci umani è ________”. Ma perché? Basta grattare un po’ la superficie di quell’ossessione, e dare un’annusatina, per avvertire una zaffata di qualcosa che potrebbe star bene in quello spazio bianco: la nostra insicurezza.
Lasciati gli elefanti del parco nazionale di Amboseli, la narrazione di Safina ci porta virtualmente in compagnia di animali forse altrettanto iconici ma completamente differenti sul piano sociale e comportamentale: i lupi del parco di Yellowstone. Scomparsi per quasi 70 anni e reintrodotti soltanto nel 1995 nell’area protetta, i lupi hanno rapidamente riportato equilibrio al suo ecosistema: hanno predato i cervi che, fino ad allora, erano prosperati in numeri insostenibili, rendendo aride e prive di vegetazione ampie aree del parco. Con meno cervi la flora si è rinforzata, sugli alberi sono tornati gli uccelli canterini e si sono rinvigorite le popolazioni di anfibi e rettili nel sottobosco. Poi i castori hanno ricominciato a tagliare gli alberi e a creare le loro dighe, e dei nuovi specchi d’acqua hanno tratto giovamento anche i pesci. Tutta questa rinascita si è avuta grazie al rientro sul territorio di un’unica specie, il predatore primario dell’ecosistema. E la tutela di questo animale ha comportato anche lo studio dei singoli esemplari, come il leggendario maschio alfa Twenty-one, fortissimo e imbattuto dai suoi rivali ma che ha sempre dimostrato compassione e rispetto per gli avversari, o Seven Fifty-five, la cui vita fu profondamente cambiata dalla morte del fratello e della compagna, ma che mai si diede per vinto. Animali coraggiosi, intelligenti e, come osserva lo stesso autore, “dannatamente tosti”. I lupi, con la loro forza ancestrale, ci portano a interrogarci su quali possano essere stati i passaggi che hanno portato una specie così potente ad adattarsi agli ambienti umani al punto da diventare nostri amici e complici.
Dopo una breve parte dedicata a ridimensionare la “teoria della mente”, che per Safina significa tutto e niente al punto da dover essere superata nel nostro modo di rapportarci al mondo animale, la quarta e ultima sezione del libro è dedicata a una specie, tutto sommato, abbastanza imprevedibile: l’orca. Certo, tutti noi conosciamo la grande intelligenza dei cetacei e dei delfini in particolare, ma stupisce vedere un animale, storicamente considerato un feroce predatore di foche e piccoli di balena, come un’entità con cui immaginarsi in sintonia. Eppure, dagli studi sui pod di orche del Pacifico nordoccidentale emergono prepotentemente i tanti punti in comune con la nostra specie: l’esistenza di popolazioni con comportamenti totalmente differenti (forse potremmo azzardarci a parlare di “culture”), l’impressionante capacità di comprendere le intenzioni degli uomini, la curiosità, la sensibilità, la socialità. È veramente difficile non provare dolore per le vicende di Luna, un giovane maschio rimasto solo, che cercava disperatamente la compagnia umana e curiosava in prossimità di pescherecci e banchine, o per il dramma degli esemplari catturati e allontanati dalle loro famiglie per diventare attrazioni dei parchi acquatici. E rimane il grande mistero di come un animale così potente, in grado di lanciare in aria per decine di metri una foca da un quintale, non abbia mai aggredito un essere umano in mare aperto, ossia nel suo naturale ambiente di predazione.
L’esperienza come ricercatore di Safina e di vari altri scienziati di cui sono riportate le testimonianze è il vero punto di forza di Al di là delle parole: per capire che cosa pensano e cosa provano gli animali è assolutamente necessario aver passato tanto tempo vicino a loro, osservando le loro interazioni e le loro esperienze di vita, possibilmente nel loro ambiente naturale. E così come diventano cruciali ai fini della narrazione le storie di Echo l’elefantessa, di Twenty-one il lupo e di Luna l’orca, si entra allo stesso modo in sintonia con Cynthia Moss, Rick McIntyre o Kenneth Balcomb, quei tenaci scienziati che per decenni hanno osservato sul campo questi animali e le loro famiglie: hanno gioito delle loro conquiste e dei loro successi, hanno sofferto delle avversità che hanno dovuto affrontare, hanno pianto i loro stessi lutti. Alla fine, senza le loro testimonianze, gran parte delle nostre conoscenze sul comportamento di queste specie sarebbe molto più superficiale.
La narrazione di Safina è coinvolgente perché in gran parte personale, al punto da essere apparentemente poco scientifica, quasi romanzata. Ma questo aspetto rivela un grande talento nel trasferire conoscenza e, nel contempo, far provare emozioni forti al lettore. Ed è questo il vero punto di forza del libro, che scorre con leggerezza per tutte le sue quasi settecento pagine. E fa perdonare all’autore qualche ammiccamento (appena accennato, per carità) alle presunte capacità telepatiche delle orche, oltre a qualche sua conclusione personale basata su semplici aneddoti. Ma si tratta, in definitiva, di difetti assolutamente trascurabili nell’economia complessiva del lavoro.
Alla fine la parola chiave della riflessione di Safina è, senza ombra di dubbio, “empatia”: capire che cosa provano gli altri. Una prerogativa tutt’altro che esclusiva del genere umano, come emerge a più riprese nel libro. E così il messaggio finale di Al di là delle parole è proprio questo: noi umani dobbiamo imparare a sviluppare empatia per gli altri animali e per il loro modo di vivere, di comunicare, di provare emozioni, di essere coscienti. È un atteggiamento che dovrebbe essere presente nelle vite di tutti noi, per aiutarci a compiere le scelte giuste per una convivenza più equilibrata con gli altri esseri viventi che con noi condividono il viaggio sul pianeta Terra.