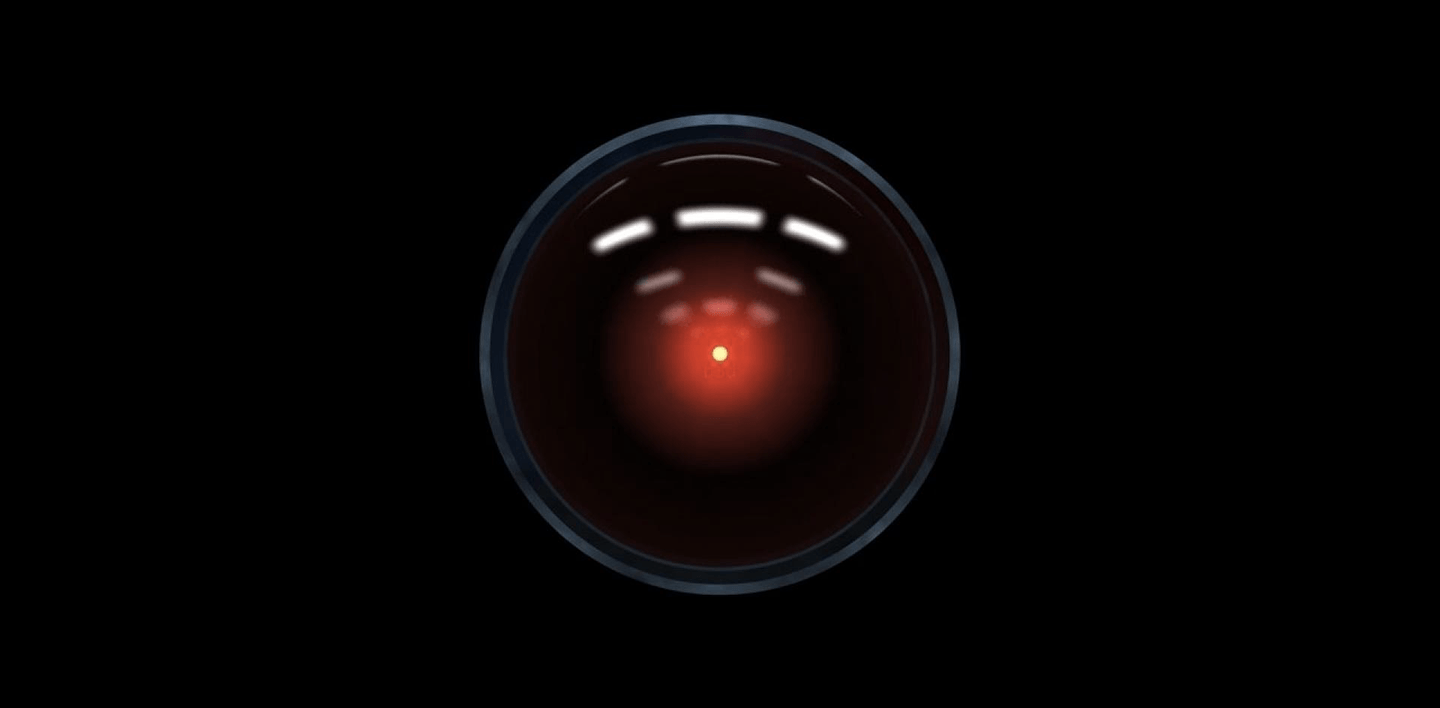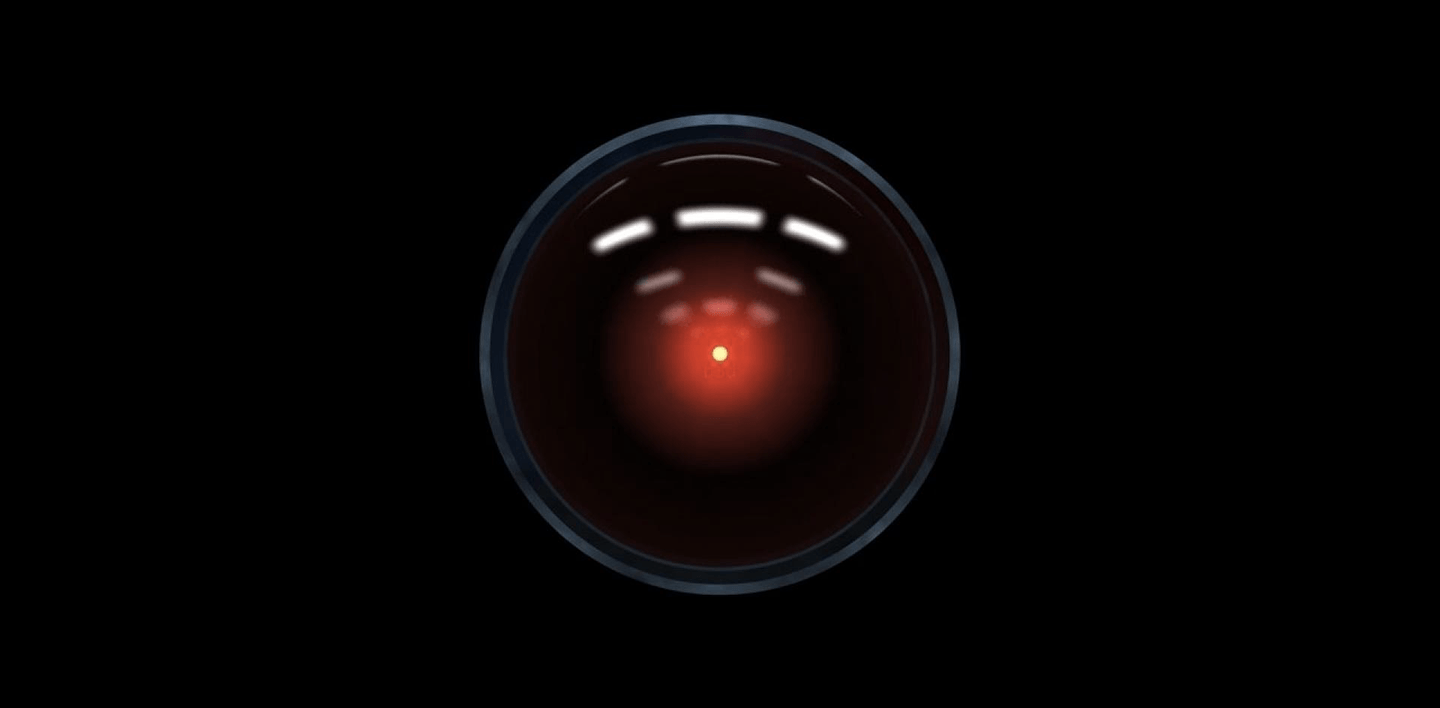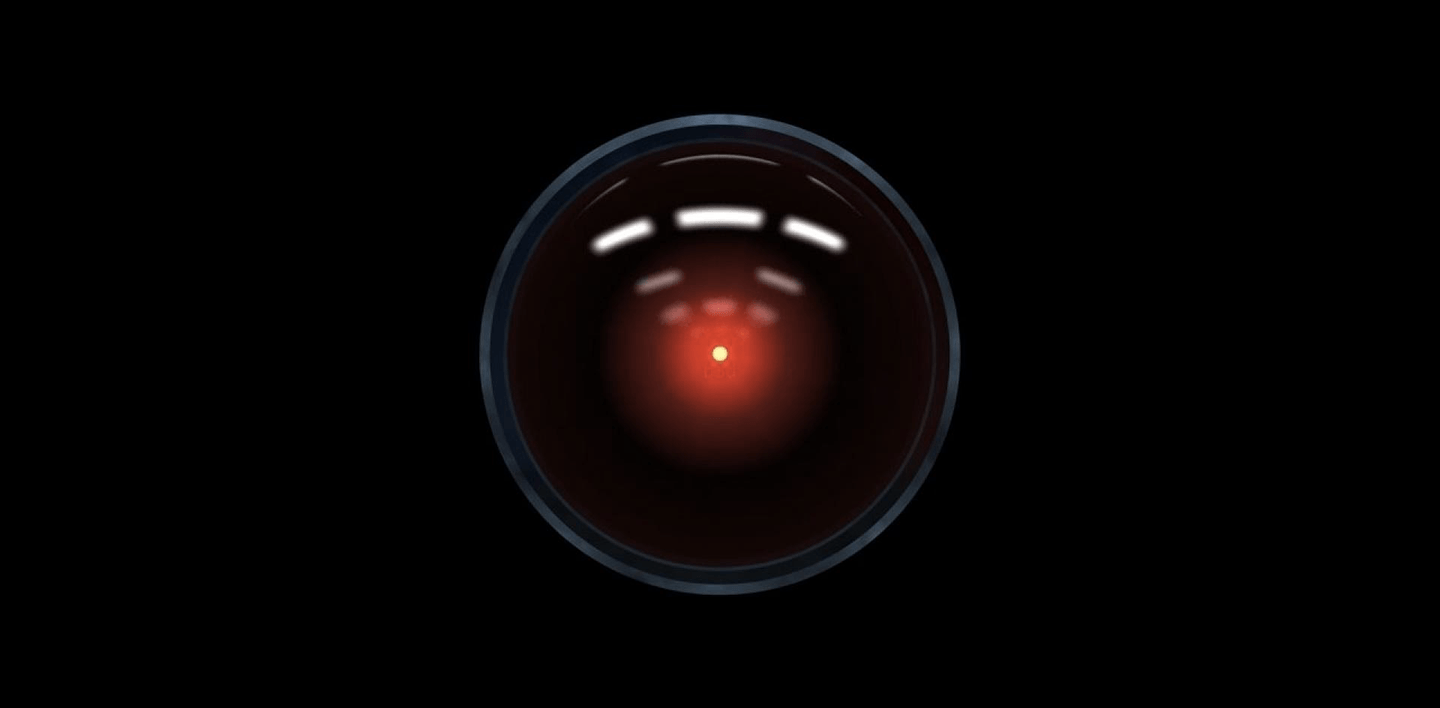U
na delle immagini mentali più potenti che ho di Londra è relativamente recente, nonostante una frequentazione di lunga data con la capitale britannica: un cielo notturno zeppo di palloni di sbarramento. Erano strumenti bellici, aerostati ancorati al suolo tramite cavi, usati per scoraggiare i pericolosi attacchi a bassa quota della Luftwaffe durante la seconda guerra mondiale. Naturalmente non è un ricordo di prima mano, ma una sintesi di scene rubate a una puntata – stranamente inquietante (The Empty Child, 2005) – della stagione con cui la BBC ha rilanciato il telefilm Dr Who. Ed è proprio su una ferita inflitta alla città da un bombardamento nazista che nasce il Barbican, imponente complesso abitativo e ricreativo (teatri, cinema, sale da concerto e per convegni, biblioteche, scuole ma anche laghetti, caffetterie e giardini) disegnato dallo studio di architetti Chamberlin, Powell e Bon in stile brutalista: una specie di astronave di cemento, sublime e mostruosa allo stesso tempo, atterrata a nord del Tamigi per dare forma a nuove forme di socialità e fruizione culturale (uno dei complessi abitativi è intitolato a Tommaso Moro, autore di Utopia).
La Regina, durante l’inaugurazione dell’Arts Center, lo definì “una delle meraviglie del mondo moderno”, ma più di una classifica lo annovera tra gli edifici più sgradevoli in Gran Bretagna. Luogo ideale, quindi, per ospitare Into the Unknown, mostra dedicata alla fantascienza, utopia e distopia, aperta fino al primo settembre. Ambiziosissima e illuminante per l’ampiezza di sguardo che mette insieme (in un programma ricchissimo, anche di eventi collaterali) nomi noti – Alien, Interstellar, Ex Machina, Godzilla, Star Wars, un intervento video di Charles Brooker di Black Mirror – alla ricostruzione della storia del genere nei secoli attraverso libri, illustrazioni, modelli, fino ad arrivare alle installazioni dell’artista britannico Conrad Shawcross; al corto Afronauts (2014) della regista ghanese di casa a New York Frances Bodomo ispirato al programma spaziale (di brevissima vita) dello Zambia o a In the Future They Ate From The Finest Porcelain (2016) dell’artista palestinese Larissa Sansour. Abbiamo parlato della mostra con il curatore – Patrick Gyger – storico medievalista, saggista e direttore del Le lieu unique, centro per le arti a Nantes.
Come è nato il tuo interesse per la fantascienza?
Niente d’inconsueto: viene dai libri. Mi sono trovato per le mani letteratura di genere fantascientifico a circa sette o otto anni e, da allora, non ho più smesso. Non ricordo il nome del primo romanzo che ho letto, ma certamente Le Cronache Marziane di Ray Bradbury furono un’illuminazione.
Si dice in giro che tu abbia una definizione piuttosto stringente del genere.
Sono stato per qualche anno direttore di un museo dedicato alla fantascienza in Svizzera: la Maison d’Ailleurs, istituzione voluta da uno dei primi studiosi del campo, Pierre Versins. La sua passione e il suo desiderio di approfondire i concetti di utopia e distopia derivavano dal fatto che aveva militato nella resistenza francese e, catturato, fu deportato ad Auschwitz: ai suoi occhi, dovette trattarsi di una specie di romanzo fattosi realtà. A guerra finita, iniziò a collezionare libri e ideò questa definizione piuttosto puntuale per circoscrivere la fantascienza – io non faccio altro che attenermici: congetture romanzesche razionali. Innanzitutto, parliamo di finzione, romanzi e non tentativi di prevedere il futuro…
Nostradamus è già fuori dai giochi, quindi.
Esattamente. Poi, deve essere razionale, seguire le leggi naturali. Queste devono rimanere stabili, uguali a se stesse: non ha alcuna rilevanza che la storia si svolga nel futuro o si torni indietro nel passato. Questa è, diciamo così, la parte “Science” della “Fiction”. L’elemento più importante, ma anche il meno semplice da descrivere, è quello congetturale: le storie potrebbero avere ipoteticamente luogo in quella che la maggior parte di noi definisce “realtà”, ma deve esserci una congettura, un “se” iniziale, che distingue un particolare universo immaginario da quello in cui viviamo. La definizione esclude il fantasy, l’horror o il racconto mimetico, che comunemente definiamo realistico.
La fantascienza ha seguito, dalla nascita, cicli alterni di notorietà. Fino a non molti anni fa, ad esempio, aveva un lato quasi carbonaro: c’erano gruppi ristretti di forti consumatori (che magari dovevano subire anche lo stigma dell’infantilismo) e, fuori da questo circuito, l’interesse era pressoché nullo a parte sporadici, straordinari successi…
Si certo, Star Wars o Blade Runner.
Come ti spieghi l’enorme e capillare diffusione di produzioni fantascientifiche oggi? Penso a cosa diversissime tra loro: dai supereroi a Black Mirror.
Molti ragazzi della mia età sono cresciuti attaccati a schermi che trasmettevano Star Wars o Alien o, in alcuni casi, divorando scrittori fondamentali come Philip Dick o J.G. Ballard. Quei ragazzi, oggi, hanno ruoli decisivi nell’industria dell’intrattenimento: dirigono società di effetti speciali, sono registi o produttori. Non è un caso che quest’anno escano nelle sale i nuovi Star Wars, Blade Runner e Alien. Un’altra ragione è che la tecnologia degli ultimi vent’anni – direi a partire dalla trilogia de Il Signore degli Anelli – è in grado di mettersi a pari, di rendere in modo plausibile le visioni della letteratura. Vale anche per i film con i supereroi: la visione ridicola di tizi con tutine aderenti è stata attutita dagli effetti speciali. Il punto di contatto tra il “reale” e l’“immaginario” è più morbido, ha cessato di creare quell’effetto grottesco che interrompeva la sospensione dell’incredulità. Terzo e ultimo motivo: viviamo in un ambiente culturale che non saprei definire in altro modo se non come un grande meccanismo che ricicla la cultura del passato. Allo stesso modo in cui alcuni tipi di musica elettronica provenienti da ambienti underground o comunque con storie, geografie e connotazioni molto precise, sono stati addomesticati e resi generici per essere appetibili anche al vasto pubblico dei frequentatori dei festival internazionali. La nostra società non riesce a immaginare alternative a se stessa. Puoi aderire a gruppi politici conservatori o progressisti, ma difficilmente questi metteranno in discussione l’infrastruttura della vita che conduci. Non ci sono partiti che promuovono, per esempio, la distruzione dei cellulari o la vita nei boschi. Non sto dicendo che sia una cosa buona o dannosa, ma solo che ci sono stati momenti nella storia recente – soprattutto negli anni Sessanta, ma fino al collasso dell’Unione Sovietica – in cui l’idea che il mondo potesse trasformarsi in modo sostanziale era ancora dibattuta, credibile. Una delle funzioni della fantascienza è mantenere una piccola finestra su futuri possibili o presenti alternativi, una qualche forma di speranza o, per i meno ottimisti, una via di fuga momentanea.
Visitando la mostra si avverte questo tuo interesse per l’elemento, diciamo, socialmente propulsivo della storia della fantascienza, più che ad esempio il lato spettacolare o il feticismo da collezionista. Credo si capisca anche che, come storico, tu cerchi nessi tra le forme del pensiero utopico prodotte in ambito filosofico e la fantascienza.
Credo siano sostanzialmente vicine. Un’utopia ha bisogno di un’ambientazione piuttosto maneggiabile, un territorio circoscritto come ad esempio una città con una serie di caratteristiche utilizzate per illustrare un racconto morale o una prospettiva, espressa in modo più o meno sottile, ma apertamente politica. In un racconto utopico si mostra ciò che il mondo può diventare, anche se non necessariamente la strada per questo cambiamento, per rendere appetibile una particolare direzione storica. La distopia è, naturalmente, l’opposto: “Se non prendiamo un corso diverso, ecco le mostruosità cui possiamo andare incontro”. Viviamo in tempi che sono allo stesso tempo utopici e distopici: se aveste la possibilità di dire ai vostri bisnonni che nel paese dove vivono quasi tutti avranno la possibilità di accedere alla varietà di cibi disponibili oggi, all’educazione obbligatoria universale, che non esisterà più la poliomielite o il colera, che si potrà comunicare con amici che vivono in altre nazioni in qualsiasi momento o viaggiare in aereo al costo di un pasto al ristorante, ma allo stesso tempo che si sarà sotto sorveglianza costante o che non si avrà controllo della propria vita privata, resterebbero certamente sbigottiti.
Sul lato distopico possiamo inserire anche l’“accorciamento del futuro”: la difficoltà ad immaginarsi tra cinque o dieci anni per via dello scenario recessivo, dell’arretramento di diritti del lavoro e dello stato sociale. È quasi un tormentone giornalistico, ma in un certo senso, sembra si sia restaurata – per una fetta non trascurabile della popolazione occidentale – una forma mentis ottocentesca, da inizi dell’industrializzazione: ci si beve il salario settimanale al pub – o il corrispettivo edonistico, voluttuario contemporaneo – perché non c’è il famoso “futuro da costruire” con oculatezza dei periodi buoni.
Nell’attuale scenario politico Europeo e Nord Americano ci sono conservatori di sinistra e conservatori di destra, non progressisti. Idee come quella del salario universale – e non voglio dilungarmi su quali siano, secondo me, i modi più corretti per metterlo in pratica – cambiano radicalmente la prospettiva di come si può vivere. Cosa accadrebbe se nell’arco di dieci anni, nessuno fosse più costretto a lavorare? Quanti continuerebbero per la sola voglia di farlo? E coloro che decidono di non lavorare come impiegherebbero la propria vita? Che “forma” darebbe alla società, all’architettura, agli intrattenimenti un cambiamento di questo tipo? In un certo senso, queste speculazioni pongono questioni, anche inquietanti, sulla natura umana, ma allo stesso tempo rompono il mantra per cui il futuro è l’oggi, solo blandamente perfezionato. Una delle cose più interessanti della fantascienza intesa nei termini di uno, chiamiamolo così, strumento politico – anche alla luce della nuova popolarità di cui dicevamo – è il potenziale di mettere in circolo queste idee. Pensa allo scrittore italiano Valerio Evangelisti che è rimasto piuttosto politico anche nella serie di best-seller dedicata al personaggio Nicolas Eymerich. Per non dire dei riferimenti strani, oscuri o al metal che riesce ad inserisce nei suoi romanzi [ride].
Già, come si dice, la fantascienza è un genere intrinsecamente politico, in un modo o nell’altro: uno dei segmenti più interessanti della mostra è quello in cui vediamo città futuribili usate nelle pubblicità del Ventesimo secolo che mostra il modo in cui siano state utilizzato visualizzazioni del “futuro” come leva per attivare il desiderio per l’uno o l’altro prodotto o servizio.
Pensa al New York World Fair del 1939, per cui la General Motors aveva costruito questo enorme padiglione chiamato “Futurama”. Per realizzarlo, si avvalsero di nomi molto celebri dell’epoca: il progettista principale era l’architetto e scenografo Norman Bel Geddes. Alla fine del lungo percorso che visualizzava il mondo del domani immaginato dalla ditta automobilistica, c’era un cartello che recitava: “Ho visto il futuro”. O pensa anche a un personaggio incredibile come Syd Mead che prima di diventare set designer di Blade Runner fu messo sotto contratto dalla Steel Corporation of America negli anni Cinquanta e Sessanta per produrre immagini del futuro, in cui naturalmente l’acciaio sarebbe diventato il materiale principale per la costruzione di case e automobili dall’aspetto avveniristico. Dopo la seconda guerra mondiale, le famiglie non possedevano ancora tutti quei beni e utilizzare quel tipo d’immaginario era un espediente piuttosto accessibile. Quale potrebbe essere un corrispettivo contemporaneo? L’iPhone 8 sarà incredibilmente migliore dell’iPhone 7? Molte persone sono disposte a crederci e a spendere denaro per avere uno smartphone più avanzato, però sono cose che non fanno sognare; non riescono a produrre immagini complesse e seducenti come, per dire, le automobili volanti. L’idea di usare il futuro per vendere prodotti si è esaurita. In generale, c’è una certa carenza di raffigurazioni del futuro. Il mio lavoro principale è quello di dirigere un centro artistico in Francia e una delle cose che mi chiedo costantemente è: come riuscire a progettare insieme agli artisti prospettive significativamente nuove sulla realtà? Credo che, nel suo piccolo, sia un approccio politico, pur partendo da esperienze di carattere estetico. In che modo puoi aver voglia di cambiare l’esistente se non hai immagini di cosa può diventare?
Torniamo alla mostra, come hai concepito il percorso narrativo?
Ci sono due obiettivi che tento di raggiungere nell’arco dell’esibizione: il primo è restituire la sensazione di un viaggio vero e proprio dentro la fantascienza. Mette in luce come derivi da un tentativo di colmare i vuoti nelle conoscenze geografiche dell’epoca, di produrre una mappatura immaginifica in cui le foreste amazzoniche o i poli potevano essere popolati da mostri o creature che credevamo estinte. Questo movimento scende dalla terra nel profondo degli abissi e infine vira verso lo spazio – ancora alla ricerca di nuove scoperte e conoscenze – e una volta capito che lo spazio è troppo esteso, troppo freddo, troppo pieno d’insidie si torna indietro sul pianeta terra per trasformarlo, costruire spazi utopici fatti di architetture ciclopiche e sorprendenti. Una volta finito il lavoro, si entra nello spazio interiore: trasformi i tuoi sogni, trasformi i pensieri. Gli spazi geografici sono rimpiazzati da metafore più astratte. Volevamo creare un equilibrio tra prodotti meno noti, di ricerca, e la cultura popolare. Modellini di Star Wars, manoscritti, libri o carte illustrate. Questo per mostrare che la fantascienza può assumere diversi formati, progetti che coinvolgono audience enormi e sottoculture di nicchia, underground. Il mio punto di vista è che più che un genere, la fantascienza sia una disposizione del pensiero che può essere applicata a qualsiasi ambito. Questo è l’elemento chiave.
La commistione è decisamente interessante, in parte perché può spingere i più curiosi ad approfondire le parti più “esoteriche”, in parte perché rispecchia in modo naturale l’esperienza di chi si è sempre interessato poco alle distinzioni tra “alto” e “basso”.
Amare la fantascienza o i fumetti è accettabile oggi, ma resta l’idea che si tratti di forme artistiche di basso profilo. È una divisione completamente posticcia, ci sono sempre state persone come te o come me che possono guardare indifferentemente un film di Mario Bava e uno di Stanley Kubrick. Mi farebbe molto piacere l’idea che i visitatori si incuriosiscano alla storia di Sun Ra, Jeff Mills, James Ballard o Philip Dick. Alla fine dell’esibizione, e questo è molto importante, c’è una piccola teca solitaria con dentro sei libri di fantascienza appartenuti e annotati da Jorge Luis Borges, tra cui uno di Bradbury. Parliamo di Borges: il direttore della Biblioteca Nazionale dell’Argentina e, naturalmente, uno dei maggiori scrittori del Ventesimo secolo. Era interessato anche a questi libri e a riviste pulp.
Che poi forse è sempre successo: a parte il caso estremo dell’onnivoro Quentin Tarantino, penso a Jean-Luc Godard che, se non erro, era un estimatore del noir classico Hollywoodiano o anche Olivier Assayas – uno dei miei registi contemporanei preferiti – che nella prima metà degli anni Ottanta ha promosso, dalle pagine dei Cahiers du cinéma, la produzione cinematografica di Hong Kong e così via…
Ti racconto un aneddoto: quando ero teenager vivevo in un piccolo paese in Svizzera, lo stesso in cui abitava Jean-Luc Godard e un giorno andai in una videoteca per affittare un VHS e divenni amico del proprietario. Naturalmente Godard frequentava lo stesso negozio, e ogni settimana correvo ad aggiornarmi sulle videocassette che aveva preso in prestito e si trattava, giuro, di qualsiasi cosa: dalla più infima produzione fantascientifica a noir americani, passando per qualche film erotico fino a cose più alla moda o underground. Io ero sempre costernato: “No, non è possibile che Godard abbia affittato Cannibal Holocaust” e il mio amico annuiva divertito.
Ci sono novità, generi che ti interessano particolarmente di recente?
Dopo il cyberpunk è difficile definire movimenti in modo così distintivo, ma credo che lo stesso si possa dire di altre discipline. Anche nella musica, nei primi anni Novanta o ascoltavi rock alternativo o… no [ride]; leggevi il cyberpunk o no. Ora c’è questa frammentazione in rivoli, in sottogeneri. Forse alcuni elementi di novità sono stati la rinascita della space-opera o quello che si definisce new-weird che unisce elementi di fantasy, di fantascienza, con le atmosfere più cupe dell’horror come ad esempio il lavoro di Jeff VanderMeer o di China Miéville che, per me, è uno dei maggiori scrittori contemporanei. Poi c’è l’interesse per le città, la social fiction e, cosa più interessante, l’idea della singularity, la speculazione sulle possibilità per cui l’interazione con intelligenze artificiali superiori a quella umana possano produrre nuove civiltà. Poi ci sono sottogeneri come lo steampunk, che pensavo morto negli anni Novanta – e già allora mi interessava poco – ma è sopravvissuto diventando un fenomeno sempre più mainstream, credo perché è riuscito a creare un tipo di iconografia distinguibile in modo inequivocabile.