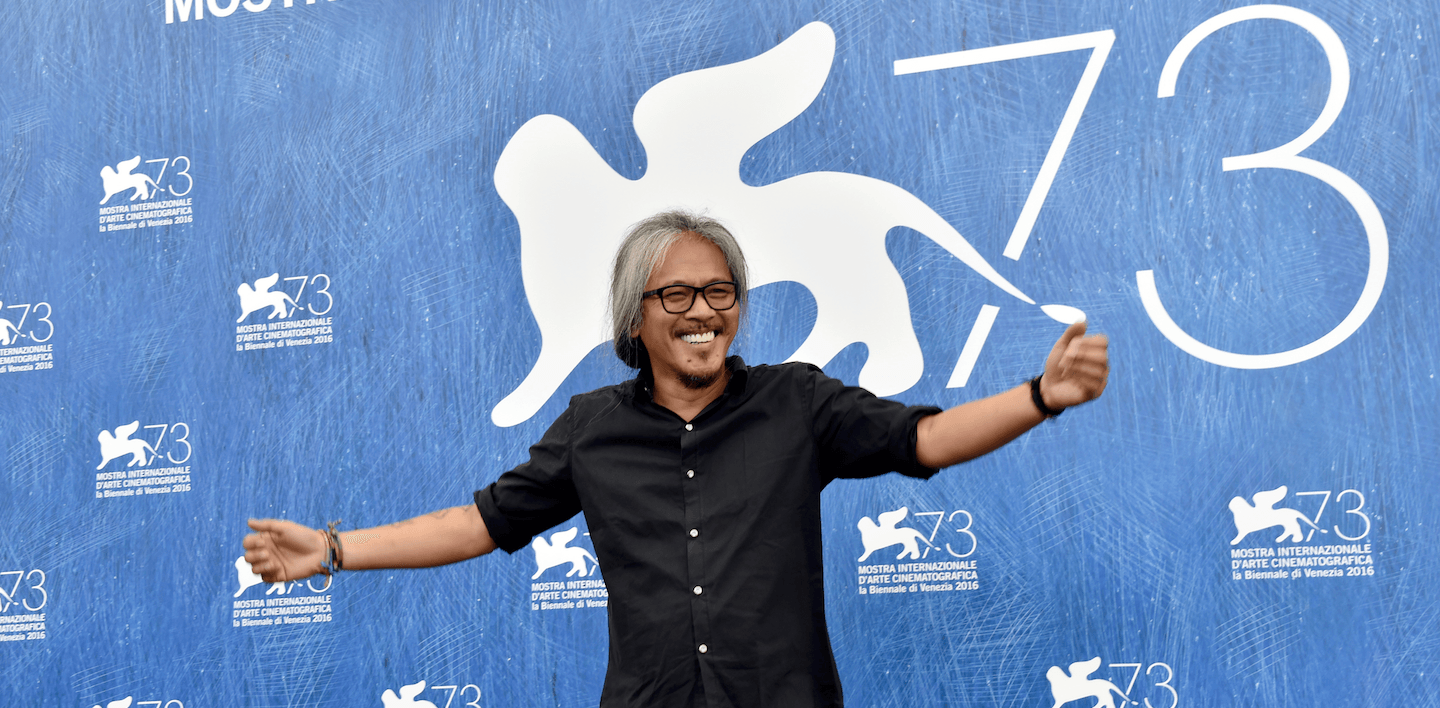
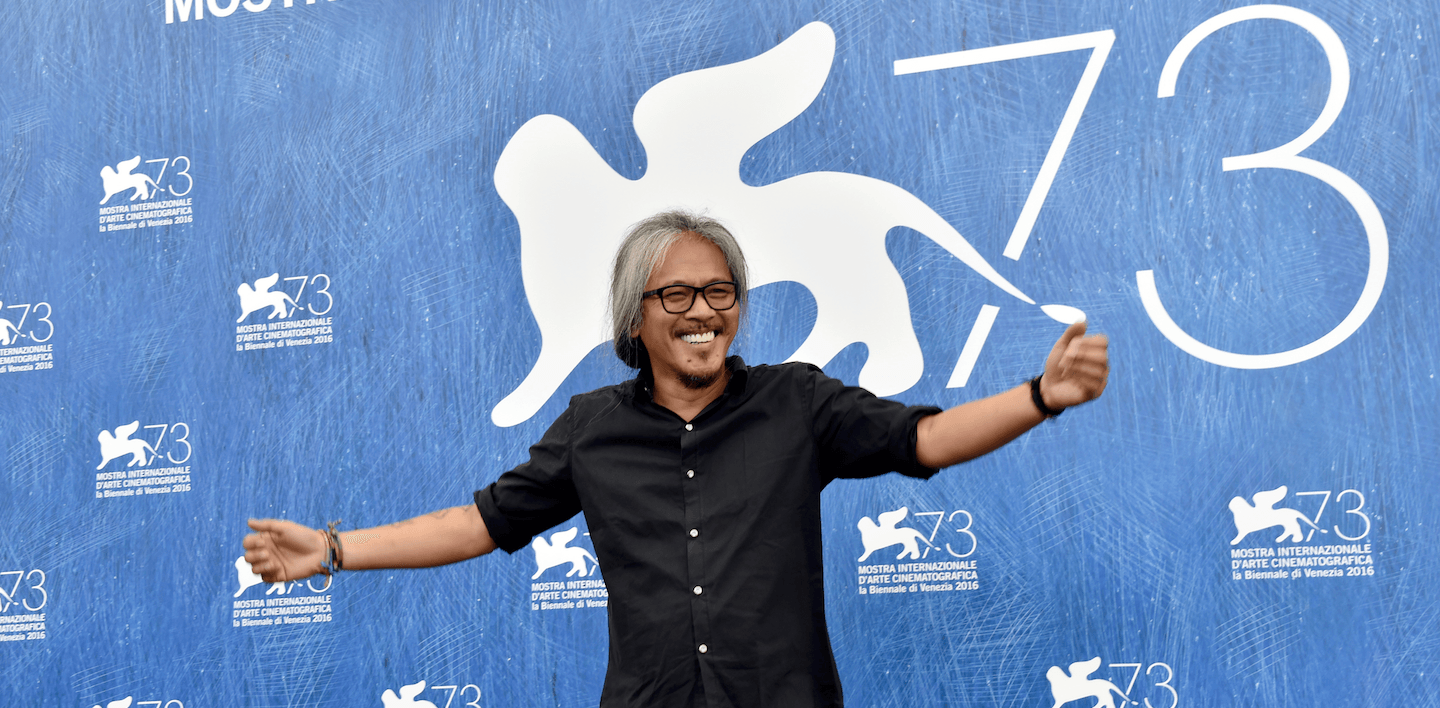
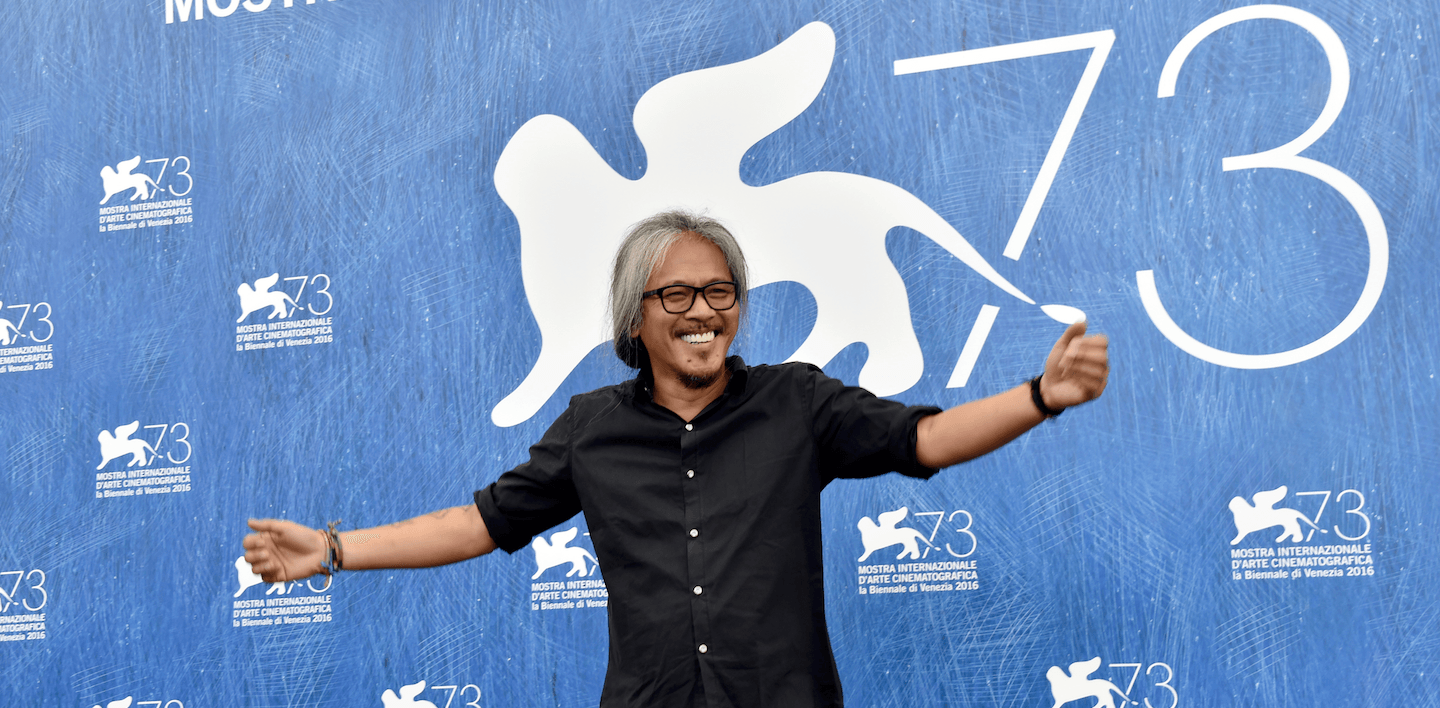
Q uando si parla di Lav Diaz si chiama sempre in causa la lunghezza quasi parossistica dei suoi film. From What is Before, vincitore al festival di Locarno nel 2014, dura 5 ore e 38 minuti; A Lullaby to the Sorrowful Mystery, premio Alfred Bauer a Berlino lo scorso febbraio, arriva a 8 ore e 5 minuti; The Woman Who Left, Leone d’Oro all’ultima Biennale di Venezia, raggiunge le 3 ore e 44 minuti di immobili piani sequenza in bianco e nero, senza un singolo primo piano su un volto umano.
È la storia di una donna che esce di prigione dopo trent’anni di detenzione, condannata per un delitto che non ha commesso. Una volta fuori va in cerca di vendetta, ma più prova a realizzare il suo piano più la vita la confonde, facendole incontrare uomini e donne che vivono al margine, comprese due versioni allucinate dei figli che non ha potuto vedere crescere.
Le scene sono realizzate come fotografie composte con massima cura: raramente la singola azione si svolge in più di un’inquadratura, e le pochissime volte in cui la macchina da presa si muove l’effetto è fortissimo, come trovarsi su una nave che all’improvviso salpa dopo una lunga attesa. Il suono è composto solo di parole e rumori ambientali, l’assenza di colonna sonora affina i sensi attraverso un lavoro di privazione. Tiene lo spettatore continuamente in cerca di qualcosa, in attesa, in ascolto.
Il cinema di Diaz viene spesso etichettato come parte dello slow cinema, anche chiamato contemplative cinema, categorie ufficiose che raccolgono film di luoghi e epoche molto diverse: le caratteristiche per far parte di questo presunto movimento sono le inquadrature statiche, la lunghezza eccessiva, la narrazione sorretta da eventi minimi. Robert Bresson, Andreij Tarkovskij, Theo Angelopoulos e Béla Tarr sono alcuni dei soliti nomi tirati in ballo come simboli di un cinema filosofico, puro, senza compromessi.
Si tratta di un insieme di film creato non per appartenenza consapevole, ma come semplice opposizione a un pensiero cinematografico dominante: l’industria dell’intrattenimento in stile hollywoodiano, la cinematografia satura di ritmo e colpi di scena, piena di luci, suoni, colori. A un cinema fatto per essere ricevuto passivamente, dove il tempo del film è concepito per non essere avvertito, se ne contrappone un altro in cui lo spettatore è chiamato a osservare attivamente, a interrogarsi, a confrontarsi con la durata delle immagini.
A un cinema fatto per essere ricevuto passivamente, dove il tempo del film è concepito per non essere avvertito, se ne contrappone un altro in cui lo spettatore è chiamato a confrontarsi con la durata delle immagini.
Diaz sembra essere il campione di questo stile: un suo film del 2004, Evolution of a Filipino Family, dura 593 minuti ed è stato realizzato nell’arco di undici anni, allo stesso modo in cui Boyhood di Richard Linklater racconta la vita di una famiglia americana lungo dodici anni. Il film di Diaz invece narra la violenza e la corruzione del governo di Ferdinand Marcos attraverso le vicende di un gruppo di contadini che vive alle porte di Manila. Mentre Linklater presenta un’impeccabile coerenza di registro, lasciando soltanto ai volti e ai corpi degli attori di rivelare lo scorrere del tempo, Evolution of a Filipino Family presenta una mescolanza di stili e tecniche che raccontano l’evoluzione di Diaz stesso come regista, mescolando il 16mm dei primi anni con il digitale utilizzato per concludere l’opera, supporto da lì in avanti sposato dal regista per facilitare le sue narrazioni fuori misura.
Neanche Diaz è in grado di razionalizzare il ruolo preponderante che lo scorrere del tempo ha nei suoi lavori. “È accaduto in maniera organica”, ha detto anni fa a proposito della lunghezza abnorme di Evolution. “Appena avevamo altri soldi richiamavamo gli attori, ci bevevamo un caffè e ricominciavamo a girare”. Tutto il film, finanziato con il contibuto di amici e parenti, è costato soltanto 60000 dollari. Proprio da lì è cominciata la maturazione artistica di Diaz, che in pochi anni è diventato il regista filippino più premiato di sempre.
Time Regained era il titolo di una retrospettiva dedicata a Diaz al Lincoln Center di New York nel 2015. Il tempo riconquistato, come se i suoi film rappresentassero un recupero, il ritorno di qualcosa che si riteneva perduto. Non è un caso forse che le riflessioni di passati maestri di cinema lento suonino come perfette descrizioni del modus operandi di Diaz. Scriveva Tarkovskij nel suo memoir del 1986, Scolpire il tempo:
“La dominante assoluta dell’immagine cinematografica è costituita dal ritmo che esprime lo scorrere del tempo all’interno dell’inquadratura. Il fatto poi che questo stesso scorrere del tempo viene rivelato anche dal comportamento dei personaggi, dai trattamenti figurativi e dai suoni, tutto ciò costituisce soltanto una serie di componenti collaterali che, ragionando da un punto di vista teorico, possono anche essere del tutto assenti e, cionondimeno, l’opera cinematografica esisterebbe lo stesso.”
La corrispondenza con la sequela di lunghi quadri fissi di Diaz è evidente, e lui stesso ha espresso la sua idea di tempo in un’intervista di tre anni fa:
Nei rispettivi modi in cui i due registi esprimono un pensiero analogo sta tutta la differenza tra il cinema di Tarkovskij e quello di Diaz. Il primo lirico, epico autore di un cinema tanto ineffabile quanto tecnicamente complesso e ambizioso; il secondo figlio illegittimo del suo tempo, adoratore della lentezza nell’epoca della velocità, che ha scelto il digitale per poter girare ore e ore senza ostacoli produttivi; autarchico che scrive, dirige, monta i suoi film da solo. Diaz non cerca la spiritualità di Tarkovskij, spesso prediligendo lunghi dialoghi espositivi in cui i personaggi toccano temi di attualità con conversazioni fittissime quasi fossero documentari; non è neanche cultore della forma come Robert Bresson, i cui film sono collezioni di scene in cui, pur con un’estrema economia espressiva, il regista francese riusciva a intrecciare dei legami di suoni e immagini perfetti ed essenziali come haiku.
L’unica cosa che veramente lega questi tre registi è la ricerca di un tempo interno delle immagini, l’invito che rivolgono allo spettatore a navigare dentro le inquadrature, a crearsi i propri percorsi visivi, l’invito a essere disposti a saper aspettare, o a non sapere cosa aspettarsi. Invece di saturare l’audiovisivo per permetterci di consumarlo, questi registi lo sottopongono a rarefazione per invitarci a manipolarlo con la nostra sensibilità. Non è poi così necessario capire bene il messaggio politico di The Woman Who Left, o se avessero giovato al film mezz’ora di tagli o qualche movimento di macchina in più. Si tratta di un film che non può essere riassunto in un gradimento complessivo e univoco: richiede di essere trattato come un’esplorazione, un viaggio che ha una sua durata e che ha fasi diverse. Ancora Diaz sul tempo e sullo spazio:

