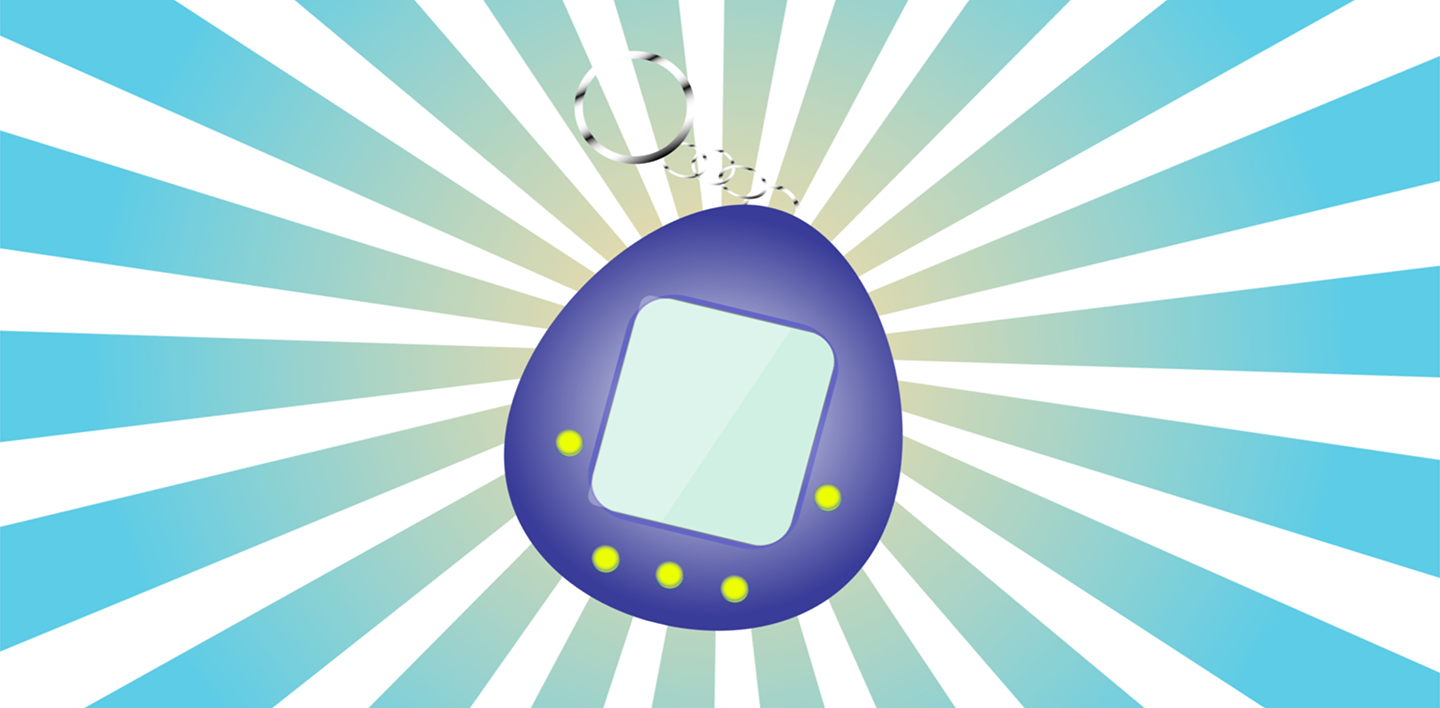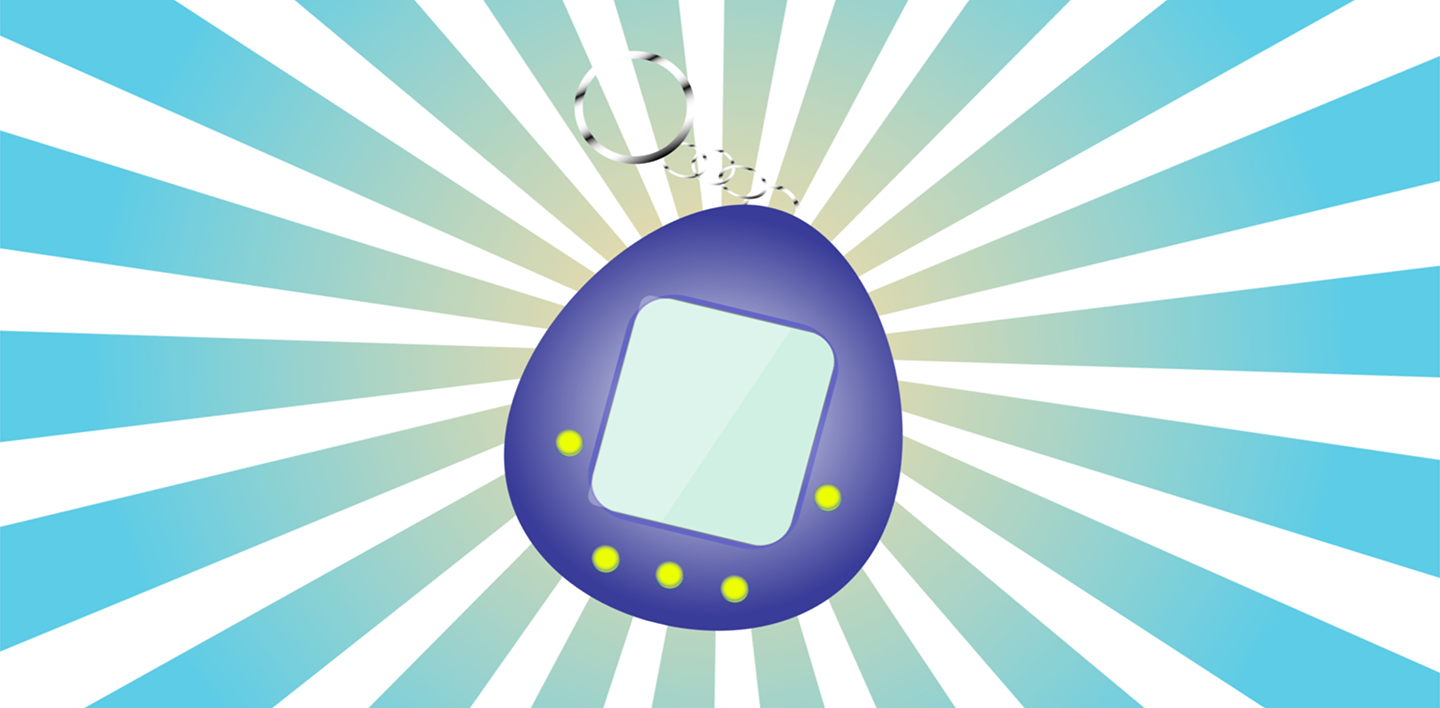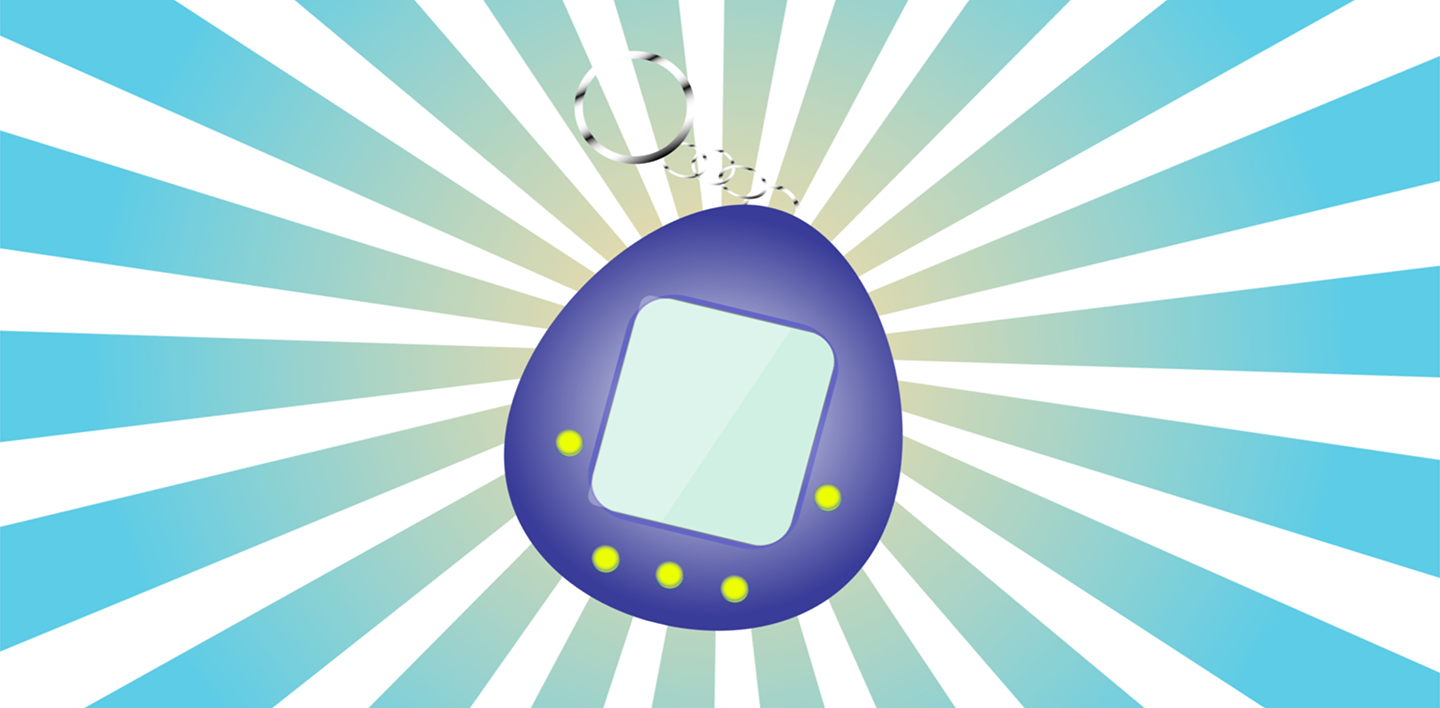“L
e tecnologie informatiche e della comunicazione definiscono ormai l’animale umano, quindi il pianeta stesso è una tecnocultura. Il Giappone è arrivato a capirlo un po’ prima di noi, ed è per questo che abbiamo amato così tanto i suoi prodotti… Abbiamo consumato abbastanza fantasie giapponesi da esserci immedesimati e non considerarle più come qualcosa di esotico”. Vigilia di Natale del 1996, i negozi di giocattoli del Giappone accolgono una folla di migliaia di persone pazientemente in fila per l’ultima novità: un minuscolo alieno di cristalli liquidi racchiuso dentro un uovo di plastica. Sprovvista del tasto “off”, la creaturina digitale non chiedeva di risolvere sfide impossibili o trovare soluzioni a rompicapi intelligenti ma nutrizione e cure, in assenza delle quali sarebbe andata incontro prima al deperimento e poi alla morte – o al ritorno sul suo pianeta d’origine, a seconda delle narrazioni – lasciando comparire sullo schermo l’iconcina di un fantasma fluttuante prima di essere resettata e lasciare spazio a un’altra versione di sé.
Piccolo come un portachiavi e stiloso come uno scarabocchio, il Tamagotchi immesso sul mercato dalla Bandai nasceva dall’idea dell’imprenditore Yokoi Akihiro, un ex dipendente amante degli animali da compagnia, che mesi prima aveva ceduto il progetto al colosso dell’industria di giocattoli sotto forma di orologio da polso. Ma furono due giovani creative – la trentenne Maita Aki, addetta al marketing, e l’illustratrice venticinquenne Shirotsubaki Yoko – a svilupparne e indovinarne il design a tal punto da trasformare quella che era a tutti gli effetti una fantasia maschile in un irresistibile must-have per ragazzine di città alle prese con cercapersone elettronici e riviste di moda. Vivo, perché non si spegneva mai, quel giochino che adesso volevano tutti e che se si spegneva era morto, nell’incoscienza collettiva stava ufficialmente aprendo la strada alla digitalizzazione dei sentimenti. Non è un caso se anni dopo Sherry Turkle lo avrebbe definito “il miglior manuale di preparazione alla psicologia della robotica sociale”, tenendolo al centro delle sue prime ricerche sulle relazioni tra esseri umani e macchine sensibili. In Popポップ. Come la cultura giapponese ha conquistato il mondo, il reporter e traduttore americano Matt Alt lo descrive come “l’avanguardia dell’ingegneria elettronica”, un groviglio di “viscere hi-tech racchiuse in un colorato involucro di plastica progettato per piacere alle bambine” ma che nel giro di poco avrebbe esportato nel resto del mondo la reincarnazione digitale dell’estetica kawaii, il cosiddetto “culto del carino” di cui fino ad allora Hello Kitty era stata l’indiscussa reginetta.
Sul pianeta ‘vivevano’ quaranta milioni di Tamagotchi, una costellazione di uova pronte a schiudersi generando un nuovo orizzonte di senso.
Nel 1997 il Tamagotchi (dal giapponese tamago: uovo e uotchi, derivazione di watch, orologio da polso) era già una mania; da quel momento le analisi di mercato avrebbero iniziato a calcolare ogni quanti minuti nel mondo ne veniva acquistato uno e presto anche l’Italia avrebbe visto davanti ai negozi di giocattoli le stesse scene di folle dedizione al cospetto di una produzione che stentava a fronteggiarne la domanda. Ad Akihiro Yokoi e Aki Maita fu assegnato il Premio (satirico) IgNobel per l’economia “per aver dirottato l’equivalente di milioni di ore di lavoro sull’allevamento di cuccioli virtuali”. Nel giro di due anni, sul pianeta ne “vivevano” quaranta milioni, una costellazione di uova pronte a schiudersi generando un nuovo orizzonte di senso. In uno dei capitoli del libro Alt ne racconta la storia, includendo il Tamagotchi a pieno titolo nella famiglia di quelli che chiama “congegni trasmetti-fantasie”, dispositivi prodotti da un’industria a metà strada tra la cultura pop e l’hi tech con cui il Giappone ha sedotto l’occidente negli anni dell’economia globale. Gli stessi in cui la patria dei Salaryman – dipendenti in giacca devoti al lavoro full time che di notte andavano a sbronzarsi in gruppo davanti a un Karaoke – diventava il regno della bolla finanziaria e dei sogni infranti.
La terra degli Otaku – solitari introversi, depressi, spesso disoccupati, ossessionati da quel mix di fantascienza, anime, manga e videogame che li rendeva dei bizzarri perdigiorno, chiusi a chiave nelle loro camerette a fantasticare davanti a ragazzine di carta. Oppure: “canarini nella miniera del capitalismo all’ultimo stadio” come Alt li definisce a un certo punto. Per questo libro, spiega nell’introduzione “ho scelto il quadro economico come cornice di una storia più ampia, quella di come i creativi giapponesi abbiano ridefinito cosa significhi essere umani nell’epoca moderna”. Tra le maglie della fitta rete di aneddoti e retroscena sulla genesi di alcuni tra i prodotti più iconici per chi è cresciuto tra gli anni ‘80 e il 2000 – dal Walkman al Game Boy, passando per Pac-Man, Akira e radioline della Sony – affiorano parole inventate da quella stessa industria e presto adottate ufficialmente dai vocabolari di tutto il pianeta, proprio mentre le studentesse per cui il Tamagotchi era stato inventato elevavano le emoji (dal giapponese e, immagine, e moji, carattere) al lessico minimo delle emozioni digitali.
Popポップ è qualcosa di più di un saggio sul Giappone: è un trattato di archeologia sociale e insieme un manuale di tecnologia dei sentimenti.
Uscito negli Stati Uniti nel 2020 per Crown con il titolo Pure invention (in Italia nel 2023 per Add, traduzione di Simone Roberto), Popポップ è qualcosa di più di un saggio sul Giappone. È un trattato di archeologia sociale e insieme un manuale di tecnologia dei sentimenti. Un volume che starebbe bene nei programmi universitari di chi studia comunicazione e semiotica, perché racconta di come il mercato delle idee e i suoi linguaggi, anche mediatici, hanno plasmato le vite e il modo che abbiamo oggi di pensarle e di evaderle, senza prescindere dal nostro sesso. Matt Alt, che ha studiato giapponese a scuola e per anni ha lavorato per l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti traducendo videogiochi di notte, oggi vive a Tokio dove si è trasferito nel 2003 e ha fondato un’azienda specializzata nell’esportazione di un “media-mix” di contenuti – videogame, manga, e altri prodotti d’intrattenimento.
Claudia Bruno: Più che un arcipelago localizzato sulle mappe, il Giappone di cui racconti è un riverbero, la proiezione ipertecnologica di una visione. In certi sensi, per molti, è come esserci cresciuti senza averci mai messo piede. È stato così anche per te, prima di scrivere questo libro?
Matt Alt: All’inizio pensavo di intitolare il libro Generazione J perché c’è davvero una linea di demarcazione netta tra le generazioni che hanno consumato prodotti giapponesi semplicemente perché erano economici, e quelle che hanno iniziato a consumare prodotti giapponesi perché pensavano che fossero cool. Sicuramente l’immagine del Giappone che ha preso forma nella mia testa ha a che fare con i prodotti che ho consumato – non solo i congegni trasmetti-fantasie che sono nel libro come gli anime, i giocattoli robotici, il karaoke o il game boy, ma anche cose come il sushi, il ramen istantaneo e i Pocky. Questa miscela di giocosità e manifattura sembrava qualcosa di molto diverso dalla mia cultura americana, era molto invitante.
CB: Leggendoti mi sono resa particolarmente conto di quanto prima di Internet la nozione stessa che avevamo di tecnologia corrispondesse praticamente sempre a degli oggetti fisici e di quanto oggi ci troviamo in una prospettiva diversa. E però uno dei pregi del libro credo sia proprio quello di aver raccontato questo passaggio come una rottura soltanto apparente con “il passato”. I manufatti in quanto invenzioni hanno sempre incarnato qualcosa di immateriale, una “visione del mondo”.
MA: Il libro è diviso in due: la prima metà è incentrata sugli oggetti, sui prodotti fisici; la seconda sulle idee, sulle fantasie immateriali. A rispecchiare il radicale cambiamento avvenuto nella realtà quando tutti noi abbiamo iniziato a trasferire le nostre vite online. Ma senz’altro credo che i prodotti che realizziamo dicano molto della nostra cultura e dei nostri valori. Gli oggetti che produciamo sono inevitabilmente prodotti del loro tempo. Studiandoli possiamo imparare molte cose su noi stessi. È la ragione per cui ho scritto il libro – tutti conosciamo i prodotti che raggiungono il successo, però spesso ignoriamo i motivi di quel successo. È questo che ho voluto indagare.
Gli americani credevano di essere i più forti al mondo, ma come dimostra la popolarità che hanno avuto i prodotti giapponesi, c’era fame di punti di vista alternativi.
CB: In Pop parti dal disastro di Hiroshima e Nagasaki e arrivi fino ai giorni dell’hate speech in cui la pandemia ci ha trasformati tutti in degli Hikikomori, e lo fai sfidando una concezione lineare del tempo, attraverso continue incursioni mediatiche e salti semantici, restituendoci prima ancora che un pezzo importante della storia di un paese, l’incipit di una storia globale della tecnologia. Che tipo di connessione c’è, secondo te, tra il modo in cui percepiamo il tempo e il modo in cui inventiamo e usiamo le tecnologie?
MA: O un’altra lettura che si potrebbe dare a questo libro è quella di “una storia della globalizzazione nel dopoguerra”, in particolare tra l’Asia e l’Occidente, perché mostra come i flussi culturali dall’Asia all’Occidente si siano rafforzati in quell’arco di tempo. Gli americani credevano di essere i più forti al mondo, ma come dimostra la popolarità che hanno avuto i prodotti giapponesi, c’era fame di punti di vista alternativi. C’è da dire che spesso questi prodotti arrivavano con un certo ritardo rispetto alla loro nascita in Giappone. Pensiamo al karaoke, già una tendenza di lunga data in Giappone quando gli americani e gli europei cominciarono ad accorgersi della sua esistenza all’inizio degli anni Ottanta. Il consumo di questi dispositivi va quindi incontro a tempistiche diverse – o meglio, prima era così. Con Internet c’è stata una grande sincronizzazione dei consumi, sia di prodotti che di media, in tutto il pianeta.
McLuhan riteneva che i mezzi di comunicazione modellassero il modo in cui consumavamo i messaggi che ne derivavano. I congegni trasmetti-fantasie sono simili nel loro aver plasmato il modo in cui interagiamo con il mondo.
CB: Il tuo discorso tiene insieme manufatti e opere dell’ingegno, dispositivi elettronici e neologismi fabbricati su misura da un mercato sempre pronto a essere esportato, capace di intercettare in anticipo lo spirito del tempo. In questa galassia dalla conformazione eterogenea tutto è imparentato con tutto – dalle vecchie macchinine di latta alle consolle al karaoke, passando per manga, anime e pupazzetti, e fino alle emoji. Tu li chiami “congegni trasmetti-fantasie”. McLuhan diceva che il medium è il messaggio, ma il senso che affidi a questa espressione sembra un po’ diverso.
MA: Nulla si crea dal niente. C’è sempre un precursore, fisico o culturale che sia. Man mano che la nostra si avvia a diventare una specie iper-consumatrice, dove a definire la nostra identità sono più il consumo di prodotti e fantasie che l’habitat, la famiglia o altri indicatori socioculturali tradizionali, il peso metaforico di ciò che consumiamo aumenta. McLuhan si riferiva in particolare ai mezzi di comunicazione perché riteneva che essi modellassero il modo in cui consumavamo i messaggi che ne derivavano. I congegni trasmetti-fantasie sono simili nel loro aver plasmato il modo in cui interagiamo con il mondo.
CB: A un certo punto citi lo scrittore cyberpunk William Gibson che dice che il Walkman “ha cambiato la percezione umana più di qualsiasi altro gadget per la realtà virtuale”. In effetti è all’origine della nostra concezione della musica, una bolla privata che ti segue ovunque, mette in scena la colonna sonora della tua vita. Non è difficile pensare che se non fosse stato inventato, oggi Spotify non esisterebbe. Oppure ci saremmo arrivati comunque, seguendo un’altra pista – dopotutto racconti che il karaoke è stato inventato cinque volte. Possiamo dire che il Walkman ha segnato l’inizio di un processo tecnologico di reinvenzione della realtà?
MA: Il Walkman ha segnato un prima e un dopo nel nostro modo di vivere la sfera pubblica. Se prima stare nello spazio pubblico era un’esperienza condivisa, con il Walkman si trasforma in un’esperienza interiorizzata e le persone si sottraggono a una realtà consensuale per entrare in “mediasfere” di cui si prendono cura personalmente. Questo fenomeno è stato solo accelerato da sviluppi successivi, come l’iPod o l’iPhone, i social media e le teorie del complotto digitali. Io addirittura penso che Spotify discenda dal karaoke! Che può sembrare strano, ma se ripercorriamo lo sviluppo del karaoke dai dispositivi di riproduzione multimediale (nastri stereo 8, CD-ROM, dischi laser, ecc.) allo streaming digitale on demand, la discendenza è chiara. Molte delle cose che diamo per assodate nella nostra società attuale sono state introdotte per la prima volta nelle strade del Giappone, e lo streaming multimediale è forse la più lampante.
CB: È interessante come proprio negli anni in cui ci è stato ripetuto di continuo che la cultura e l’economia erano due dimensioni agli antipodi, tu mostri come per molti versi queste due dimensioni siano letteralmente collassate l’una nell’altra. Il ruolo che aziende come Sony, Sanrio, Nintendo o Toshiba hanno svolto nella formazione di un’intera generazione, forse anche due, è corrisposto a fatturati significativi per l’economia nel suo complesso, tanto da risollevarla in momenti di crisi e di disastro finanziario.
MA: Almeno tre generazioni – la Generazione X, i Millennials e ora la Z – sono cresciute con le fantasie giapponesi, in un modo o nell’altro. Viviamo in un’epoca in cui i nostri eroi sono i prodotti dei consigli di amministrazione. Non è qualcosa che ha inventato il Giappone, solo che a un certo punto le sue fantasie sono diventate altrettanto o maggiormente attraenti rispetto a quelle create in occidente. Non credo che ci sia qualcosa di intrinsecamente sbagliato in questo, non potrebbe essere altrimenti in un’economia di libero mercato che riconosce alla libertà di espressione un suo proprio valore. Alcune idee saranno sempre e inevitabilmente monetizzate.
I giapponesi non ne hanno inventata una sola per gli stranieri. Le hanno inventate per sé, e solo dopo abbiamo scoperto di amarle. Ma l’Occidente, lo sappiamo, si considera il centro del mondo.
CB: Quali sono secondo te i pericoli di una scarsa coscienza rispetto al fatto che la “cultura” oggi è un’industria a tutti gli effetti?
MA: Credo che sia importante avere l’alfabetizzazione mediatica necessaria a capire quando si viene manipolati. È una questione di cui dovremmo occuparci a partire dal sistema educativo, perché vivere in una società dell’informazione globale significa che i flussi di informazione rappresentano flussi di potere. Uno degli aspetti più interessanti nella stesura di questo libro per me è stato rendermi conto di quanto tutte le critiche e le isterie rispetto al “lavaggio del cervello” che i prodotti giapponesi avrebbero fatto ai bambini occidentali non siano state altro che una fantasia. Tra le cose di cui parlo nel libro, i giapponesi non ne hanno inventata una sola per gli stranieri. Le hanno inventate per sé, e solo dopo abbiamo scoperto di amarle. Ma l’Occidente, lo sappiamo, si considera il centro del mondo.
CB: La storia che racconti è anche la storia di come siamo passati da giocare insieme a giocare da soli. Penso al passaggio dalle radio familiari ai transistor, dal karaoke al walkman, dalle sale giochi alle consolle domestiche ai game boy. Ma penso anche alle doppie vite che ci siamo costruiti per evadere da realtà e orizzonti politici troppo spesso deprimenti, e a come tutto questo abbia modificato la concezione stessa di erotismo e di piacere. Secondo te oggi la tecnologia può rappresentare un giocattolo per degli ex bambini che non sono più riusciti (o non hanno più voluto) diventare adulti?
MA: Ho scritto ampiamente su questo abbandonarsi degli adulti a una serie di piaceri infantili, l’ho chiamata la “
grande regressione”. Può rappresentare una spinta positiva quando l’evasione permette di ricaricarsi, stimola la curiosità e la creatività. Può essere estremamente dannosa se assume la forma di un attacco d’ira, fondamentalmente ciò che di cui è fatta la gran parte della politica populista contemporanea: risentimento, vittimismo. È più facile buttare giù una torre di mattoncini che costruirla, lo sappiamo dall’esperienza che abbiamo dell’infanzia. A quanto pare alcune persone non superano mai questi impulsi, ma dobbiamo anche tener conto del fatto che siamo tutti essenzialmente dei bambini nel profondo, e questo è un aspetto che i produttori giapponesi colgono più istintivamente di quelli occidentali – d’altronde la Bibbia ammonisce di “mettere da parte le cose infantili”.
Se pensiamo all’abc dei social media, alle emoji, ai selfie, alle declinazioni virtuali delle nostre identità, non sono stati i tecnici della Silicon Valley a inventare queste cose. Sono state le ragazze giapponesi.
CB: Uno degli aspetti che più ho apprezzato di POP è la ricostruzione che fai del ruolo che le ragazze giapponesi hanno avuto nella definizione di linguaggi e immaginari, e delle tecnologie che li hanno supportati. Innovatrici, designer, studentesse, gamer, trend setter. Non solo protagoniste del culto del carino” ma pioniere di quello che sarebbe diventato il nostro alfabeto digitale dei sentimenti, qualcosa di sempre più strategico per il funzionamento delle nostre stesse economie. Cosa hanno saputo vedere secondo te queste ragazze che gli altri non trovavano così evidente?
MA: Le ragazze giapponesi sono le pioniere misconosciute dell’era dei social media. Le tecnologie che così presto hanno adottato per connettersi tra loro in un contesto di turbolenze sociali com’era quello del Giappone degli anni ’90, rispecchiano fedelmente il modo in cui i giovani di tutto il mondo avrebbero fatto lo stesso almeno un decennio più tardi, dopo lo shock Lehman. Il dato che si trovassero purtroppo a ricoprire i gradini più bassi della società in un mondo pensato per gli uomini com’era e resta tuttora il Giappone, ha reso per loro l’adozione di nuove tecnologie qualcosa di più che un semplice consumo. Era una strategia di sopravvivenza e allo stesso tempo una pratica profondamente ribelle e rivoluzionaria, e proprio sotto il naso dell’establishment che le ignorava. È accaduto in modo così organico e naturale che persino loro sul momento non se ne sono rese pienamente conto. Se pensiamo all’abc dei social media, agli sms, alle emoji, all’Internet mobile, ai selfie, alle declinazioni virtuali delle nostre identità, non sono stati i tecnici della Silicon Valley a inventare queste cose. Sono state le ragazze giapponesi.
CB: Un contrappunto al senso di rivalsa invece molto maschile che ha animato l’industria giapponese a partire dal dramma della sconfitta bellica. Dalle macchinine di latta del dopoguerra l’immaginario sulla mascolinità si è trasfigurato nei videogiochi e negli anime distopici fino a trovare nuova linfa nelle guerre informatiche. Nella parte finale del libro offri un dettagliato resoconto di come la cultura otaku sia stata snaturata e fatta propria dagli hater del nuovo millennio, al punto da avere un ruolo chiave nella formazione dell’alt-right americana e della misoginia online alla base del cosiddetto Gamergate. Pensi che siamo ancora in tempo per inventare un utilizzo più sostenibile delle tecnologie?
MA: Gli otaku sono stati dei precursori nel trovare un centro alle loro identità in personaggi di finzione. Erano disprezzati in Giappone e presi in giro all’estero, ma il loro stile di vita ha anticipato il modo in cui fandom e politiche identitarie avrebbero poi impostato il discorso pubblico. Non sono sicuro che possiamo inventare la nostra via d’uscita, sembra esserci qualcosa che lo impedisce nella natura umana – oggi siamo tutti otaku, nel nostro consumare e identificarci in narrazioni costruite su misura. E le tecnologie a cui abbiamo accesso ci danno la possibilità ineguagliabile di trovare le nostre tribù – in senso positivo, come una persona isolata che può trovare una comunità di supporto, ma anche in senso negativo, come razzisti che vanno a unirsi ad altri razzisti, o persone arrabbiate che trovano altre persone arrabbiate. Questo è ciò che ha alimentato il Gamergate e QAnon, e anche molte politiche populiste.
CB: Nel 1997 Sadie Plant parlava di “tecnocultura” a proposito del riassetto delle dinamiche di genere che le tecnologie digitali avevano innescato. Secondo te questa parola oggi potrebbe tornare nei nostri discorsi? Possiamo dire che il Giappone è stato per molti di noi una tecnocultura? Qual è la tua idea di Giappone oggi?
MA: Gli anni dieci del duemila sono stati un periodo di grande sincronizzazione tra Giappone e occidente, dal punto di vista tecnologico, sociale e dei consumi. Oggi il Giappone non è più all’avanguardia nella creazione di tecnologie, ma resta assolutamente all’avanguardia rispetto a come le società avanzate stanno affrontando gli effetti destabilizzanti di queste tecnologie. Le tecnologie informatiche e della comunicazione definiscono ormai l’animale umano, quindi il pianeta stesso è una tecnocultura. Il Giappone è arrivato a capirlo un po’ prima di noi, ed è per questo che abbiamo amato così tanto i suoi prodotti. E anche se oggi le cose sono cambiate e siamo tutti più simili, conserviamo questi sentimenti, che addirittura si amplificano. Perché abbiamo consumato abbastanza fantasie giapponesi da esserci immedesimati e non considerarle più come qualcosa di esotico.