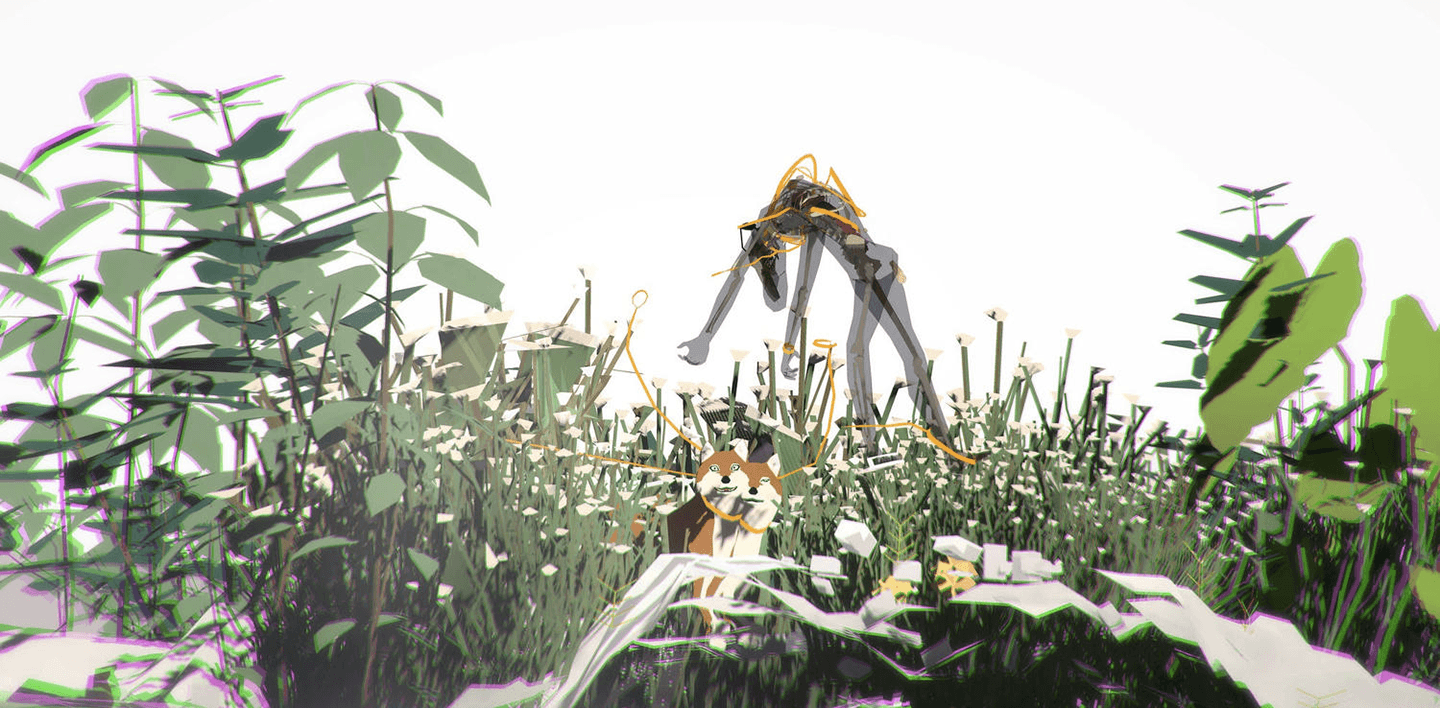
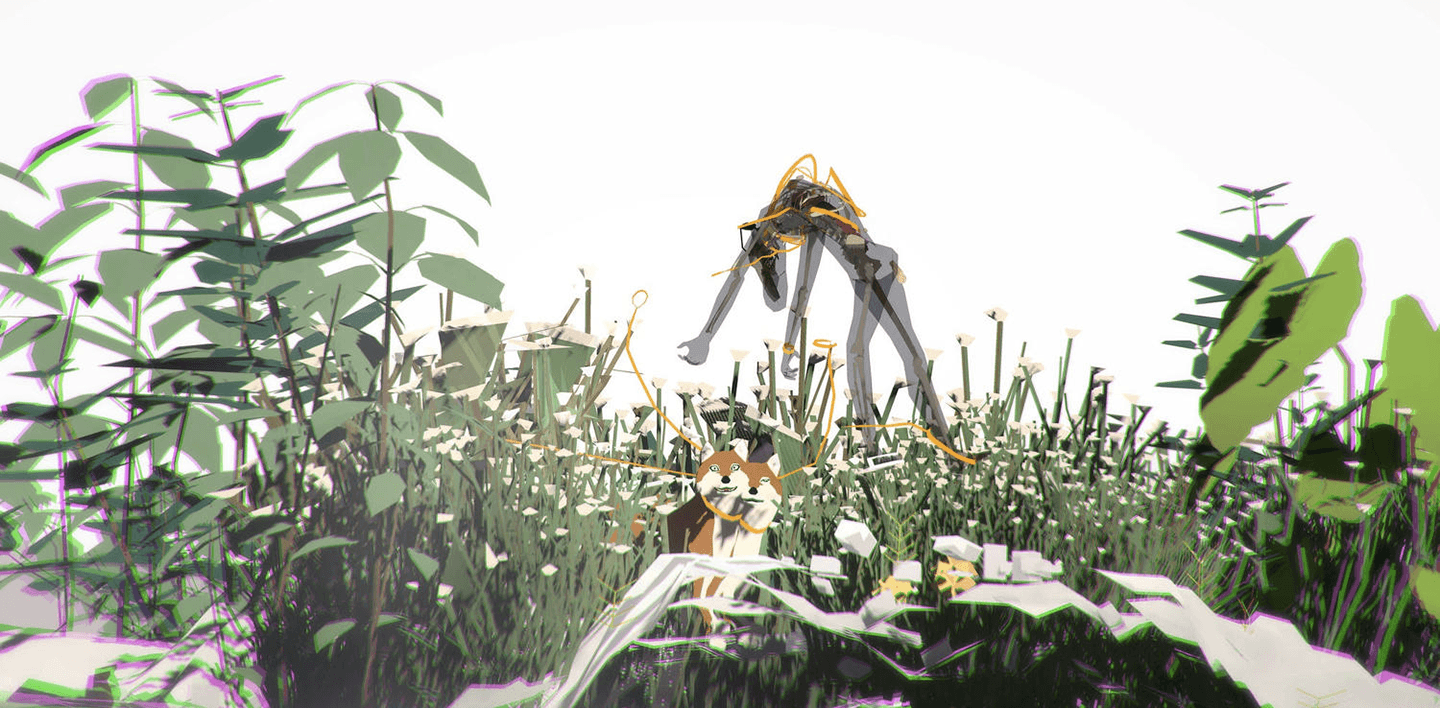
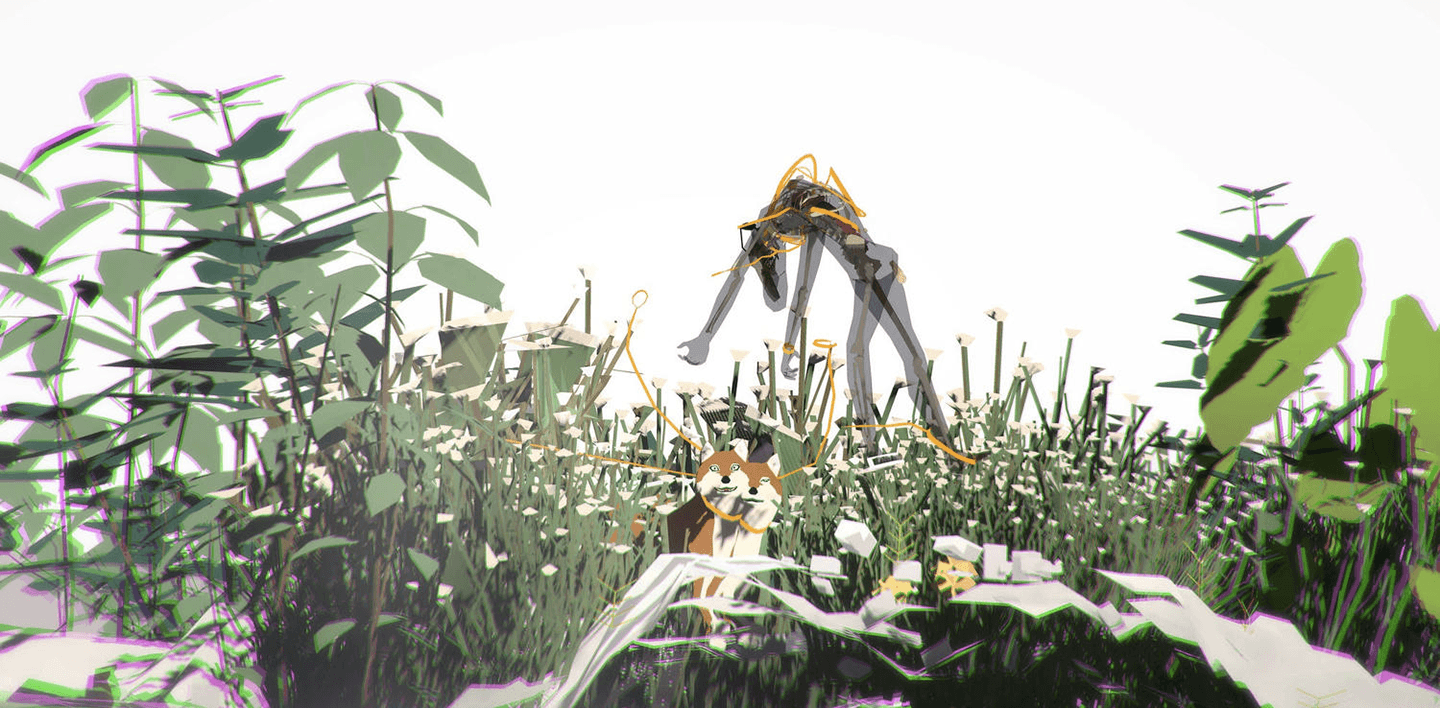
P oco prima del Millennium Bug si è entrati in un’era di “disincanto digitale.” Nicholas Negroponte ne scriveva su Wired nel 1998: “La tecnologia sta già cominciando ad essere data per scontata, e le sue connotazioni saranno le pubblicità di domani e il substrato culturale per nuove idee. Come per l’aria e l’acqua potabile, l’essere digitale, verrà notato solo per la sua assenza, non per la sua presenza. […] I computer come li conosciamo oggi saranno a) noiosi, e b) scompariranno all’interno di oggetti che sono in principio altre cose: unghie intelligenti, camicie che si lavano da sole, macchine senza autista, bambole Barbie terapeutiche, maniglie che apriranno all’uomo delle consegne e lasceranno uscire Fido, ma non faranno entrare altri dieci cani.”
Questo è il discorso culturale da cui, agli inizi del nuovo millennio, in ambito musicale e artistico, si è sviluppata la corrente minore del post-digital. Con il termine si intende non un superamento in accezione storico-hegeliana dell’era digitale, quanto più, similmente a quanto è accaduto per il post-punk o il post-feminism che rappresentano una deriva o una continuazione criticamente rivisitata del fenomeno iniziale, si intende un ripensare il rapporto tra essere umano e tecnologia. Secondo Florian Cramer, professore di New Media all’Università di Scienze Applicate di Rotterdam, post-digital “descrive una prospettiva sull’informazione digitale e la tecnologia che non si concentra più sull’innovazione tecnica e il miglioramento, ma rigetta quel tipo di narrazione tecno-positivista.”
Kim Cascone, musicista e teorico dell’estetica post-digital, sostiene che questa si sia sviluppata a seguito dell’esperienza di lavorare in ambienti saturi di tecnologia digitale. Continua Cascone, nel suo saggio “The Aesthetics of Failure”, dicendo che “nello specifico è dal ‘fallimento’ della tecnologia digitale che questa nuova corrente è emersa: glitch, bug, errori delle applicazioni, crush del sistema, clipping, distorsione da campionamento lento, distorsione, rumore di quantizzazione elettronica, persino il rumore della base della scheda audio dei computer, sono il materiale grezzo che i compositori cercano di integrare nella loro musica.” E come un attore che guarda in camera, questi suoni squarciano il velo di illusione che avvolge la tecnologia e il nostro supposto controllo su di essa. Gli strumenti tecnologici possono essere tanto precisi ed efficienti quanto la mente umana che li ha creati.
È per questo motivo che all’interno del post-digital il medium non è il messaggio, piuttosto è lo strumento specifico che diventa il messaggio. Come sostiene il sound artist Enrique Tomás, “suonare con una specifica interfaccia corrisponde ad assumere implicitamente un’attitudine politica e l’ideologia inerente ad essa, solitamente sviluppata e assimilata dalla sua comunità di users. L’atto di creare, hackerare o performare con alcuni tipi di interfacce significa manifestare quella particolare visione creativa (nda, legata all’interfaccia) e la politica artistica dei suoi utenti.”
Un esponente del post-digital che si è cimentato con questo concetto prevalentemente in ambito artistico, seppure, in quanto sound artist, strettamente legato alla musica, è Jem Finer. Jeremy Max Finer è stato, insieme a Shane MacGowan, membro fondatore della band folk-punk anglo-irlandese The Pogues attiva durante gli anni ’80 e ’90. Dopo lo scioglimento Finer ha continuato a suonare e comporre, oltre che con il banjo, anche con chitarra, mandolino, ghironda e sassofono, ma soprattutto, ha cominciato a dedicarsi all’arte.
Score For a Hole in The Ground è l’opera con cui ha vinto, nel 2005, il PRS Foundation New Music Award. È un’istallazione musicale permanente in una foresta nel Kent, la quale consiste in un buco profondo sette metri e largo poco più di due, rivestito di cemento e sormontato da una lastra di metallo con degli intagli a fessura. Sulla piattaforma, a sua volta, si erge un tubo di acciaio corten alto sette metri, alla cui estremità si trova un corno simile a quello di un vecchio grammofono. Inoltre, uno stagno artificiale è collegato sotterraneamente al buco, e l’acqua che da esso vi gocciola all’interno, con l’azione congiunta degli altri fenomeni meteorologici, contribuisce a creare una sinfonia di suoni naturali, poi amplificata attraverso il corno metallico.
Cosmolog è invece il nome del progetto nato da due anni di residenza artistica presso il dipartimento di astrofisica dell’università di Oxford, la cui opera d’arte principale è Centre of the Universe, un capanno di legno adibito a radio osservatorio spaziale in cui Finer ha vissuto per un mese in condizioni da semi-eremita mentre catturava fotoni che viaggiavano per lo spazio. L’artista, descrivendo l’esperienza, racconta:
Durante Cosmolog trasformavo segnali in suoni — in realtà rumore puro e semplice — e in disegni, tramite un apparecchio simile ad un sismografo. Si sarebbe potuto usare la matematica per decodificare quei segnali, si sarebbe scoperto qualcosa a riguardo della composizione chimica della loro fonte, riguardo alla loro potenza, ma a me non interessava. Infatti un giorno ho messo il volume del sound system al massimo, ho abbandonato il capanno e chiuso la porta. L’intera struttura, trasformata in una gigantesca cassa, tremava. Era la traslazione in sensazione fisica che faceva il paio con il potere sonico: si aveva l’impressione di assistere alla nascita di forze cosmiche.
Sebbene la carriera folk-punk sembri non avere niente in comune con la “deriva cosmologica” che hanno preso gli interessi di Finer, è utile sapere, che prima di dedicarsi a musica ed arte, l’artista si è formato nell’ambito della matematica e dell’informatica. La sua familiarità con i computer è più evidente in opere come Mobile Sinfonie o Supercomputer. La prima, come suggerisce il nome, è una sinfonia pensata per telefoni cellulari. Ogni suoneria, composta appositamente, è una “voce” dell’orchestra e la composizione globale emerge dall’interazione accidentale e casuale delle suonerie. Più persone utilizzano una suoneria della Mobile Sinfonie, più il brano si arricchisce di voci. La seconda, invece, ispirata alla matematica di Jean Tinguelyun e ad Il Gioco della Vita di John Conway, è un apparecchio a metà tra un flipper e un videopoker giapponese, le cui palline, scorrendo su circuiti labirintici di unità meccaniche computazionali, trasportano informazioni e calcolano frasi melodiche minime.
Con questa opera Finer sostiene di chiudere il cerchio con un concetto di post-digital da lui interpretato agli inizi degli anni 2000. La sua accezione si riferisce non a un disconoscimento della tecnologia, quanto più a un’indagine sulla sua sostenibilità, a una riconsiderazione e riconfigurazione delle vecchie tecnologie, di modo da rendere possibile riconnettersi allo spazio fisico. Post-digital, dopo trent’anni di lavori con il computer, è l’aggettivo con cui ha definito il suo modus operandi, una metodologia che implica un ritorno a una relazione diretta con i materiali e il paesaggio, in opposizione a una relazione mediata da uno schermo.
I temi che da sempre spingono l’artista all’esplorazione e alla creazione sono quello di tempo e spazio, sistemi automatizzati e processi a lunga durata. L’esempio in cui si sintetizzano tutti è Longplayer, senza dubbio la sua opera più famosa, con la quale è stato invitato al Transmediale 2010, festival di arte e cultura digitale che si tiene ogni anno a Berlino. È un brano musicale in esecuzione dal 2000 e programmato per continuare a suonare fino al 2999 senza mai ripetersi. A riguardo del quale Finer stesso dichiara: “Ciò a cui aspiro con la mia arte è di creare un’esperienza condivisa e di incoraggiare lo spirito di comunità. Molte delle mie istallazioni implicano un impegno duraturo: da parte mia per crearlo, e da parte della comunità per salvaguardarlo. Longplayer è nato come un esperimento per cercare di creare uno spazio in cui mettersi in relazione al flusso e riflusso del tempo su scale differenti. Comporre un brano musicale che duri mille anni è una cosa, ma come far sì che continui a suonare è un’altra. Non c’è un’unica risposta, ma propendo per un approccio secondo il quale le persone scelgono se farlo continuare o no. E se la scelta sarà positiva, allora la responsabilità diventa condivisa dalla comunità e si estenderà per generazioni.”
Il suo percorso da sound-artist sembra dunque zigzagare tra arte, scienza e filosofia. Leggendo i titoli dei suoi lavori — Radio Astronomy, Zero Genie, Stay were you are, On Earth as in Heaven — si ha l’impressione che Finer sia alla ricerca di un modo per ancorare il metafisico nel reale.
Oppure di ancorare il reale nel metafisico. Per me il fatto che qualcosa possa essere spiegato dal linguaggio non significa che non abbia anche una dimensione di ineffabilità. Sono in grado di capire la scienza delle cose, ma questo spesso serve soltanto a farle sembrare ancora più inspiegabili. Per esempio, Centre of Universe era un radio osservatorio funzionante che catturava fotoni. L’idea che stessi captando particelle che fluttuavano nell’universo da poco dopo la sua nascita per me era un pensiero assurdo, anche se in teoria è scienza semplice. La mera scala di tempo e spazio e la domanda di come e cosa c’era prima della nascita dell’universo, per me sono cose magiche.
In questo filone tecno-artistico-filosofico che tende al magico e al misterioso, si inserisce anche l’opera di Mark Fisher, autore di The Weird and the Eerie e di Ghosts of My Life. Ispiratosi al jeu de mots derridiano, nella raccolta di saggi Fisher presenta il suo concetto di hauntology. Derrida coniò il termine unendo l’aggettivo haunted (infestato) al sostantivo ontology (ontologia) per riferirsi a una situazione di discongiungimento temporale, storico e ontologico in cui la presenza dell’essere è rimpiazzata da un “fantasma” – qualcosa di non veramente presente, ma neanche completamente assente — laddove come spettro viene inteso non un’entità sovrannaturale, bensì un qualcosa che agisce senza esistere fisicamente. Di conseguenza l’hauntology designa un operato del virtuale. Mark Fisher ha applicato lo stesso concetto alla musica e ha spiegato con esso la fascinazione tutta contemporanea per i vinili dicendo che “il gracchiare [del vinile] ci rende consapevoli del fatto che stiamo ascoltando un tempo che è disallineato, che non ci permette di cadere nell’illusione della presenza”. Affiancata al post-digitalism di Finer, le due formulazioni sembrano porsi in una relazione di consequenzialità. Interrogato a riguardo e su come, a quasi vent’anni dalla sua prima definizione del termine, sia cambiato il suo rapporto sulla tecnologia, il sound-artist propone una riflessione affascinante sull’evoluzione del digitale ed il nostro rapporto con esso.
“La mia prima esperienza con un computer risale al 1974, era un ICL 1900 che occupava un sacco di spazio e la cui potenza era minima in confronto a quella del più basilare computer di oggi. Non c’erano app, tutto doveva essere programmato. E c’era un elemento temporale coinvolto: niente era istantaneo. Per scrivere codici dovevi pigiare forte sui tasti e linea dopo linea le informazioni venivano salvate su schede. Queste venivano poi ordinate e raccolte da un operatore in camice bianco che le faceva funzionare inserendole nel marchingegno. Qualche ora dopo recuperavi una stampa con i risultati. Eri completamente consapevole di quello con cui avevi a che fare. Con il passare del tempo i computer sono diventati sempre più veloci, potenti e piccoli. E anche sempre meno trasparenti. È facile quindi dimenticarsi che effettivamente si sta usando un computer. La tecnologia digitale sembra che si stia muovendo verso l’invisibilità, quasi come se volesse ingannare e rendersi post-digitale (nella mia accezione del termine) attraverso il suo concretizzarsi in oggetti fisici”. Finer, poi, obietta:
“Qualcuno potrebbe ribattere che il post-digitale è la condizione in cui ci troviamo in conseguenza all’ubiquità della tecnologia. Non è quello che intendevo all’epoca, ma in un certo senso entrambe le prospettive si stanno integrando nel concetto. Da quando ho formulato il mio significato di post-digitale è stato inventato il touchscreen, e benché l’esperienza di usare un iPad, per esempio, continui ad essere mediata attraverso uno schermo, almeno adesso c’è una forte componente tattile e gestuale coinvolta. Ancora più di questo, il rimpicciolimento fino all’invisibilità (nel senso che non siamo più in grado di vedere il meccanismo che elabora i dati) e l’abilità di inserire computer ovunque, risultano in oggetti 3D tattili e senza schermo. Per questo motivo c’è un incontro tra le diverse definizioni di post-digitale. Al momento sto creando unità audio che processano autonomamente algoritmi, che sono essenzialmente scatole con vari pulsanti, fader, input e output audio, all’interno dei quali ci sono computer Raspberry Pi. Dov’è dunque l’ hauntology? Forse nei bug, e quindi nelle mutazioni – sempre presenti nei miei codici e nei miei impianti elettrici – che io accolgo con piacere. Esse rappresentano a loro modo “il gracchiare” che ci mantiene coscienti di quello che sta succedendo all’interno. Creano l’inaspettato. Esiste grazie a loro un costante feedback che provoca incidente, modificazione, incidente, modificazione, in loop. I computer si rimpiccioliscono per infestare la mia prima definizione di post-digital, e l’illusione di presenza (presenza in senso esistenziale, non in senso temporale) è negata ulteriormente dai colpi e dai clangori nel mio processo lavorativo”.
Tornando invece a Negroponte, possiamo spuntare dalla lista delle sue previsioni quasi tutto ciò che ha nominato: a distanza di vent’anni abbiamo macchine che si guidano da sole, Reborn Dolls, Smart Home e computer infilati negli oggetti più disparati. L’onnipresenza digitale, l’avanzamento estremo ed estremamente rapido della tecnica, sembra aver innescato nel subconscio collettivo un meccanismo di ritorno ad una dimensione più mistica, meno decodificabile. Il 2017 infatti pare essere stato, soprattutto a livello curatoriale, l’anno dedicato alla “magia” ed incentrato in particolare sul binomio che essa compone insieme alla tecnologia. Impakt, il festival d’arte e newmedia di Utrecht, ha ospitato una serie di performance e presentazioni a tema “Haunted Machines and Wicked Problems”. Il corpo tecnologico, esorcizzando il database, sogni ri-cablati, realtà speculative, paesaggi mitici e phobiarama, sono solo alcuni dei nomi degli eventi che si sono tenuti nella cittadina olandese.
“Guest, Ghost, Host: Machine!” era invece il nome dell’annuale Serpentine Marathon, una serie di interventi da parte di artisti, filosofi, musicisti e antropologi, che ha avuto luogo alla Serpentine Gallery di Londra lo scorso Ottobre, e il cui focus era l’avvento dell’intelligenza artificiale e l’interazione dell’uomo con le macchine. Anche il padiglione italiano della Biennale d’arte di Venezia, curato da Cecilia Alemani, è stato intitolato “Il Mondo Magico” in riferimento all’opera di Ernesto De Martino, e proponeva un ritorno all’immaginario e al fantastico. In un intervento durante i giorni dell’esposizione con l’artista Adelita Husni-Bey (autrice del film The Reading/La Seduta) e Federico Campagna (autore di Technic and Magic: The Reconstruction of Reality, in uscita a maggio per Bloomsbury), quest’ultimo presentava la tesi principale del suo libro come la contrapposizione tra il mondo della tecnica e quello della magia. Secondo l’autore, il primo ha come punto di riferimento la filosofia occidentale e usa il linguaggio come categoria per stabilire ontologicamente l’esistenza — se qualcosa è definibile allora esiste — il secondo si rifà alla filosofia iraniana e si basa sul concetto di ineffabilità.
A riguardo del fatto che la sua opera si collochi precisamente all’interno di questo discorso, ovvero nell’intersezione tra “magico” e tecnologico, al confine tra scienza e arte, Finer afferma che è una conseguenza naturale della sua curiosità e di una sua specie di ossessione: quella di cercare di capire come funzionano le cose.
Il fatto che alcune di queste ‘cose’ siano tempo e spazio è un risultato dei miei interessi che tendono verso la fisica e gli elementi, e che per me, nonostante le loro spiegazioni scientifiche, hanno una forte connotazione magica, di mistero, e di ineffabilità.Gran parte del mio lavoro è ispirato dal cercare di trovare il modo per dar senso alle questioni che mi perplimono e mi ossessionano. Forse è un modo di concretizzarle e cercare l’elemento di contrasto, una spiegazione scientifica e verificabile da completare con qualcosa che si rivolga alla mia esperienza momentanea. Con queste istallazioni stavo cercando il contrappunto a una spiegazione. Con le mie opere artistiche sto cercando la faccia magica della tecnica.