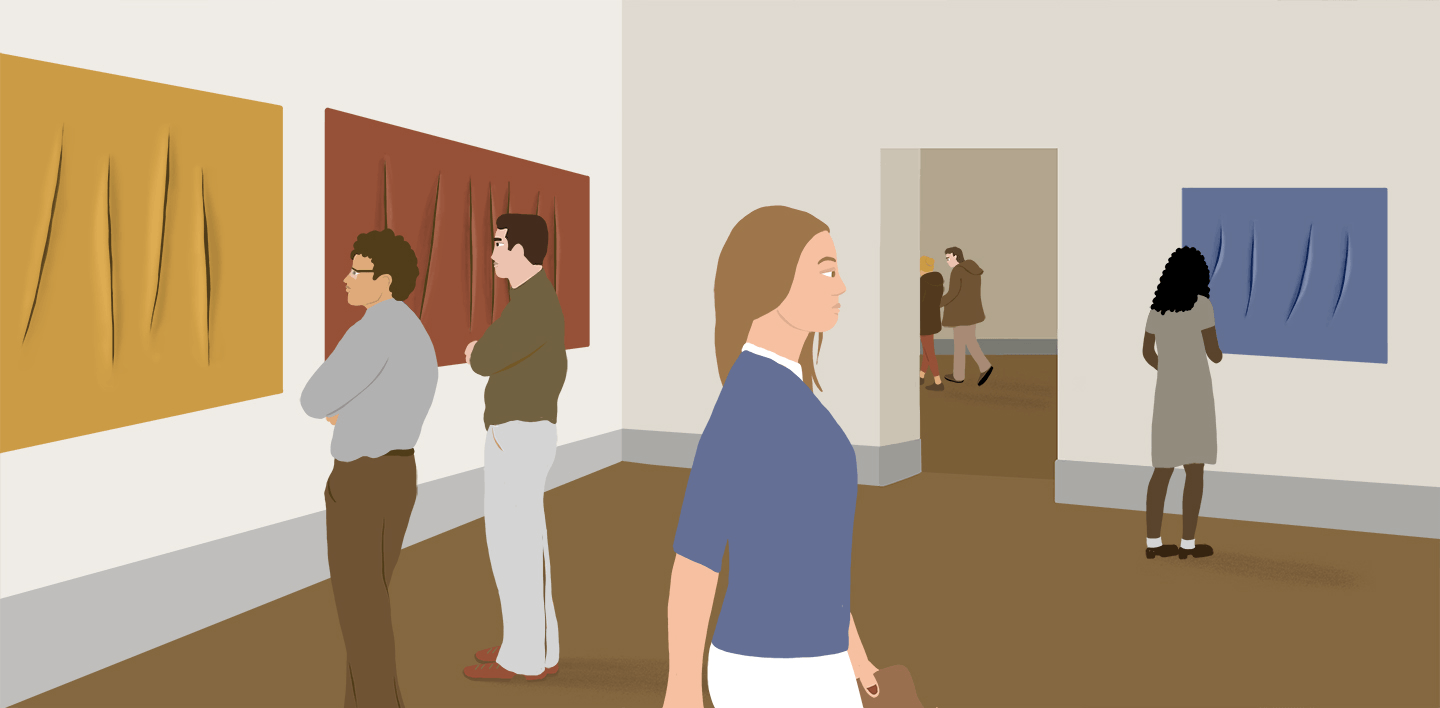
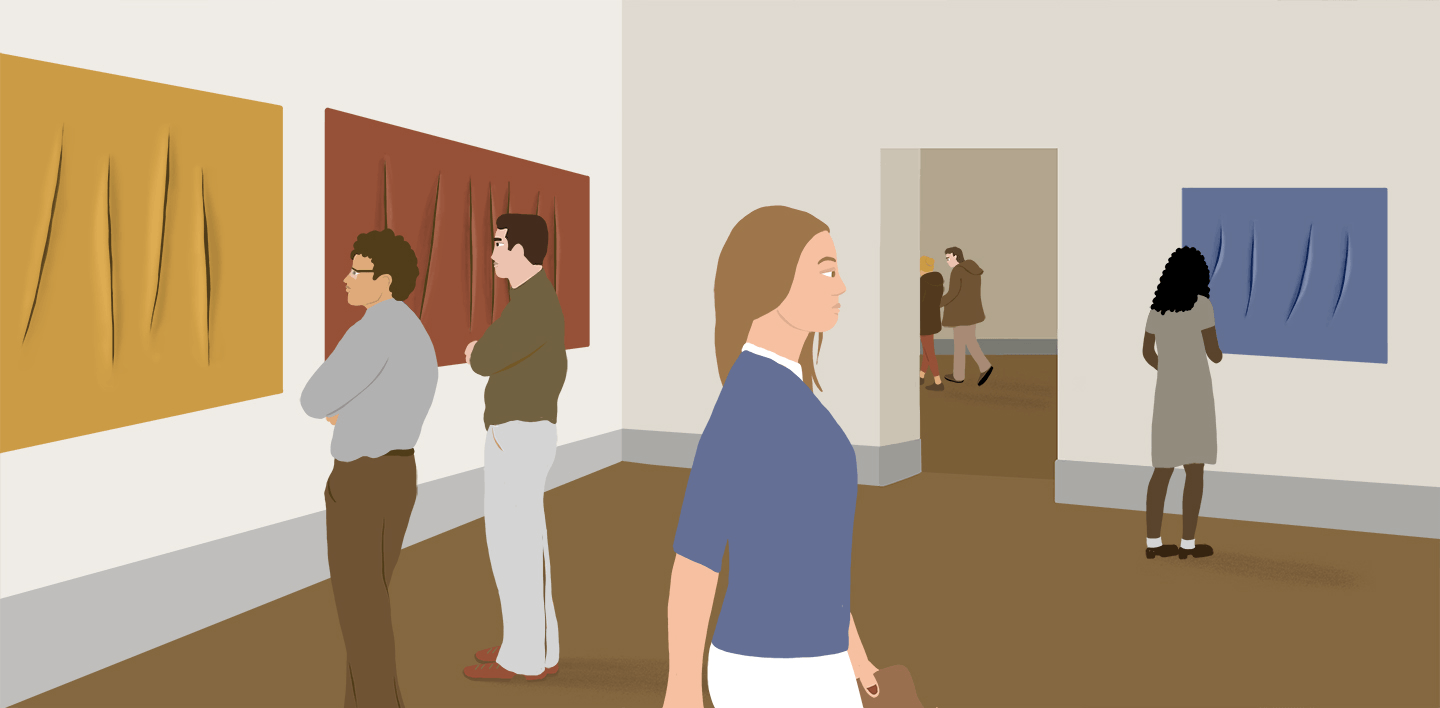
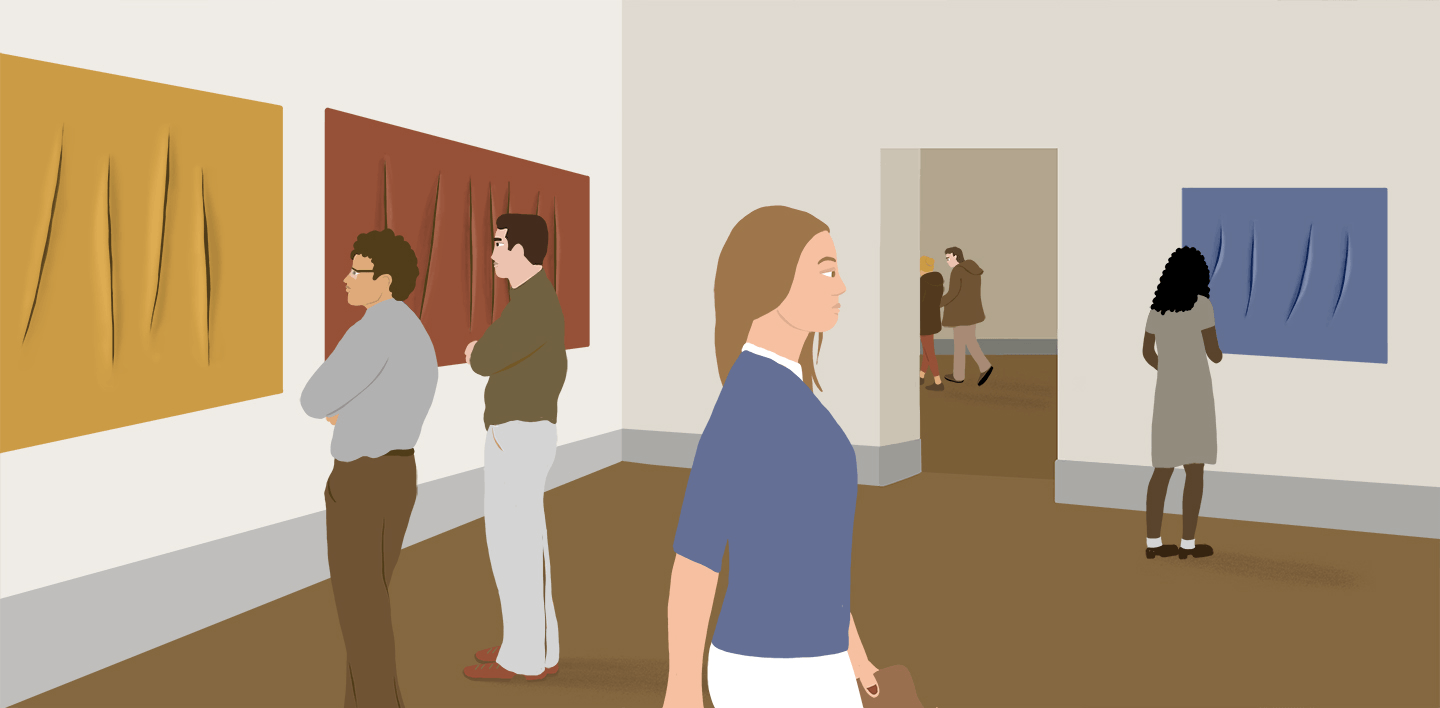
Un giorno, tutto questo, è il tema della trentunesima edizione del Salone Internazionale del Libro che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Il Tascabile partecipa al progetto 5domande ideato quest’anno dal Salone, un questionario nato per “riflettere sul mondo in cui viviamo e sul mondo che ci aspetta, e la cui forma dipenderà evidentemente anche da noi”. Abbiamo risposto alle 5domande girandole a donne e uomini arrivati sul Tascabile dai percorsi più diversi: dallo sport all’astrofisica, passando per l’arte contemporanea. Il futuro non è ancora scritto: c’è chi però, raccontandolo, può aiutarci a cambiarlo.
Oggi ci siamo chiesti, che cosa voglio dall’arte: libertà o rivoluzione? La creazione artistica può bastare a se stessa? O deve porsi l’obiettivo di cambiare le cose? Libertà o rivoluzione: cos’è l’arte, e che cosa deve e può dare a tutti noi?
Sofia Silva – artista, giornalista
Che cosa voglio? ‘Volere’ è un capriccio e gli unici capricci che trovano posto nell’arte sono quelli degli antichi maestri, Guardi, Tiepolo, Goya… Anche “Volere è potere” è fuori-luogo nello studio dell’artista: ogni grande artista si guarda bene dalla padronanza. Volere è meschino. Chi si avvicina all’arte, visiva e non, cercando erudizione culturale, complicità politica o svago domenicale, le si avvicina miseramente. Piuttosto, vista l’occasione per la quale rispondo a queste domande… Bello se gli scrittori italiani cominciassero a guardare, a raggiungere, a studiare l’arte visiva fuori dalle mostre blockbuster o dai nomi celebri del divismo artistico dati ciclicamente in pasto agli spettatori.
Da uno studio non troppo empirico condotto subdolamente, ho capito che parte dei nostri scrittori s’appassiona di graphic novel, d’illustrazione e di celebri nomi ormai passati alla mitologia extra-artistica, come Damien Hirst. Si furoreggia per l’aspirante emulo di Giacometti che bazzica piazze o salotti cittadini e non si sa cosa passi per le collezioni internazionali. Si scambia la creatività per arte. Questo condiziona le parole: ricamare il proprio lessico pensando a un dipinto della pittrice georgiana Tamuna Sirbiladze dà un esito ben diverso a quello raggiunto ispirandosi a un murales di un orsetto travestito da Frida Kahlo che incita alla fratellanza. L’arte che guardi influisce sulle storie che scrivi. Per non parlare poi di questa costante: grandi artisti italiani che desirerebbero testi letterari sui propri cataloghi ma non sanno a chi chiedere e scarsi artisti italiani che godono dei testi di grandi scrittori. L’arte è materia di estrema responsabilità e prima di esporsi è necessario costruirsi un giudizio critico, ma pare che questo importi a ben pochi.
Mi si chiede poi se “la creazione artistica può bastare a se stessa” e “che cosa l’arte deve e può dare a tutti noi”. L’arte non deve né può, tantomeno basta, parola che solleva un’aria di sufficienza. L’opera d’arte è libera dalla fame di coordinate e di significato; se è grande, è libera anche dall’individuo che la dipinge, scolpisce, ricama, concepisce. L’opera d’arte vede la Storia a volo d’uccello, non ne è suddita. È assoluta, sciolta da; figlia ingovernabile, nasce dall’artista e dal suo sguardo sul mondo, ma né l’artista né il collezionista né il mondo la possiedono. Ogni grande opera inaugura una rivoluzione dello sguardo. A tutti noi o a pochi di noi l’arte può dare l’occasione di imparare a guardare una stanza, un pensiero, un oggetto, il tempo.
Fabio Deotto – giornalista, autore di Un attimo prima
Posto che il verbo “dovere”, a mio parere, andrebbe espunto da ogni discorso sulla scrittura o sulla lettura, credo che i romanzi abbiano più incidenza sociale e politica di quanto si sia disposti ad ammettere. In una intervista del 2013 per il New York Times, Mohsin Amid disse che la narrativa ha un enorme potere sociale dal momento che “può dire pubblicamente ciò che altrimenti apparrebbe indicibile, contrastando così un silenzio forzato che è l’arma preferita di chi detiene il potere.” Amid, nello specifico, faceva riferimento ad autori come Saadat Hasan Manto, che sono riusciti a rendere visibili personaggi che nella realtà Pakistana venivano confinati ai margini del campo visivo, ma gli esempi sono molteplici. Da sempre i libri – e i romanzi in particolare – hanno rappresentato una minaccia per chi deteneva il potere, o a chi avesse un qualsiasi interesse a mantenere intatto lo status quo, soprattutto quando veicolavano narrazioni non consolatorie: i libri possono passare di mano in mano, possono diffondersi sottotraccia, non richiedono accessi certificati a una piattaforma, non viaggiano su frequenze che possano essere schermate, richiedono una partecipazione attiva, privata e invisibile del lettore, e dunque hanno il potere di diventare un cuneo che insiste sulle crepe di qualsivoglia narrazione ufficiale.
Credo però che il vero elemento dirompente non consista solo nel fatto che i romanzi possano “dire ciò che è vietato dire”, ma anche nella loro capacità di rendere visibile l’invisibile, di mostrare ciò che altrimenti parrebbe impossibile immaginare: quando un autore o un’autrice scrive un libro crea una dimensione immersiva, consente ad altre persone di fare un giro nella propria testa, di adottare il punto di vista di una persona sconosciuta, di vivere “per simulazione incarnata” una condizione che non potrebbe essere comunicata unicamente attraverso una consegna di dati e nozioni. Basti pensare a come alcuni dei romanzi che leggiamo nel corso della nostra vita, soprattutto durante l’adolescenza, fungano in modo più o meno cosciente da palestra mentale in cui allenarsi ad affrontare il mondo esterno.
Fotografare una situazione dal proprio punto di vista, applicare il proprio filtro alla realtà tangibile, rielaborare informazioni ed esperienze per immaginare un presente (o un futuro) diverso sono atti umani; quando vengono fatti in forma pubblica, consentendo a un numero indistinto di altre persone di prenderne parte, lo si desideri o meno, diventano atti politici. I libri moltiplicano il numero di sguardi sulla realtà, e così facendo ne aumentano la profondità, rendendo intelligibile una complessità che sarebbe impossibile cogliere utilizzando un solo filtro percettivo. I romanzi hanno il potere di cambiare lo sguardo delle persone sulla realtà che le circonda, il modo in cui la osservano, concepiscono e dunque vivono; e dato che il “mondo” per come lo intendiamo è fatto di persone, allora sì, i romanzi hanno il potere di cambiare il mondo.
Mohsin Amid è convinto, come lo è Olive Senior e come lo era George Orwell, che ogni narrazione sia intrinsecamente politica “come lo è l’atto di votare, e come lo è l’atto di non votare.” Io credo però che questa generalizzazione sia fuorviante. Il fatto che i romanzi possano avere un’influenza sulla realtà non significa che un autore debba orientare la propria scrittura sul nord di questa bussola. Anzi, sono convinto del contrario: un approccio strategico o finalistico porterebbe a brutti romanzi, e anche a cattiva propaganda se è per questo. Per quanto possa sembrare contraddittorio, il fatto che un’opera possa avere una valenza a livello privato o sociale non è affare di chi scrive; e questo secondo me perché non è tanto chi scrive a rendere la propria opera politica, ma chi quell’opera la legge. Un lettore può trovare spunti di riflessione socio-politica in qualunque opera, anche in un racconto per bambini, anche nel cosiddetto “romanzo di intrattenimento “, questo perché ogni storia, più che una creazione, è una rielaborazione, una distorsione, un riarrangiamento o un ribaltamento della realtà esistente. E allora, cosa dovrebbe fare un autore? Con quale approccio dovrebbe affacciarsi al foglio bianco? Come ho già detto, non credo si debba imporre nulla a chi legge o a chi scrive, e credo che le generalizzazioni siano sempre nocive.
Però posso utilizzare il verbo “dovere” in maniera riflessiva, e parlare per me. Uno scrittore non può forzarsi ad affrontare tematiche che non conosce o non sente sue, quando ci prova di solito combina disastri. Ma può imporsi di non aggiungere filtri spuri al modo in cui vede, concepisce e riconcepisce la realtà in forma narrativa: mi riferisco a tutte quelle sirene che spesso portano a dirottare la propria ricerca poetica verso traguardi allettanti, come arrivare in classifica, vincere un premio letterario, cucirsi addosso una veste autoriale da consegnare ai posteri, intercettare un’opzione cinematografica, guadagnarsi il titolo di intellettuale o semplicemente riempirsi il conto in banca. L’unico dovere che sento è di essere onesto anche nella finzione: quello che mi interessa è gettare il mio punto di vista su quell’angolo di realtà che mi impedisce di distogliere lo sguardo, o che mi tiene sveglio la notte, o che mi scuote o inquieta a sufficienza da decidere di passare lunghe ore con le mani sulla tastiera. Il mio solo “compito” è assicurarmi che ciò che mi spinge a scrivere siano le storie, i percorsi mentali che le generano, gli spunti reali che le innescano, e non invece finalità che nulla hanno a che fare con la scrittura. Io non posso far molto di più che consegnare il mio sguardo, assicurarmi che corrisponda il più possibile a ciò che vedo e a ciò che penso. E ricordarmi sempre che non sono gli scrittori, ma i lettori, a dare immagine, suono e vita a quanto scritto su carta.