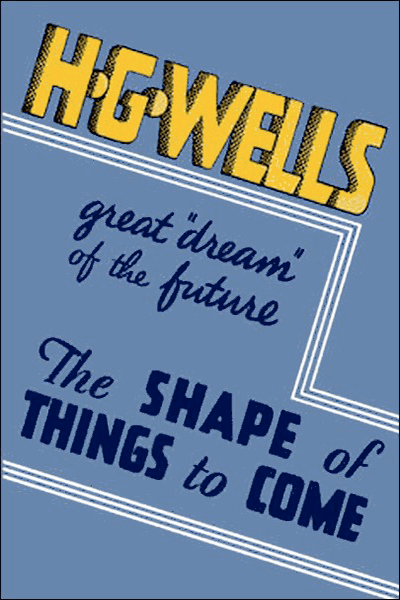T he Institute of Things to Come è un progetto di Ludovica Carbotta e Valerio Del Baglivo: artista lei e curatore lui, hanno ideato una mostra in quattro tempi che avrà luogo alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino da questo febbraio fino al prossimo ottobre. Quattro sono gli artisti chiamati a animare le stanze della Fondazione con film, performance e workshop, per indagare il destino della terra, per comprendere cosa ne resta del concetto di futuro, oggi.
Gli artisti dell’Institute immaginano scenari impossibili, futuri lontani che raccontano il presente: dalle distopie di Bedwyr Williams, all’Afrogalactica di Kapwani Kiwanga, ai cetacei e i sogni lucidi Alex Cecchetti, fino ai fondali oceanici della coppia di artiste Louise Hervé e Chloé Maillet, gli artisti selezionati da Carbotta e Del Baglivo ci proiettano a distanze siderali, mescolando tutto, tempo, ossessioni, paure e desideri, per immaginare un mondo, senza che questo ci debba contenere, senza che questo debba rispondere alle esigenze degli uomini. Abbiamo conversato con i due ideatori del progetto, sul mondo a venire.
L’artista come indovino
Valerio Del Baglivo ci tiene a dire il suo obiettivo non è comprendere quello che ci aspetta e che gli artisti non sono affatto dei rabdomanti, “una visione che a me va stretta” – mi spiega – “anni fa seguivo un corso di Cultural Studies a Palermo, e negli Studi Culturali t’insegnano che un cultural turn, cioè un cambiamento epocale nelle società può essere riconosciuto grazie ad una serie di caratteristiche; una di queste è che gli artisti sono in grado di anticipare i cambiamenti all’interno delle loro ricerche, di precederne l’arrivo nel pensiero comune e anche in quello scientifico”.
L’obiettivo di The Institute è prendere in considerazione un aspetto che le scienze sociali condividono, cioè mettere la cultura al centro dell’avanzamento di una società, al centro dei dibattiti contemporanei, perché altrimenti “si finisce per accostare la figura dell’artista a quella dell’indovino, a ridurlo a un’anima sensibile. Gli artisti possono essere in grado di leggere la condizione sociale e politica in cui viviamo, ma è perché la osservano con maggior e vivida consapevolezza.”
Prevedere il futuro
Se questo Istituto del mondo a venire non serve a predire il futuro, allora, qual è la sua funzione? Va compreso, forse, cos’è che si intende con previsione, quale visione si voglia attribuire a questa parola, perché – spiegano i curatori –, se si associa al campo economico o socio-politico, questa parte da dati statistici e cifre che descrivono avvenimenti passati e che non ci permettono di proiettarci oltre certi limiti temporali, che siano di qualche mese o di pochi anni, “e soprattutto, si fanno per paura, per non trovarsi impreparati di fronte a possibili disastri economici o mutamenti politici.” Qui, invece la prospettiva deve essere un’altra, capace di proiettarci in mondi che potrebbero essere e non essere: “nel campo culturale, invece, avviene l’opposto e le previsioni viaggiano su tempistiche improbabili, come cento o duecento anni, e si fanno non per paura del futuro, ma per riflettere, contraddire, mettere in discussione lo status quo. Si tratta di ragionamenti che hanno a che fare con l’adesso: questa è la differenza, si immaginano futuri improbabili e lo si fa non con la paura di dover trovare strumenti per affrontare situazioni inaspettate, ma al contrario, perché queste situazioni completamente assurde servono per ragionare sulla contemporaneità”.
Il nome
The Institute of Things to Come mutua il titolo da un romanzo del 1933 di H.G.Wells, The Shape of Things to Come: il romanzo, ambientato nel 2106, è una cronaca storica della vita sulla terra dal 1933 in poi, scritta da un diplomatico; è un romanzo di fantascienza che racconta il futuro salutandolo come passato e che di anno in anno si sta trasformando in una storia controfattuale, che ora si avvera e ora si tradisce. “Il testo di Wells rimane un riferimento non solo per lo sforzo con il quale egli ha immaginato un futuro ma proprio perché ha confuso i tempi, ha ipotizzato un futuro, che, però, nella finzione letteraria è un passato. Questo continuo intersecarsi di dimensioni temporali, questa sovrapposizione di tempi è forse l’aspetto più interessante ed è condivisa da tutti gli artisti invitati – ma anche di molti altri che non sono in questa lista e che utilizzano la finzione come pratica e metodo di ricerca artistica. The Shape of Things to Come è, poi, un titolo forte: a noi affascinava l’uso della parola “things”, così aperta, che ci permetteva di inserire nel progetto molte cose, perché indica non solo oggetti, ma processi e fenomeni. La correzione da ‘shape’ a ‘Institute’ rimanda a aura accademica, una risonanza da istituto scientifico.”
AFROGALACTICA: A brief history of the future (teaser) from Kapwani Kiwanga on Vimeo.
I quattro artisti
Gli artisti coinvolti da Carbotta e Del Baglivo lavorano su più supporti visivi, rispondendo all’interesse dei due curatori per i mixed media. Ad aprire è Bedwyr Williams, in mostra da Febbraio, con Echt, che ci proietta in un futuro prossimo nel quale le istituzioni britanniche e i sistemi di governo sono crollati; a seguire, Kapwani Kiwanga (in mostra dal 13 Aprile), Alex Cecchetti (dal 21 Giugno) e Louise Hervé e Chloé Maillet, con The Waterway (14 Settembre 2017). La selezione si basa sui temi che questi hanno affrontato nei loro lavori, sono, dice Valerio,
artisti che abbiamo conosciuto negli anni in cui abbiamo vissuto a Londra: le opere che andremo a mettere in mostra sono tutti lavori già esistenti, perché, come abbiamo detto, la parte della nuova produzione sarà quella affidata ai workshop. Il progetto dietro The Institute va considerato nella sua interezza: la selezione degli artisti ci consente di affrontare vari temi legati al futuro, moltiplicandoli, dalla paura dell’invecchiamento alla ricerca di luoghi di vita su altri pianeti, fino alla dissoluzione politico sociale degli attuali modelli democratici in atto o alla questione postcoloniale.
In mostra prevalentemente saranno installazioni filmiche, ma queste sono concepite in maniera ogni volta diversa: sono di tipo immersivo, come nel caso di Bedwyr Williams, che crea un ambiente che risponde al film, mentre, nel caso di Kapwani Kiwanga, i video sono in parte d’archivio e in parte originali e saranno accompagnati, il giorno dell’inaugurazione, da una performance in cui l’artista impersonerà un’antropologa, dando vita a una lecture accademica vera e propria su una fantastica conquista dello spazio da parte degli Stati Uniti d’Africa.
Invece Alex Cecchetti presenterà CETACEANS, un concerto scritto per accompagnare il pubblico in un intero ciclo di sonno di un’ora e mezza. A chiudere, Louise Hervé e Chloé Maillet: forse, nel loro caso, il lavoro fatto con gli studenti del workshop sarà incluso nella mostra.
The original is unfaithful
Ludovica Carbotta ha intitolato una delle sue opere The original is unfaithful to the translation, una citazione da Borges, che si dice è grato per “la felice e creativa infedeltà” delle traduzioni europee dei suoi romanzi; così viene da chiedere se anche le opere degli artisti selezionati non siano luoghi in cui la realtà e la finzione si mescolano continuamente, creativamente infedeli:
forse sì, anche per gli artisti invitati a The Institute potremmo parlare di infedeltà, perché molto spesso nei loro lavori infatti si assiste a una rilettura della storia passata o di teorie scientifiche. Quella che prospetta Borges è un’idea di moltiplicazione del testo e dell’opera che in quel modo vive in altre lingue: un concetto molto importante anche qua, dove c’è un’opera al centro, ma che viene ridiscussa nel contesto del workshop.
E sono proprio gli workshop a costituire una parte fondamentale del progetto di Carbotta e Del Baglivo:
Non volevamo che questo progetto permettesse solo un approccio ricettivo passivo, ma che fosse un momento in cui attivare una discussione: il fatto è che questa non si avvia da sola, è un passo che va mediato e guidato. Così abbiamo chiesto agli artisti di ideare dei workshop e di farlo insieme a un’altra persona che possibilmente non venisse da un campo artistico, in modo che il suo ruolo fosse quello di giustificare queste teorie fittizie, di dargli un fondamento scientifico, per cui partire a interrogare gli scenari ipotizzati come fossero reali: immaginiamo che gli stati africani controllano le potenze occidentali da decenni, come ci comportiamo? che vuol dire cosa significa per noi? Così i partecipanti, che poi sono principalmente anche loro artisti, guidati da loro, potranno calarsi in questi scenari, discutere queste situazioni come fossero reali, immedesimarsi in queste ipotesi di vita su Marte o nei fondali oceanici. Fondamentalmente volevamo posizionare la Storia con la S maiuscola nello spazio di una dimensione privata e individuale.
L’arte dei sogni
Louvre è una delle opere più note di Alex Cecchetti: si tratta di un tour nel museo, senza il museo, così i suoi lavori si muovono tra presenza e assenza, per esplorare nuove forme di comunicazione. Per The Institute of Things to Come Cecchetti ipotizza che in futuro potremmo comunicare senza utilizzare le parole, ma tramite sogni e musica. CETACEANS è una installazione sonora immersiva che indaga nuove forme di linguaggio, un concerto per coro, armonica di vetro e waterphone, che indaga il sogno, le vertigini, i lassi di tempo ed i sogni lucidi, come stati in cui si produce una diversa forma di comunicazione, dove si intrecciano note, poesie e suoni di voci di balena. “L’installazione sollecita i sensi grazie a diverse sorgenti sonore, dando l’impressione di disincarnazione e alla deriva la coscienza via. Alla fine, gli spettatori potranno addormentarsi, e il concerto sarà sperimentato solo nei loro sogni.” spiega Del Baglivo e aggiunge che anche il workshop sarà probabilmente condotto da un neuroscienziato, per esplorare queste ipotesi e forme di telepatia. Durante il workshop gli studenti saranno condotti in diversi luoghi della città per condurre alcuni esperimenti, in cui la comunicazione verbale non sarà permessa, sostituita dall’uso di linguaggi metaforici come la poesia e i tarocchi.
“A noi qui non interessa proporre un esercizio di stile, ma utilizzare il futuro come esercizio di emancipazione, come possibilità di autorappresentarsi, come giudizio critico sull’attualità. The Institute of Things to Come è un allenamento strategico contro le difficoltà e le incertezze del presente stato di crisi: non si tratta di capire se la fine e l’apocalisse siano vicine o no, ma di esercitare un processo di immaginazione personale, raccontare quello che noi potremmo diventare singolarmente e il tipo di società in cui potremmo vivere; è anche per questo che il futuro ci attrae. Tra gli artisti non c’è una visione univoca e anche tra immaginario utopico e distopico il rapporto è spesso ambiguo, per questo abbiamo chiamato 12 studenti, perché a ognuno di essi chiederemo di interpretare queste cose a un livello personale.”
Afrogalactica
Tra gli artisti invitati, quella che mi affascina di più è Kapwani Kiwanga, che metterà in scena Afrogalactica, un progetto in cui si mette in scena l’Odissea degli Afronauti nello spazio. Parte dalle sue ricerche sull’Afrofuturism e dal lavoro “Space is the Place” di Sun Ra, del 1974, in cui il musicista propone un’utopia spaziale, una fuga intergalattica per gli africani e gli afroamericani. Kiwanga, dal futuro, racconta quello che succede dopo l’8 dicembre 2058, il giorno in cui nascono gli Stati Uniti d’Africa, una data scelta per commemorare il 100° anniversario della prima Conferenza pan-africana di Accra: racconta, come un’antropologa, degli sforzi scompiuti nel campo dell’esplorazione dello spazio dall’inesistente Agenzia spaziale degli Stati Uniti d’Africa.
Tutti gli artisti scelti sono importanti perché intrecciano video, performance, producono oggetti, ma Kapwani lo è per altri due motivi: primo perché la sua pratica include la performance con un approccio molto diverso da quello degli altri artisti coinvolti, e interpreta un personaggio che è non solo un accedemico, ma anche una donna e una donna di colore. Il secondo aspetto per cui è importante Kapwani è che, appunto, il suo personaggio indaga il tema del postcolonialismo, un tema che in un paese come l’Italia non viene affrontato ma che, invece, dovrebbe esserlo. L’Italia ha una storia coloniale e, se questa è inferiore rispetto a quella di paesi come Francia e Inghilterra, lo è dal punto di vista della potenza economica, non per i processi che ha innescato: paesi come l’Eritrea e la Libia continuano a vivere nel mito dell’Italia, come altri paesi africani e asiatici vivono nel mito dell’Inghilterra.
Del Baglivo, che condivide con lei le tematiche della bio e political fiction e della gender materiality, sottolinea l’importanza di Kapwani perché, nella creazione di un’altra identità, mette al centro se stessa, il modo in cui si reinterpreta la storia e il modo in cui la storia si impone e si subisce come persone. Questo si intreccia necessariamente alle questioni del post-colonialismo, ma “il fatto è che il tema del colonialismo italiano è stato legato anche al fascismo e, nonostante lo preceda cronologicamente, questo ha fatto sì che si incastrasse in altre tematiche storiche e politiche, e che quindi per questo venisse sempre affrontato facendo cioè prevalere il periodo storico rispetto al tema in sé.”
Torino e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Il workshop di Kapwani Kiwanga, “Future Ruins: Reading the City, Writing its future”, ideato insieme a Mirene Arsanios, chiede di rileggere la città, vuole reinventare una storia a partire dalle tracce del presente. Se il passato coloniale non è così visibile in una città come Torino – più facile trovarne i segni a Roma, spiega Valerio – si può sempre far riferimento agli stabilimenti Fiat di Asmara e ancora molte architetture possono essere inventate: “adesso stiamo lavorando con Kiwanga e Arsanios alla ricerca di architetture futuriste da cui loro potranno sviluppare altre storie: possono essere monumenti così come luoghi, strade e palazzi, che fanno parte dell’immaginario civile e sociale della città. Mirene Arsanio è una curatrice e scrittrice che ha fondato uno spazio a Beirut che si chiama Ninety-eight Weeks, dove ogni 98 settimane, che sono due anni meno il mese di agosto, si sceglie un tema e lo si approfondisce. Arsanios scrive fiction e ha un giornale di scrittura in lingua araba e francese molto bello dove si raccolgono storie di individui che si rapportano alle città” spiega Valerio “e ovviamente c’è molto di suo nel workshop. Beirut negli ultimi venti-trent’anni – lei è della nostra generazione – ha cambiato profondamente situazioni di guerra, migrazioni, e è naturale che le persone che vivono questa città e il gruppo di lavoro di Arsanio partano sempre dal legame personale con la città.”
Sarà la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a ospitare questo progetto, con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando ORA! Linguaggi contemporanei produzioni innovative: “la Fondazione l’abbiamo scelta per l’incredibile sforzo didattico profuso negli ultimi anni. È stato il primo posto a cui abbiamo pensato di chiedere una collaborazione, perché tornando indietro sono anni che dà attenzione a corsi e residenze per curatori e altro e lo fa con una generosità incredibile, con costanza e con costanza è riuscita a mantenere questo programma per dieci anni.”