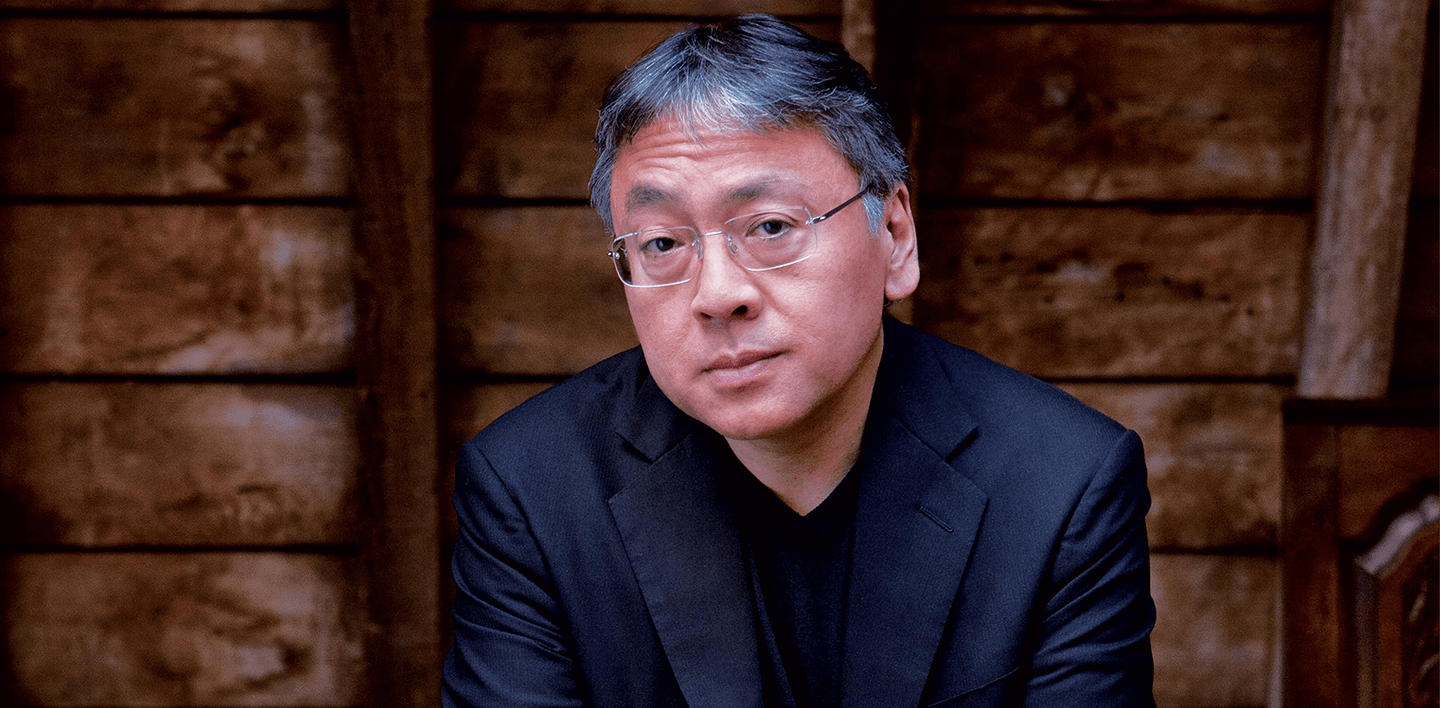
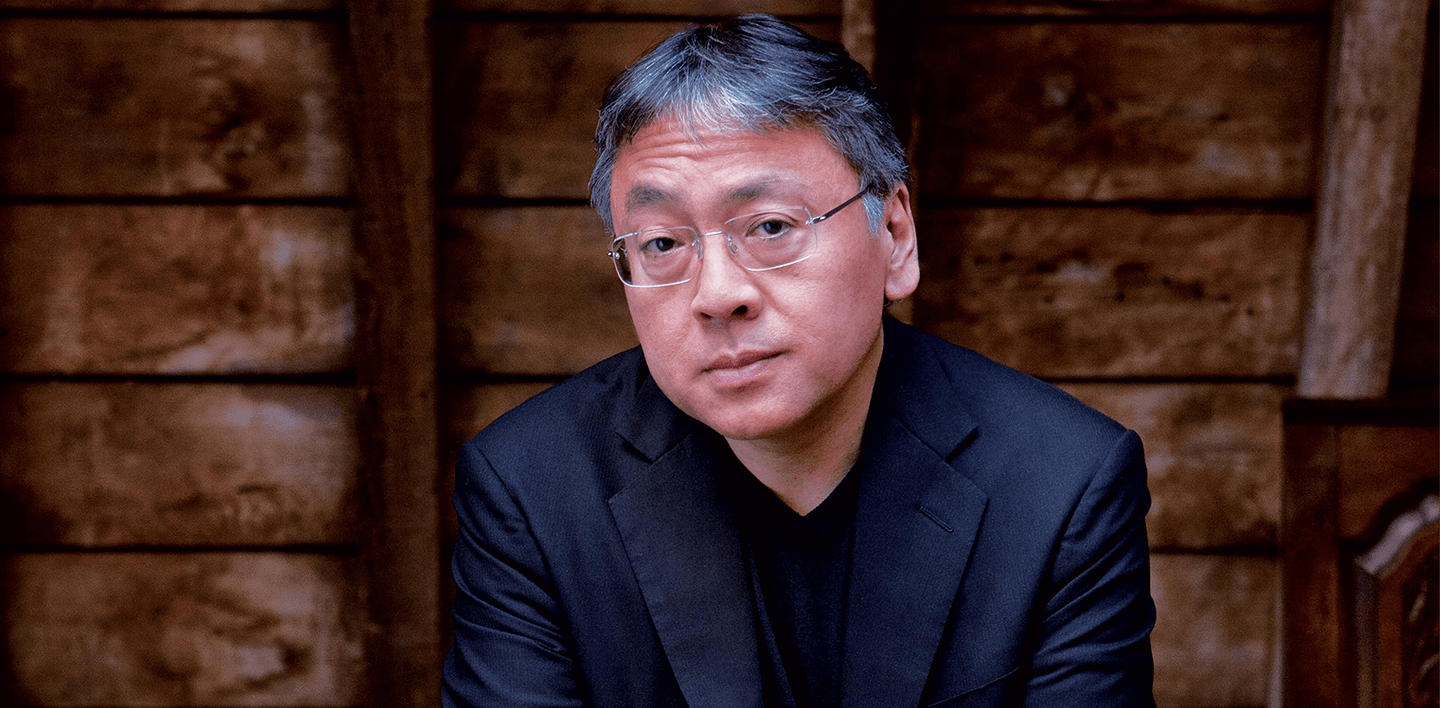
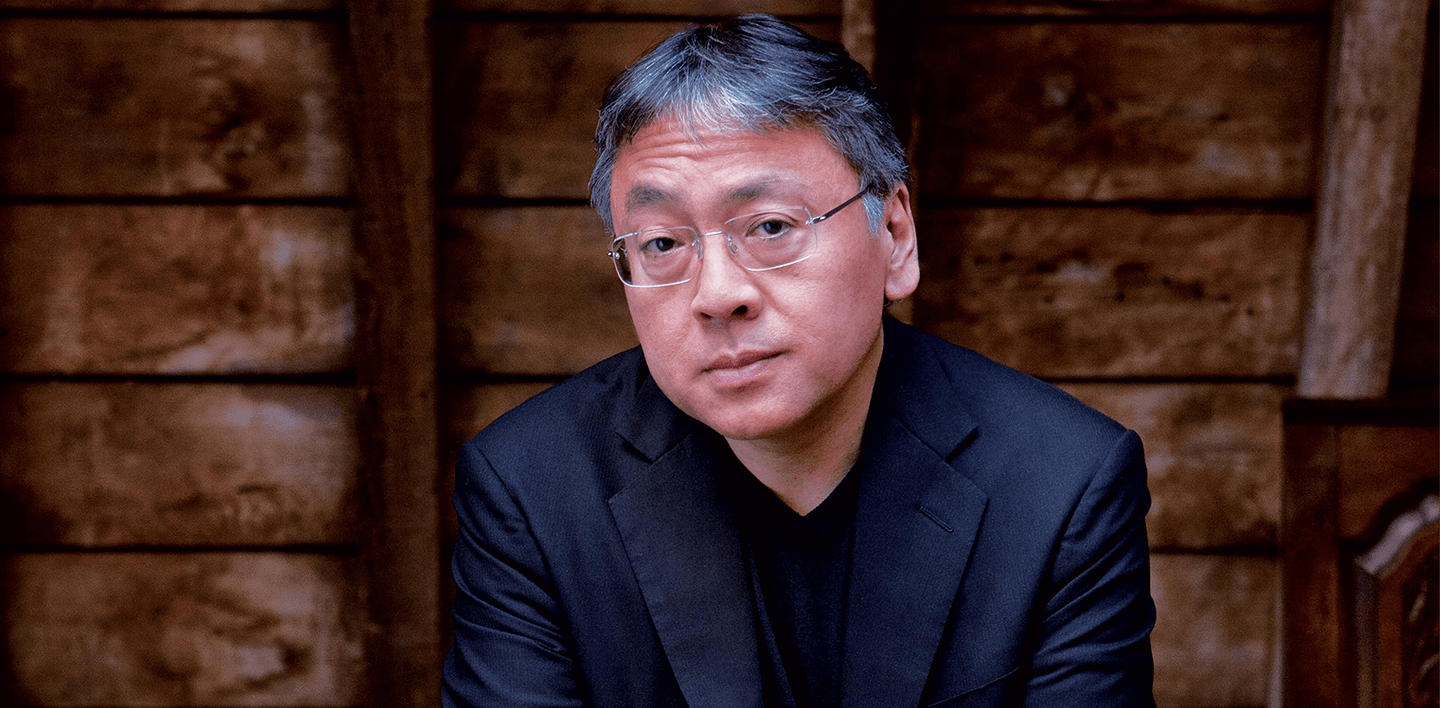
L a storia d’amore è materiale infiammabile. Chi vuole fare letteratura deve maneggiarla con cura, perché sbilanciarsi nel rosa puro è un attimo: e se da un lato è vero che questo riguarda principalmente le autrici (che se parlano d’amore finiscono quasi senza eccezione nella categoria “rosa”, a prescindere dalla qualità del romanzo), è anche vero che scrivere d’amore in maniera non prevedibile, banale o limitandosi a tirare le leve del cliché è difficile per tutti. Kazuo Ishiguro non è un autore che venga istintivo o immediato associare alla narrazione del sentimento amoroso: eppure la sua capacità di raccontare l’amore, utilizzandolo come motore della vicenda senza farne la vicenda, è straordinaria. Nell’amore romantico, Ishiguro trova spesso una chiave di volta, il punto su cui si regge l’architettura di un intero romanzo.
Quel che resta del giorno, del 1989, è il suo terzo romanzo. Ambientato nell’Inghilterra del secondo dopoguerra, è un lungo monologo interno di Stevens, il maggiordomo di un’antica magione nobiliare. Quando lo incontriamo, Stevens ha chiesto un permesso al suo datore di lavoro – il possidente americano Farraday, che ha acquistato Darlington Hall dopo la morte del suo proprietario, Lord Darlington – e sta viaggiando verso il Devon, una zona della Cornovaglia dove risiede una sua ex collega, la governante Miss Kenton ora coniugata Benn, che in una lettera gli ha confidato di stare attraversando un brutto momento nel suo matrimonio. A bordo della Ford presa in prestito da Farraday, Stevens ripercorre con la memoria gli anni Trenta e Quaranta a Darlington Hall, e riflette sul senso di una vita spesa al servizio degli altri, perfezionando l’arte di non essere altro che il miglior maggiordomo del Regno.
Narratore inaffidabile, completamente disconnesso dai suoi sentimenti e incapace di riconoscerli, Stevens – che anche nei suoi monologhi interni rinuncia ad avere un nome proprio – è un uomo profondamente solo, che deve riconciliare la sua visione di sé con la totale dedizione a un padrone filonazista e al sacrificio della vita privata in nome di un’identità del tutto votata al servizio abnegante verso persone di grande rilevanza politica e scarsissima statura morale. Mentre viaggia per incontrare la vecchia amica, Stevens non arriva mai a riconoscere in quel viaggio il suo ultimo tentativo di riconciliarsi con sentimenti a lungo repressi e rimediare al più grande, tragico errore della sua vita: aver ignorato l’amore fra lui e Miss Kenton – nato mentre lavoravano insieme – che ha finito per sposarsi quasi per ripicca con l’uomo sbagliato.
Questo amore disperato e insoddisfatto non viene mai raccontato direttamente: lo si intuisce nei vuoti, nei momenti in cui a Stevens vengono meno le parole per descrivere le sue emozioni. E quando i due finalmente si ritrovano, la chiusura di quel vuoto non porta alla felicità. Il rosa tradizionale prevede il lieto fine; la letteratura sa che il lieto fine non è sempre la soluzione più interessante e onesta dal punto di vista intellettuale. Stevens è ormai troppo anziano per cambiare davvero e trovare se stesso: l’amore l’avrebbe salvato, ma lui l’ha respinto. Non è strano, né un tradimento del materiale di partenza, che nel film tratto dal romanzo – con protagonisti Anthony Hopkins ed Emma Thompson – la storia d’amore mai riconosciuta sia il punto centrale della vicenda, e che la versione cinematografica di Quel che resta del giorno sia considerato un classico dei film in costume in cui si piange tanto (come del resto buona parte della produzione di James Ivory).
Il rosa tradizionale prevede il lieto fine: la letteratura sa, però, che il lieto fine non è sempre la soluzione.
Si piange moltissimo, e senza ritegno, con Non lasciarmi. Qui Ishiguro abbandona ogni reticenza e all’interno di uno scenario distopico crea uno dei più grandi e struggenti triangoli amorosi della letteratura contemporanea. Ambientato in un tempo imprecisato che colloca il romanzo a metà fra la distopia e l’ucronia, Non lasciarmi è narrato dal punto di vista di Kathy, allevata insieme a decine di altri bambini in una scuola isolata nella campagna britannica. Kathy, come tutti i suoi compagni, è un clone: è stata creata in laboratorio per fornire pezzi di ricambio originali a esseri umani che vivono nel mondo esterno, e che a differenza di lei sono dotati di passaporto e diritti civili. I cloni non svolgono altra funzione che quella sussidiaria di donatori vivi o di assistenti ai donatori: una volta lasciata la scuola non devono fare altro che attendere la chiamata che li porterà sul tavolo operatorio per sacrificare un rene, un pezzo di fegato, un polmone, il cuore. Quando l’ultimo organo utile viene espiantato, il donatore ha completato la sua missione. Kathy cresce insieme a Tommy e Ruth, e l’amore fra lei e Tommy – ostacolato dalla relazione fra Tommy e Ruth – è il nodo centrale della storia: fra i donatori, infatti, si diffonde l’idea che l’unico modo per rimandare il momento in cui inizieranno a morire sia dimostrare di essere davvero innamorati.
Niente di tutto questo è vero, e i donatori non hanno scampo: Kathy, Tommy e Ruth sono costretti ad andare incontro al proprio destino. Una riflessione sulla natura umana declinata attraverso la fantascienza che nel 2016 abbiamo visto tornare in Westworld, la serie di HBO in cui i replicanti perfetti di un parco a tema vanno alla conquista della loro umanità; ma là dove Westworld si preoccupa di essere il più possibile preciso sul funzionamento della scienza alla base del suo mondo, Non lasciarmi è volutamente vago. Come vengano creati i cloni, da chi, in quali condizioni e con quali accorgimenti non viene mai specificato: l’amore negato e poi riconosciuto e infine ucciso dalla crudeltà del mondo è tutto quello che conta. La voce di Kathy è la voce di qualsiasi giovane donna alle prese con la scoperta della sessualità, dell’amicizia, della lealtà, del rapporto conflittuale che si crea spesso fra le ragazze, e con la gestione di un sentimento inestinguibile per quanto del tutto irrilevante agli occhi del mondo, come nelle leggende più cupe e poetiche che da sempre gli uomini usano per raccontare la genesi dell’universo.
Più complesso, e molto meno esplorato, è il legame coniugale. Il rosa tradizionale non lo ama molto, preferendo il brivido della passione incipiente al quieto svolgersi dei giorni di un amore maturo, e in letteratura il divorzio funziona meglio di un matrimonio felice. Ne Il gigante sepolto, Ishiguro fa di una coppia di anziani e del loro legame saldo e profondissimo il centro di un romanzo che, se come fantasy è forse un po’ anomalo, funziona molto bene come esame della natura dei rapporti, della memoria, del perdono e dell’essenza dell’amore. Axel e Beatrice sono due britanni nella terra di Artù, quando Artù è già morto da tempo. Sono sposati ormai da molti anni, nemmeno loro sanno quanti, perché la nebbia che ogni notte invade il loro villaggio sembra eliminare tutti i ricordi: hanno forse avuto un figlio, tempo prima, e vorrebbero rivederlo prima che la morte se li prenda. A piedi in un mondo attutito fra minacce sinistre, villaggi sassoni ed eroi in disarmo, Axel e Beatrice procedono uniti e senza perdersi mai di vista, prendendosi cura uno dell’altra in ogni circostanza, verso la residenza della loro progenie o forse verso la morte, come Orfeo ed Euridice al contrario, e senza voltarsi indietro.