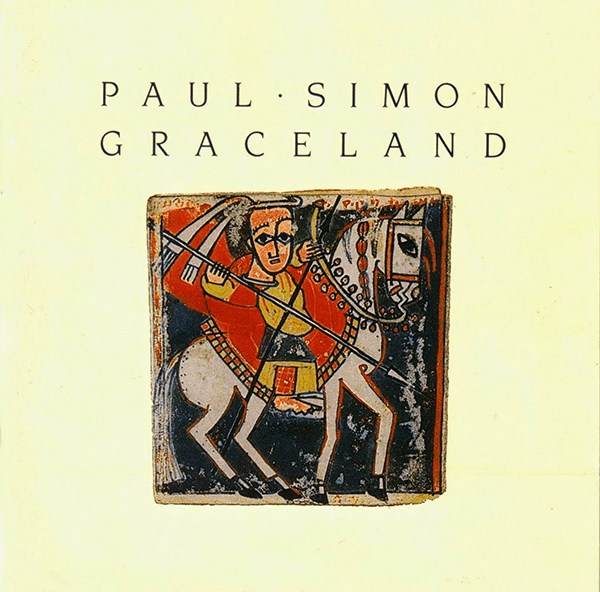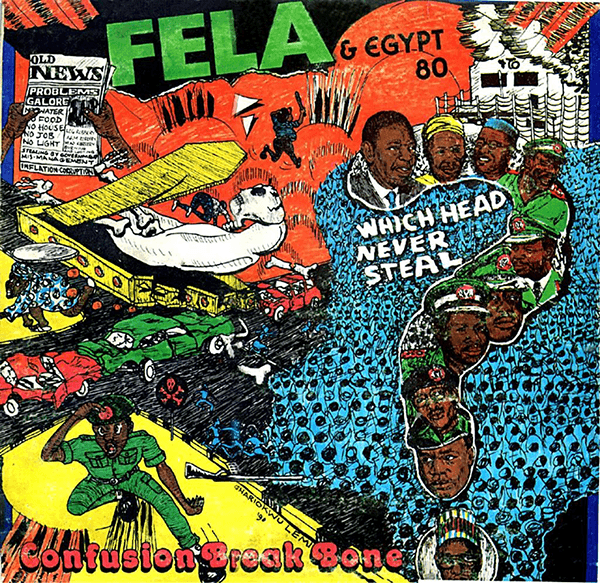N el saggio The Discourse of World Music, incluso nell’antologia del 2007 Taking Popular Music Seriously, il sociologo britannico Simon Frith scrive che si tratta di “un genere pop insolito, nel senso che ha un preciso momento originario”. Allude a un luogo e a una data: il 29 giugno 1987, in una saletta del pub Empress of Russia a Islington, nel nord di Londra, si svolse un meeting al quale parteciparono esponenti di 11 etichette discografiche indipendenti dalla vocazione specialistica, tra cui Stern’s, World Circuit, GlobeStyle, Hannibal, Cooking Vinyl ed Earthworks, insieme ad alcuni operatori del settore come il Dj radiofonico Charlie Gillett e il produttore Joe Boyd, avendo all’ordine del giorno la promozione di “forme differenti di musica non ancora classificate secondo i codici occidentali”. Al primo incontro ne seguirono altri, finché venne presa la decisione d’investire 3.500 sterline in una campagna pubblicitaria volta a reclamizzare quei prodotti e culminante in una compilation su cassetta allegata in ottobre all’influente settimanale New Musical Express. Il comunicato stampa emesso dai partecipanti a fine luglio recitava: “La richiesta di registrazioni di artisti non occidentali è sicuramente in crescita. E qui cominciano i problemi per i potenziali acquirenti dei dischi di world music. I negozi del centro non trattano quei titoli, né dispongono di una sezione identificabile in cui cercarli e quegli stessi dischi non hanno una classifica di vendita dedicata. A quel punto gli acquirenti, fatta eccezione per i più tenaci, rinunciano. E chi può dar loro torto?”.
La denominazione necessaria per individuare la sfera d’intervento era stata scelta per alzata di mano: “World Music” aveva prevalso largamente su “Tropical”, “Ethnic”, “International Pop”, “Roots” e “World Beat”. Era nondimeno una definizione approssimativa che abbracciava un agglomerato di produzioni non angloamericane create da artisti provenienti in genere dagli ex territori coloniali in Africa, Asia e America Latina. Il risultato fu la forzata convivenza negli scaffali dei negozi di dischi fra linguaggi agli antipodi non solo geograficamente: l’afrobeat di Fela Kuti, la salsa di Ray Barretto, il folklore celtico di Alan Stivell, il qawwali del pakistano Nusrat Fateh Ali Khan, il Mistero delle Voci Bulgare, il raï dell’algerino Khaled, il fado di Amália Rodrigues e il gamelan indonesiano, fra i tanti. Una categoria mercantile, insomma. L’espressione non era nuova, in verità, e aveva estrazione accademica: a coniarla negli anni Sessanta era stato l’etnomusicologo Robert E. Brown (allievo del precursore Mantle Hood, nel decennio precedente promotore di un seminario di etnomusicologia all’UCLA, in California) per dar nome al corso di dottorato che teneva presso la Wesleyan University del Connecticut: “Mi sembrò opportuno creare una dicitura adatta a rappresentarne le caratteristiche”, spiegava l’interessato. La locuzione cominciò a diffondersi: nel 1973 a San Francisco l’organizzazione non-profit American Society for Eastern Arts ampliò il proprio programma di formazione e concerti rinominandosi Center for World Music, mentre nel 1980 il Dipartimento Musicale della Kent State University istituì un centro studi della world music.
Il 29 giugno 1987, nella saletta di un pub nel nord di Londra, si svolse un incontro che aveva all’ordine del giorno la promozione di “forme differenti di musica non ancora classificate secondo i codici occidentali”.
Nei consumi musicali su larga scala una prima infiltrazione di sonorità “non occidentali” si era registrata durante gli anni Trenta, quando negli Stati Uniti divennero popolari ritmi provenienti dall’America Latina, destinati a essere incorporati successivamente nei codici del jazz – la rumba in particolare – da Duke Ellington (Caravan, 1936) e Dizzy Gillespie (A Night in Tunisia, 1942). Dall’inizio del secondo dopoguerra cominciò a insinuarsi poi nella programmazione delle sale da ballo il mambo delle orchestre di Perez Prado e Tito Puente, mentre Banana Boat Song di Harry Belafonte segnò nel 1956 il trionfo del calypso e al principio del decennio seguente il grande pubblico entrò in contatto con la bossa nova attraverso “The Girl from Ipanema”, scritta da Antônio Carlos Jobim con Vinicius de Moraes e resa celebre a 45 giri dalla versione anglofona realizzata da Stan Getz con i coniugi Gilberto, Astrud e João, tanto da divenire nel tempo la canzone con il maggior numero di reinterpretazioni in assoluto dopo “Yesterday” dei Beatles. Frattanto nel 1961 il gruppo doo-wop The Tokens aveva portato in vetta all’hit parade statunitense “The Lion Sleeps Tonight”, pezzo derivato dall’originale sudafricano di Solomon Linda Mbube, risalente al 1939, scoperto dieci anni più tardi – e raccomandato all’amico Pete Seeger, che ne avrebbe inciso un adattamento insieme ai Weavers nel 1952 – dall’etnomusicologo Alan Lomax, il quale dal 1963 si mise a capo di un progetto accademico da cui scaturì il metodo tassonomico per mappare e catalogare le musiche tradizionali del mondo detto Cantometrics. Seguirono altri estemporanei successi discografici originati nel medesimo continente: nel 1967 “Pata Pata” di Miriam Makeka e nel 1973 “Soul Makossa”, cocktail a base di funk, jazz e aromi africani shakerato dal camerunense Manu Dibango, un “sempreverde” da discoteca che sarebbe stato campionato da Michael Jackson in “Wanna Be Startin’ Somethin’” (1982) e persino da Jovanotti in “Benvenuti nella giungla” (1992).
Nonostante le “musiche del mondo” continuassero a occupare uno spazio commerciale relativamente esiguo, gestito oltreoceano da etichette discografiche stile boutique quali Elektra, Nonesuch e Folkways, riuscivano a stimolare curiosità e interesse fra le star del rock. I Beatles, per esempio, erano notoriamente affascinati dall’India, in particolare George Harrison, che aveva preso lezioni di sitar – riversandone gli insegnamenti nel 1965 in Norwegian Wood – dal maestro Ravi Shankar, che nel 1967 sarebbe apparso sul palco del festival di Monterey, nel cui cast figurava anche il trombettista sudafricano Hugh Masekela, per replicare poi l’impresa nel 1969 a Woodstock. Sul fronte dei Rolling Stones, invece, lo sventurato Brian Jones trascorse l’ultima estate della sua breve vita sulle montagne del Rif in Marocco, ospite dell’amico artista Brion Gysin, e assistette ai rituali in onore di Pan, registrandone le parti musicali (impresse su vinile con il titolo Brian Jones Presents the Pipes of Pan at Joujouka nel 1971, due anni dopo la sua morte). Da quell’esperienza erano stati stregati già i guru della Controcultura che via via avevano raggiunto a Tangeri lo scrittore Paul Bowles, che vi si era stabilito nel 1947: Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso e – primo della serie – William Burroughs, che avrebbe immortalato quella bohème da espatriati nell’Interzona de Il pasto nudo, oltre a definire i Maestri Musicisti di Joujouka “banda rock’n’roll di quattromila anni”. In seguito nitide inflessioni arabe si sarebbero percepite in Kashmir dei Led Zeppelin, brano datato 1975 come The Jungle Line di Joni Mitchell, dove si ascolta un campionamento ante litteram di tamburi del Burundi. Nello stesso anno conquistò una certa notorietà il flautista romeno Gheorge Zamfir, grazie all’utilizzo nella colonna sonora di Picnic a Hanging Rock – film del regista australiano Peter Weir – di un paio di sue composizioni incluse originariamente nella trilogia Flûte de Pan et Orgue edita dall’etichetta del discografico svizzero Marcel Cellier, che in contemporanea pubblicò Les Mystère des Voix Bulgares, raccolta di canti del coro femminile dell’ente radiotelevisivo di stato.
Ma del 1975 si ricorda soprattutto l’epifania di Bob Marley, capace di esportare il reggae giamaicano ovunque nel pianeta e perciò destinato ad affermarsi come prima star globale non euroamericana. A simboleggiarne l’ascesa, in considerazione dell’indole panafricanista implicita nel rastafarianesimo da lui praticato, fu l’esibizione che precedette di un anno la sua prematura scomparsa: il 18 aprile 1980 suonò e cantò nello stadio Rufaru di Harare per la cerimonia d’indipendenza che trasformò la Rhodesia in Zimbabwe, uno degli ultimi paesi del continente a compiere il processo di decolonizzazione. Ad aprirgli la strada verso la fama era stato però un “viso pallido”: nel 1974 Eric Clapton aveva rivisitato e portato in classifica una sua canzone, “I Shot the Sheriff”, cosicché nel giro di qualche mese Marley divenne personaggio da copertina per il magazine statunitense Rolling Stone e il settimanale britannico Melody Maker, all’epoca “bibbie” del rock. Un aneddoto che evidenzia la necessità di un mediatore qualificato per legittimare le musiche indigene presso il pubblico occidentale. Esemplare è in quel senso la figura di Peter Gabriel: cinque anni dopo aver lasciato i Genesis, deviando dal cammino artistico percorso fino ad allora, nel 1980 – in concomitanza con il terzo long playing a suo nome, nel quale campeggiava il brano scritto in memoria dell’attivista anti apartheid Steve Biko, morto in un carcere sudafricano nel 1977 – fu tra i promotori del “World Of Music Arts and Dance”, brevemente “WOMAD”, festival specializzato in suoni dell’“altro” mondo. Nel 1989 avrebbe fondato poi l’etichetta discografica Real World, omonima allo studio di registrazione insediato a Bath nel 1987, nel tempo editrice di più di trecento titoli fra cui spiccano gli album di Nusrat Fateh Ali Khan, interprete della secolare tradizione di canto devozionale del misticismo sufi, e un lavoro dei sardi Tenores di Bitti, S’amore ’e mama. Oltre a ciò, Gabriel coltivava la partnership con Youssou N’Dour, “il leone di Dakar”, ambasciatore musicale del Senegal: nel 1986 suo ospite in So per In Your Eyes, nel 1988 insieme a lui sul palco dell’happening itinerante di Amnesty International “Human Rights Now!” e l’anno seguente padrone di casa per il duetto in Skakin’ the Tree, dal suo celebre disco da solista The Lion.
Il vero punto di svolta, che spinse i “congiurati” a darsi convegno all’Empress of Russia, fu tuttavia il successo di Graceland: album pubblicato nel 1986 da Paul Simon. Il cantautore newyorkese aveva mostrato già in precedenza un’inclinazione per le ambientazioni esotiche, realizzando nel 1970 con Art Garfunkel El Condor Pasa, canzone ispirata al folk andino, e recandosi nel 1972 a Kingston allo scopo di registrare con strumentisti reggae del posto Mother and Child Reunion. Folgorato nel 1985 dall’ascolto di The Indestructible Beat of Soweto, compilation dedicata alle sonorità dell’etnia Zulu, dai ritmi della mbaqanga al canto corale isicathamiya, andò in Sudafrica per creare musica insieme al gruppo vocale Ladysmith Black Mambazo, violando – con conseguente strascico di polemiche – l’embargo anti apartheid. Risultato: Graceland divenne il maggiore best seller della sua carriera da solista, arrivando a smerciare più di 14 milioni di copie. La strada era tracciata, dunque: già nel 1982, dopo la morte di Marley, la major Island aveva indicato come possibile erede il nigeriano King Sunny Adé, alfiere della juju music, anche se la carta vincente era in realtà l’afrobeat del connazionale Fela Kuti, del quale un’altra etichetta mainstream, l’Arista, aveva fatto uscire nel 1981 Black President. Tra gli africani, però, a fare il botto fu il guineano Mory Kanté, il cui brano di “crossover” fra ascendenze indigene e modernità “occidentale” Yé Ké Yé Ké spopolò in hit parade nel 1988, divenendo il primo singolo di un artista continentale proiettato oltre la soglia del milione di pezzi venduti. Intanto – dicevamo – era nata la world music.
L’interesse dell’establishment culturale euroamericano verso quei linguaggi “esotici” poteva essere interpretato sia come divulgazione di tradizioni altrimenti destinate all’oblio sia come manifestazione di una sorta di neocolonialismo.
Il fenomeno esplose durante il decennio seguente: dal maggio 1990 “Billboard” cominciò a pubblicare la specifica classifica dei dischi più venduti, affiancandola a quella riservata alla New Age, e nel 1994 si svolse la prima edizione della “World Music Expo”, brevemente “WOMEX”, fiera itinerante in Europa che dal 1999 avrebbe istituito i relativi Awards. A certificare il boom – sempre nel 1994 – fu la monumentale “Rough Guide” a tema, un volume di settecento pagine dove il soggetto viene definito per sottrazione: “Abbiamo ignorato la musica classica occidentale e il rock, il soul, il rap, il jazz e il country angloamericani, dedicandoci al resto”. In Italia emblema della tendenza in atto sarebbe diventata la “Notte della taranta”, inaugurata nel 1998 in Salento prendendo spunto dal rituale arcaico della “pizzica”. Frattanto stava diventando un caso il Buena Vista Social Club degli arzilli veterani Compay Segundo, Ibrahim Ferrer e Omara Portuondo, che da decenni suonavano e cantavano a Cuba, prevalentemente son e rumba, senza che al mondo nessuno ne sapesse alcunché: tanto per cambiare servirono occhi e orecchi forestieri per introdurli alle grandi platee, nella fattispecie quelli del regista tedesco Wim Wenders e del musicista californiano Ry Cooder, quest’ultimo già responsabile della “scoperta” del chitarrista del Mali Ali Farka Toure per mezzo dell’album a quattro mani Talking Timbuktu.
L’interesse di rappresentanti accreditati dell’establishment culturale euroamericano verso quei linguaggi “esotici” poteva essere interpretato sia in termini di generosa opera di divulgazione di tradizioni condannate altrimenti all’oblio sia come manifestazione di una sorta di benevolo neocolonialismo: moventi contrastanti divisi da un confine labile. Da un lato, divenendo per un certo periodo moda, la world music aveva posto sotto i riflettori dei media prodotti destinati abitualmente a una ristretta cerchia di appassionati, esponendoli tuttavia a un approccio “consumista” da parte di turisti del suono stuzzicati dal contatto con il “buon selvaggio”: metafora di un’autenticità – sovente attestata da autorevoli etnomusicologi nelle note di copertina dei dischi – opposta agli artifici del pop di largo consumo. D’altronde, va considerato il disincantato punto di vista espresso da Simon Frith nel saggio citato in apertura: “I musicisti del Terzo Mondo vengono trattati da grezza materia prima utilizzata per produrre merci per l’Occidente, mentre i musicisti del Primo Mondo iniettano nuova vita nella loro musica lavorando con artisti quali Ladysmith Black Mambazo, Youssou N’Dour e Celia Cruz”. Il soggetto è perciò intrinsecamente contraddittorio, poiché in definitiva – persino a dispetto delle intenzioni dei personaggi coinvolti – “riafferma l’egemonia della cultura pop occidentale”: parola di David Byrne. Reduce dall’avventura dei Talking Heads, nella cui carriera l’entità dell’influsso africano era cresciuta nel tempo, da Fear of Music in avanti, venne folgorato sulla via di Bahia da Rei Momo, figura allegorica del Carnevale alla quale intestò il suo album da solista del 1989. L’anno precedente aveva fondato Luaka Bop, etichetta che esordì dando voce ai “tropicalisti” nella collana Brasil Classics (Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Jorge Ben comparivano nel primo volume Beleza Tropical, laddove nei successivi sarebbe venuto il turno di Tom Zé e Os Mutantes), proseguendo poi verso l’India della star di Bollywood Vijaya Anand, l’isola cubana del poeta e cantautore Silvio Rodriguez, il Perù di Susana Baca e il Messico di Los De Abajo.
Fece perciò scalpore l’editoriale da lui firmato nell’ottobre del 1999 sul New York Times e intitolato lapidariamente “Detesto la World Music”, dove affermava tra l’altro: “L’uso dell’espressione world music è un modo per ridurre all’irrilevanza certi artisti e le loro musiche. Una maniera per relegare quelle ‘cose’ in una dimensione esotica e dunque ‘carina’, stravagante ma inoffensiva”. Si era creato insomma un corto circuito, dovuto essenzialmente al vizio congenito: la fabbricazione a tavolino di una categoria merceologica travestita da evento culturale. “All’inizio del ventunesimo secolo è diventato impossibile fornire una definizione della world music senza cadere in una sorta di circolo vizioso concettuale”, osserva a riguardo Philip V. Bohlman nella prefazione alla sua monografia tematica del 2002 (tradotta in Italia nel 2006 da Edt), e tale consapevolezza si è andata diffondendo. Paradigmatico è il caso del “WOMAD”, ribattezzato dallo scorso anno “The World’s Festival” per smarcarsi dall’enunciazione originaria. “Capiamo che per molti artisti l’espressione ‘world music’ è ghettizzante. La rispettiamo perché fa parte della nostra storia, ma abbiamo la necessità di evolvere, perché la musica si è evoluta”, ha dichiarato il direttore artistico della manifestazione Chris Smith. In realtà nell’attuale scenario globalizzato, soprattutto dopo l’accelerazione impressa alla circolazione dei contenuti dall’avvento di internet, la presunta purezza “a chilometro zero” è un miraggio velleitario. O meglio, ciò che pretende di essere “non corrotto” finisce inevitabilmente per diventare agente di conservazione.
La “musica del mondo” esiste eccome, ma è tutt’altra cosa dal reparto “world music” di un negozio di dischi ed elude miti e cliché consolidati. Il rap coniugato con esuberante soggettività giovanile nelle varie periferie del mondo, ad esempio. Oppure la diffusione del suono elettronico nel “Global South” descritto da DJ/rupture nel saggio Remixing – Viaggi nella musica del XXI secolo. O ancora, il rock inteso alla maniera tuareg dai maliani Tinariwen. A questo proposito, il sociologo israeliano Motti Regev scrive in Pop-Rock Music: Aesthetic Cosmopolitanism in Late Modernity: “La presenza della musica rock nelle culture indigene e la sua influenza sulle musiche del posto vengono viste raramente come imperialismo culturale. Al contrario, il rock è percepito come un mezzo importante per rafforzare il senso contemporaneo dell’identità e dell’autonomia locali”, poiché – aggiungiamo noi – esprime tanto l’idea di appartenenza a una comunità globale quanto l’impulso all’innovazione su scala regionale. “I musicisti mescolano insieme elementi musicali di qualsiasi provenienza, aggiungendovi le possibilità sonore messe a disposizione dalle nuove tecnologie”, sostiene Hyunju Park in Globalization, Local Identity and World Music, parlando di “ibridazione”. È accaduto dunque l’opposto di ciò che gli esegeti della world music proclamavano una trentina di anni fa: le “musiche del mondo” non prosperano in antagonismo agli archetipi del “suono occidentale”, bensì li assimilano e se ne servono per immaginare il futuro.