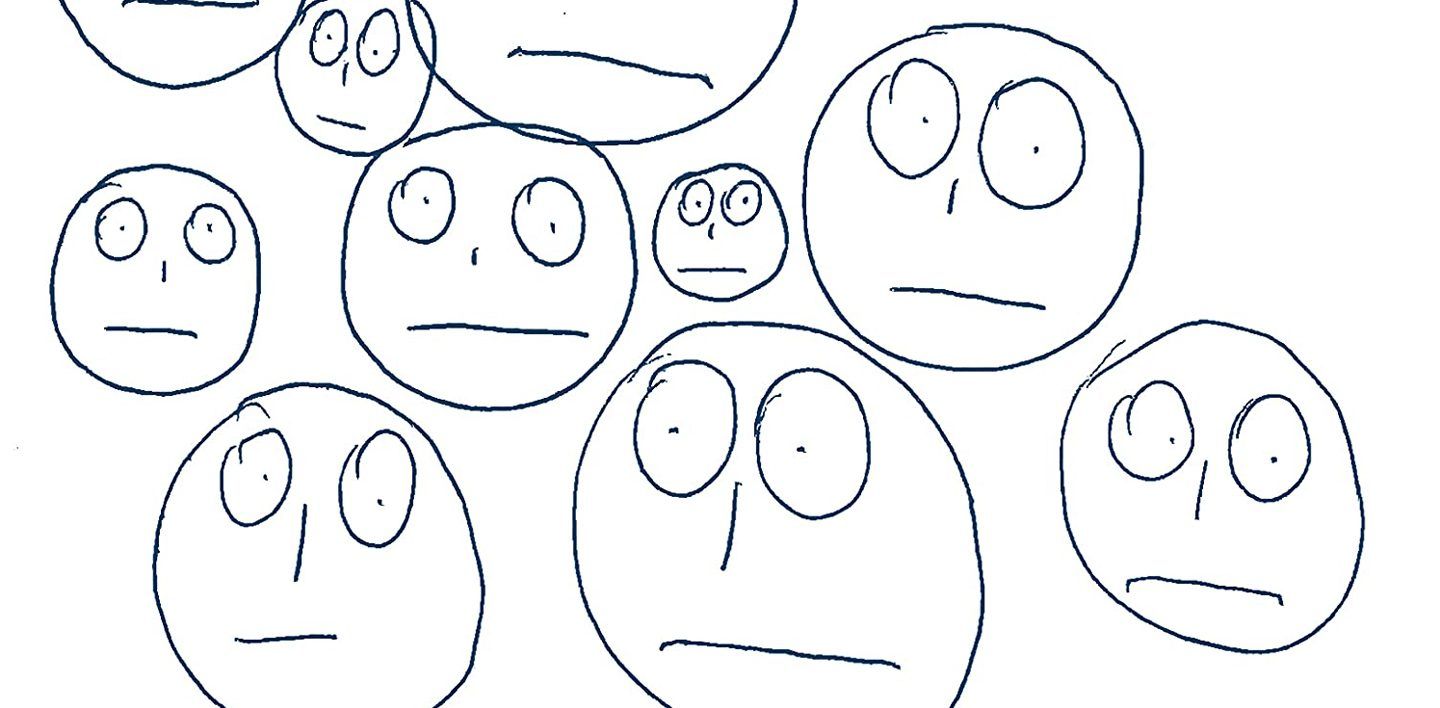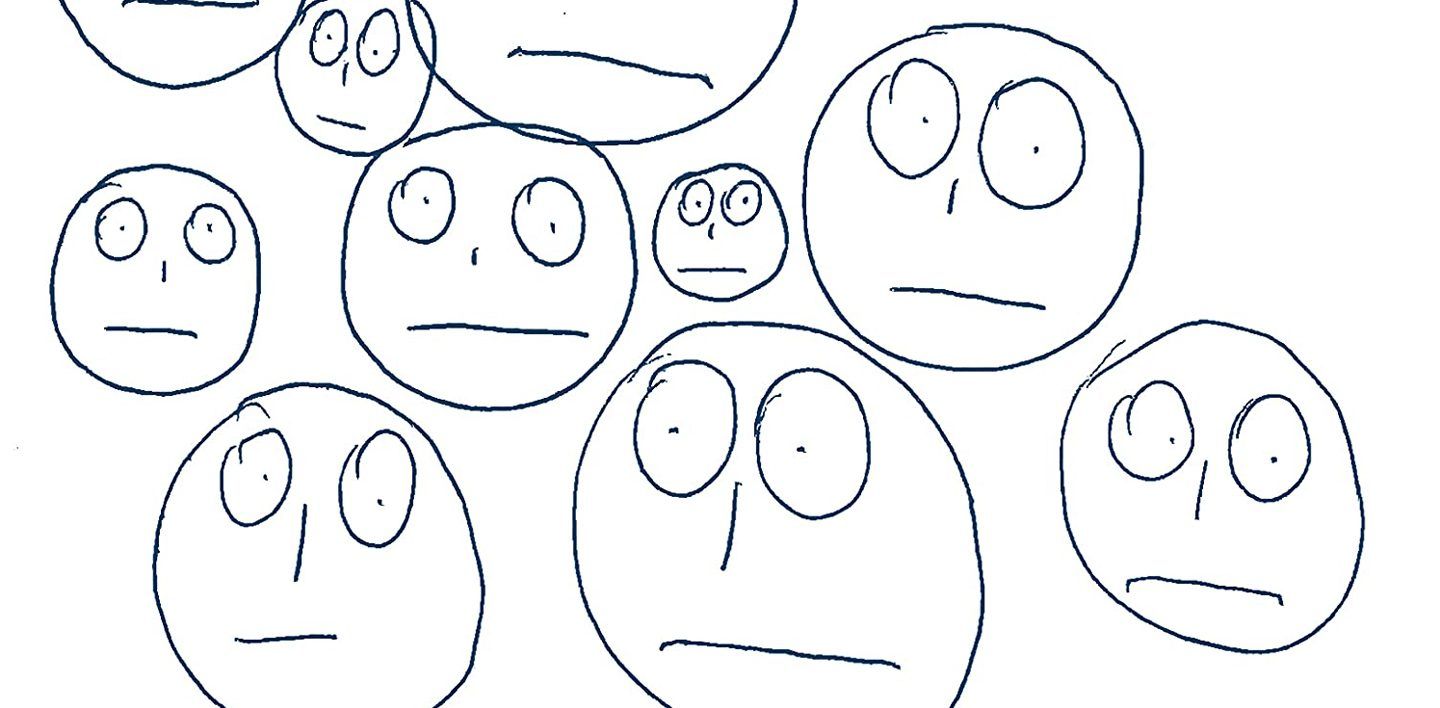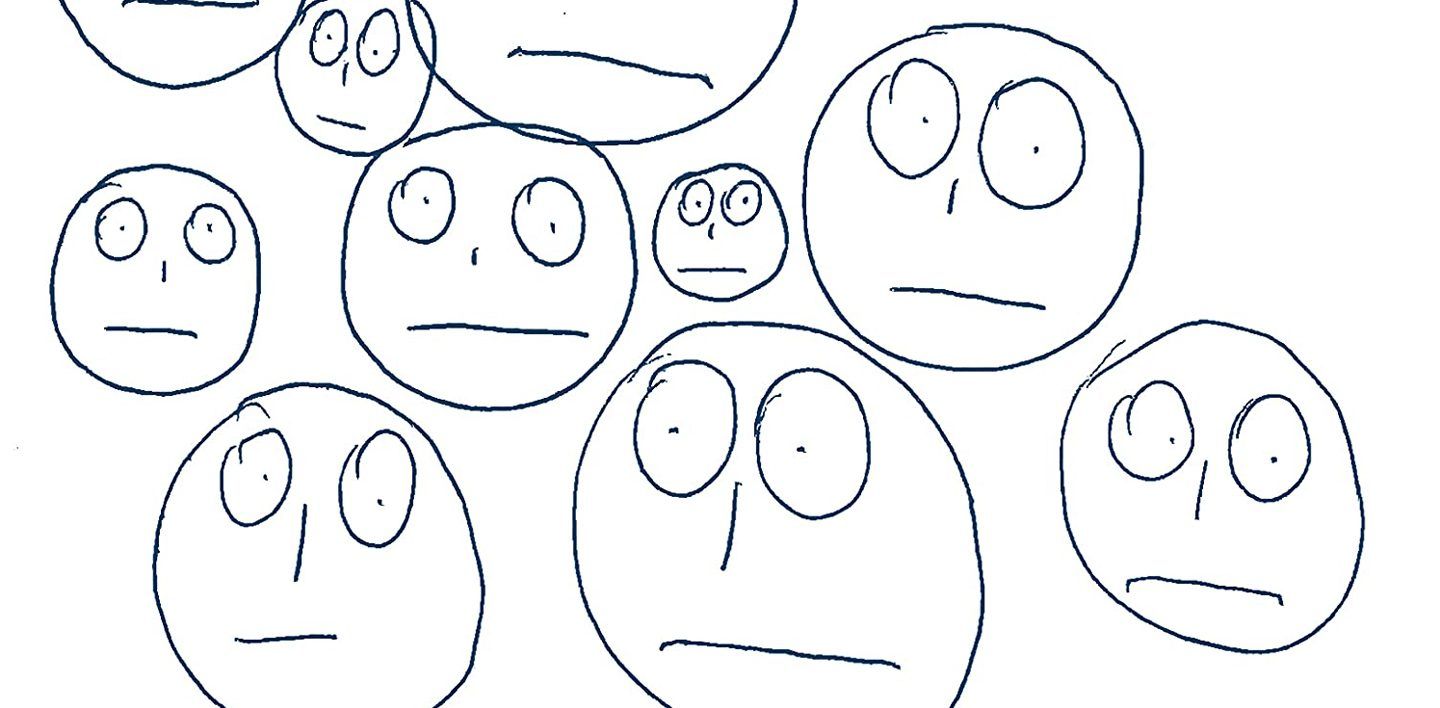Q
uanto felice e costruttivo ozio ci viene sottratto”, scrive Pietro Galeotti in La riunione, “dall’inspiegabile necessità di essere sempre presenti, connessi, informati, brillanti e vigili?”. Ne La riunione Pietro Galeotti ha messo in fila ciò che aveva già abbozzato su carta o fermato nella memoria durante quasi quarant’anni di vita professionale. La riunione è una storia, triturata in frammenti e aforismi, di quella categoria del lavoro culturale che è il lavoro televisivo. Galeotti è un autore tv di lunghissima esperienza. Ha iniziato a scrivere per la tv ad appena diciannove anni, nel 1983, accanto a Fabio Fazio. La vita dell’autore tv descritta da Galeotti è accompagnata dal sapore non piacevole della rinuncia. Le buone idee e le ambizioni vengono puntualmente accantonate. Vince il compromesso. La cialtroneria è sempre in agguato. Galeotti lo sa, è implicato nel rito della riunione autoriale, è la sua vita. Vive nella riunione, però durante la riunione, mentre i colleghi commentano la curva degli ascolti, per un istante chiude gli occhi e la mente ritorna alla traversa colpita a nove anni in rovesciata. Nel mondo dell’autorialità televisiva si parla una lingua speciale. Un anno, chissà come e perché, in riunione va di moda intercalare con “e quant’altro”, annota sul taccuino Galeotti, mentre chi scrive questo articolo ha in mente l’uso abituale dell’aggettivo “acceso”, per dire di un determinato ospite che negli ultimi tempi “è ovunque”, intervistato sui giornali e alla tv. Quindi l’ospite è “acceso” e perciò è “potabile” per un invito, un’“ospitata”. Se invece l’ospite non è “acceso”, allora è probabile che sia “bollito”; se è “pop” è meglio, se è “alto” significa che parla forbito e ha un contegno cattedratico, intellettuale, il che compromette la possibilità di un invito, e se altre volte l’ospite non è adatto per la prima serata è perché fa troppo “pomeriggio”, nel senso che come volto è facilmente associato dagli spettatori ai rotocalchi in onda tra le 14 e le 18, mentre un’idea non è semplicemente approvata, ma è “timbrata” o “battezzata”, così come il budget è da “sbudgettare” e il girato da “spillolare”, e se due ospiti in un certo ordine sono prevedibili, allora servirà un terzo che “spariglia”, magari da“brieffare” preventivamente al telefono. E così via. “C’è stato un tempo”, afferma Galeotti, “in cui chi scriveva per mestiere usava con cura la lingua italiana. Pare addirittura che alcuni sapessero che si usa “domando” se voglio sapere e “chiedo” se voglio avere”.
La riunione è un testo fatto da un mare di appunti, aneddoti di tre righe o mezza pagina, frammenti umoristici e aforismi. Dalle giornate trascorse in riunione, Galeotti ricava considerazioni che al netto dell’ironia ricordano le memorie di un diplomatico: “La pazienza, l’arte del rammendo necessaria nelle quotidiane discussioni e nelle rotture che continuamente in questa stanza si producono, sono viste come qualità casalinghe, da tinello. Per me, invece, sono gli indispensabili ferri del mestiere”. Insomma, la tv è mediazione. Riflettendo sulla quantità e diversità di professionalità e reparti al lavoro e sul conglomerato di rapporti umani, politici, di relazioni tra aziende, di questioni burocratiche e fiscali, e poi sulla logistica e sulle tecnologie informatiche ed elettroniche impiegate per il lavoro sulle immagini, anche nel caso del più modesto programma del mattino siamo di fronte a una concentrazione impressionante di complessità. Forse più che in altri ambiti, lavorare in tv significa fare esperienza del molteplice, del groviglio e dell’esistenza come campo di lotta tra contrari.
La riunione è un testo fatto da un mare di appunti, aneddoti di tre righe o mezza pagina, frammenti umoristici e aforismi.
Se il mestiere dell’autore sconta continui negoziati al ribasso, non bisogna dimenticare che ogni tanto consente di assistere a epifanie. Pietro Galeotti ha lavorato a ben sette edizioni del Festival di Sanremo. Durante l’edizione del 2000, il mezzo miracolo si manifesta nella reazione di Bono Vox di fronte a un imprevisto in scaletta: l’apparizione di Mario Merola, il re della sceneggiata. Nell’intervista che segue, affiorano altri stupori ed epifanie, insieme a un legame indissolubile con il proprio lavoro.
Hai iniziato prestissimo a fare tv. Scavando nel tuo cv si trovano programmi dimenticati, vere e proprie cittadelle di un’Atlantide televisiva. Che cos’era Sponsor City?
Questo è un ricordo abbastanza clamoroso, perché nella carriera di un autore è un po’ come per un filatelico imbattersi nel leggendario Gronchi rosa. Sponsor city, titolo ineguagliabile, era lo show che nelle intenzioni della Rete 4 non ancora berlusconiana, avrebbe dovuto segnare nel 1984 il sorpasso in ascolti e dunque in raccolta pubblicitaria nei confronti della rivale Canale 5. La guerra si combatteva sul terreno delle soap opera e delle serie, che allora si chiamavano telefilm, ma prevalere sul terreno del varietà avrebbe significato sferrare un colpo mortale al nemico. Così furono coinvolti comici popolarissimi, come Diego Abatantuono, Bombolo ed Enzo Cannavale, dive sexy come Lory del Santo, caratteristi storici come Gianni Agus, giovani promettenti come Fabio Fazio e svariati altri protagonisti dello spettacolo italiano, messi in un contenitore che più o meno avrebbe dovuto parodiare il mondo della pubblicità. Lo sforzo economico fu immane. Solo per girare lo spot, Milano fu invasa da comparse, che poi avrebbero dovuto scendere da elicotteri sul tetto dello studio). Se non sbaglio il programma chiuse prima della fine prevista. Io ricordo confusamente alcune memorabili sfuriate di Gianni Agus (straordinario attore teatrale prestato alla tv, noto per aver interpretato l’aguzzino di Paolo Villaggio nei panni di Fracchia Ndr che lamentava il dilettantismo dei partner, esprimendo il proprio disappunto con urla che si percepivano dal parcheggio antistante gli studi. Ricordo più nitidamente -avevo 20 anni- le prove costume di Lory del Santo, peraltro molto simpatica. E ricordo una riunione plenaria per la lettura dei copioni, alla quale partecipò anche Leo Chiosso, il paroliere di Fred Buscaglione negli anni 50’ e 60’, durante la quale Bombolo non riusciva a capire il senso di una battuta, “orate fratres, che lui si ostinava a pronunciare “a rate fratres”, tra la nostra ilarità e il disgusto di Agus.
E l’Orecchiocchio?
L’Orecchiocchio fu uno storico programma della terza rete. Dico storico perché RAI Tre, anzi la Terza Rete, nacque come rete culturale affidata al Professor Giuseppe Rossini, primo mitico Direttore. Uno storico di area spadoliniana, dai modi, e credo anche i gusti, risorgimentali. In quel contesto si decise di varare nel pomeriggio un programma di musica e video, un pò sulle tracce di MTV, ma con intonazione romana, che alla sua terza edizione venne affidato a Fabio Fazio, di cui ormai ero autore di riferimento. La leggenda, di cui non ci sono grandi prove, è che il nome Orecchiocchio sia stato copiato da un negozio di dischi e video di Roma Nord. Di certo fu una palestra straordinaria per me e per Fabio: un programma quotidiano nel quale potevamo fare quello che ci pareva e che decidemmo di trasformare in un mischione di musica e comicità. Un giorno venne nello studio P2 di Via Asiago a Roma, credo ora dismesso, Dario Fo, che in quei giorni recitava al teatro tenda il suo Mistero buffo. Fu una cosa incredibile. Negli anni successivi, siamo nell’85/86, grazie a un dirigente si decise di tenere il programma, ma di cambiare il titolo, che diventò Jeans, in omaggio all’idea dei giovani che aveva il Professor Rossini. Fu a Jeans che ebbi l’idea di affidare a Moana Pozzi una rubrica di consigli alle casalinghe.
Hai iniziato a fare tv a diciannove anni. E il militare?
Il militare lo rinviai con il pretesto degli studi universitari, che allungai a dismisura, fino a quando la cartolina precetto mi raggiunse nel maggio del 1990. Chiusi l’ultima puntata di Prove tecniche di trasmissione, con Piero Chiambretti, Sandro Paternostro, Helenio Herrera -uomo simpaticissimo e completamente pazzo- e Nanni Loy, dopodichè partii per Cuneo.
Il militare a Cuneo, come nella battuta nel famoso sketch di Totò.
Nel maggio del 1991, appena congedato, Bruno Voglino mi convocò a Roma per iniziare a preparare La piscina, uno show con la diva del momento, Alba Parietti, che il direttore di Rai Tre Angelo Guglielmi voleva a tutti i costi, con l’evidente obiettivo di scatenare una gazzarra mediatica. Obiettivo centrato. Credo che la rassegna stampa di La piscina sia tra le più voluminose a memoria d’uomo. E immagino che a scorrerla non si troverebbe una riga non dico di complimenti, ma neppure di pietà.
Com’erano le redazioni tv prima che arrivassero i computer e i telefonini?
La prima redazione in cui ho lavorato, nel 1983/84, quella di Loretta Goggi in quiz, era in Fiera a Milano. La Fiera aveva studi piuttosto moderni, da cui si trasmetteva anche Fantastico, lo show del sabato sera. Le stanze erano “milanesi”, quindi meno delabré di quelle romane, ma ovviamente non c’erano i computer e si lavorava sulle macchine da scrivere elettriche. Credo di ricordare anche l’uso della carta carbone per avere subito due copie dei testi.
E come si lavorava un tempo, senza computer e telefonini?
Si lavorava intensamente, senza distrazioni che non fossero l’uscita per andare al bar o le chiacchiere tra colleghi, cosa che non poteva riguardarmi più di tanto, perché io ero totalmente esordiente e faticavo a pronunciare la minima parola. Ricordo di aver assistito a discussioni molto divertenti tra autori, a proposito di un articolo letto su Rinascita, la rivista del PCI che chissà perché circolava in redazione. Io personalmente in quel programma ero l’autore dei testi di Fabio Fazio, che scrivevamo a Savona, talvolta a casa dei suoi genitori, altre volte a casa dei miei. Il testo veniva redatto sulla mia macchina da scrivere e quindi portato a mano agli autori del programma, tra cui Luigi Albertelli, straordinario autore di testi per canzoni, comprese la sigla di Furia cavallo del West e Jeeg Robot. Gli autori valutavano la qualità, quindi lo approvavano o chiedevano modifiche. In quel caso le modifiche erano fatte a penna sul testo originale.
Anche La riunione non è nato su un foglio Word…
La riunione è un estratto delle noterelle che da anni scrivo prevalentemente di sera, sui taccuini che ho sempre con me, e dove riporto fatterelli, cose divertenti, incontri, ovviamente anche piccole o grandi amarezze del lavoro. Per il libro ho fatto una selezione di alcune cose che mi divertivano o mi sembrava potessero interessare, a cui ho aggiunto qualche ricordo estemporaneo e ovviamente molte cose di pura invenzione.
La serie tv Boris dedicò un paio di episodi al racconto grottesco di come si fa la tv a Milano. Tu che differenze hai notato tra le due città?
Per semplificare potrei dire che Milano è più contemporanea e Roma più tradizionale. Naturalmente è una sintesi, che non riconosce i meriti di entrambe le sedi: peraltro sia a Roma che a Milano ho sempre incrociato dirigenti e artisti provenienti da altre città, così da non poter identificare se non in determinate zone del palinsesto la romanità o la milanesità del prodotto. Di sicuro il bar di Viale Mazzini non è paragonabile per frequentazioni e riti a quello di Corso Sempione. Ci sono poi figure totalmente radicate in un territorio, penso a Romano Frassa a Milano, nel suo ufficio con i mobili disegnati da Gio Ponti, o a Mario Maffucci con i suoi appuntamenti sotto il cavallo della sede di viale Mazzini.
Nel tuo libro ricorrono qua e là aneddoti sui capricci delle star, a volte davvero parossistici, come il tale che in camerino pretendeva le smarties divise per colore…
La questione delle smarties è puramente legale: le rockstar, e in genere gli ospiti internazionali e oggi qualche big nostrano, usano questo escamotage come via di fuga, nel caso qualche cosa dello show non sia di loro gradimento. Poiché è impossibile ottemperare a tutte le richieste che compaiono come non trattabili nei loro contratti, gli artisti possono richiamarsi a questa o a quella inottemperanza contrattuale per non esibirsi, percependo comunque il cachet previsto.
“Questo lavoro”, scrivi, “non è più competenza di artigiani, più o meno sapienti, più o meno colti”. Il guaio, mi viene da aggiungere, è che neppure internet, cioè il competitor o l’alleato della tv a seconda dei punti di vista, sembra un luogo fatto da artigiani, più o meno sapienti…
Il tema della competenza, a mio avviso centrale, è stato smantellato nel corso degli anni con una serie di rivendicazioni anche politiche -l’uno vale uno- che hanno lasciato il segno un pò dappertutto. La figura dell’autore come antenna del contemporaneo, quindi, non è più richiesta, soppiantata da figure tecniche: chi sa montare, chi istruisce i protagonisti, chi fa le scalette… in modo da smembrare il lavoro, parcellizzarlo, non farlo interagire, talvolta tenendo all’oscuro uno del lavoro dell’altro. Chi è abituato a una pratica della scrittura come risultato di lunghe sedute collettive, oggi è un pò come il dinosauro che percepisce, lontano ma ugualmente minaccioso, il rumore del meteorite in avvicinamento.
Quest’estate la Triennale di Milano ha dedicato una serata fantastica al ricordo della Rai Tre di Angelo Guglielmi. C’eri anche tu seduto da qualche parte. Sono rimasto stupito dalla performance sul palco di Bruno Voglino. Strepitoso, per tante ragioni. Sono andato a rileggermi la sua storia e ho scoperto che il 4 gennaio 2022 compirà novant’anni. Tu come lo hai conosciuto? Che rapporto c’è tra di voi?
Bruno Voglino, figura centrale del varietà italiano dagli anni ‘70 a oggi, è stato il grimaldello attraverso il quale Fabio Fazio, e io con lui, siamo approdati giovanissimi in Rai. Voglino è un leggendario talent scout. Nel 1982, insieme a un altro monumento dello spettacolo italiano, Guido Sacerdote, che in coppia con Antonello Falqui scrisse programmi come Studio 1, Senza rete e Canzonissima, aveva battuto tutta l’Italia alla caccia di giovani, ancora chiamati talenti, anziché talent. Nella sua rete di rabdomante del varietà finirono Piero Chiambretti, Giorgio Faletti e un appena maggiorenne Fabio Fazio. Da lì, da quella visione, partì tutto. E ti garantisco che ci voleva il fiuto di Voglino per capire che dietro certe forme ingenue di spettacolo si nascondevano talenti di una certa grandezza. Bruno è stato per me il dirigente dei programmi della mia età dell’oro. Diritto di replica, Prove tecniche di trasmissione, Va pensiero, La Piscina e poi la nostra esplosione professionale con Quelli che il calcio, che per otto stagioni fu un laboratorio di follia e capacità tecnica per molti versi irripetibile. Ma Bruno Voglino vuol dire La tv delle ragazze, Avanzi, Il portalettere, Complimenti per la trasmissione, Il laureato e Svalutascion, cioè Celentano su Rai Tre!
Persona coltissima, enormemente spiritoso, con una voce torinese, quasi al limite della parodia del piemontese alla Macario, ma con giudizi sempre lucidissimi e utili: la sua lezione è stata immensa e la sua eredità decisamente non raccolta. Ora è in pensione, ma resta più avanti di moltissimi colleghi.
Con che tipo di tv sei cresciuto?
Con la tv dei ragazzi, che peraltro non amavo, almeno fino all’arrivo dei primi telefilm, tipo Tre nipoti e un maggiordomo, e poi con i varietà che invece mi piacevano tantissimo. Ricordo il disgusto di mia madre davanti a certe scenette di Paolo Villaggio in Quelli della domenica, un programma del pomeriggio domenicale, e quanto invece a me quello strano personaggio, che parlava tipo tedesco e picchiava delle anziane signore, mi faceva ridere moltissimo. L’epifania televisiva però fu per me L’altra domenica, contenitore alternativo a Domenica In, realizzato da Renzo Arbore e con un cast inaudito: Roberto Benigni, Isabella Rossellini, Andy Luotto, le sorelle Bandiera, Otto e Barnelli, musica dal vivo e servizi da New York e da Londra, che per me erano appena più vicini di Saturno. Ascoltavo molta radio: Arbore e Boncompagni ad Alto Gradimento, ma anche Gran Varietà, la domenica mattina, con giganti della rivista italiana, da Paolo Panelli a Bice Valori, da Nino Manfredi ad Aldo Fabrizi. Io lo sentivo principalmente perché Paolo Villaggio ogni domenica leggeva un capitolo di Fantozzi, ma poi la bellezza del resto mi inchiodava.
Leggendo il tuo libro, mi sono fatto l’idea che anche l’edicola è stata un luogo importante della tua vita e della tua infanzia…
In edicola andavo tutti i giorni, per le varie uscite di Topolino, di cui compravo una strana edizione anastatica detta Topolino d’oro, con le storie degli anni 30. Costava 500 lire: un trauma per i miei genitori, che tuttavia me lo compravano. Poi Tex e gli albi Bonelli, la Marvel e l’Uomo Ragno, fino all’incontro per me sconvolgente con Alan Ford. Non avevo mai letto un fumetto così anarchico, rivoluzionario, divertente, politico.
Nel libro racconti di un luogo misterioso, cioè un negozio che forse non lo era, di proprietà di Giovanni Gandini, il fondatore della rivista Linus, che tu poi hai diretto tra il 2016 e il 2018. Questo negozio-non-negozio si trovava in via San Fermo, a Milano…
Ho scoperto qualche anno fa che il negozietto di fumetti e rarità editoriali di via San Fermo è stato l’ultimo indirizzo di Giovanni Gandini. Era un posto di cui non saprei definire la natura, dove, giuro, non ho mai visto concludersi uno scambio commerciale, ma dove si potevano leggere degli strani biglietti sul vetro all’ingresso, con una serie di prezzi per i possibili acquirenti. Era un laboratorio? Una galleria? Un negozio? Non l’ho mai capito. Sicuramente, dentro i pochi metri quadrati dello spazio era contenuto un tesoro, con migliaia di pezzi rarissimi del fumetto italiano e internazionale. Un Paradiso.
So che collezioni arte futurista…
Ho collezionato per anni libri futuristi in prima edizione. Una passione nata per caso, dopo aver scoperto che Albissola Marina, paesino in provincia di Savona cui sono affezionatissimo e di cui sono peraltro orgoglioso residente, è stata negli anni Trenta una delle culle del cosiddetto secondo futurismo, ovvero la fase dell’avanguardia in cui, dimenticati gli ardori guerrafondai, si continuava la battaglia contro il passatismo, cercando una sorta di ricostruzione futurista dell’Universo, che riguardava ogni territorio artistico, dal cinema al design, dalla moda alla musica, compresa ovviamente anche la pittura, la scultura e la ceramica. E poiché Albissola era terra di ceramisti, alcuni di loro, con Tullio Mazzotti ribattezzato Tullio d’Albisola in testa, si misero a proporre ceramiche che non assomigliavano più ai vasi ornamentali da salotto borghese, ma erano forme nuove, vertiginose, mai viste, futuriste appunto. Ad Albissola era presente anche Farfa, un poeta futurista, paroliere dall’immaginazione davvero pirotecnica, del cui libro fondamentale, Noi. Miliardario della fantasia, entrai in possesso, ma in realtà fu lui ad impossessarsi di me, insieme alla necessità di collezionare altri libri futuristi e altri e altri, fino a smettere, dopo aver raccolto una collezione che senza falsa modestia definirei molto importante. E che poi ho venduto, con grande dolore.
Mi chiedo pure come tante persone che hanno fatto la storia della tv, come tu, Fabio Fazio, Carlo Freccero, Antonio Ricci e Tatti Sanguineti, veniate tutti da un posto piccolo e distante come la provincia di Savona. C’è una risposta o è un caso?
Carlo Freccero dice sempre che i savonesi sono dei napoletani tristi. Chissà, forse in questa sua definizione c’è la risposta alla tua domanda.
A me mancano moltissimo le riunioni dentro una stanza. Come hai vissuto lo smart working?
Con grande fatica. Essendo profondamente novecentesco, ho bisogno, proprio come carburante creativo, del contatto fisico con i colleghi, con le persone. E continuo a credere, come scrivo nel libro, che qui, nella riunione, una volta era tutta conversazione.