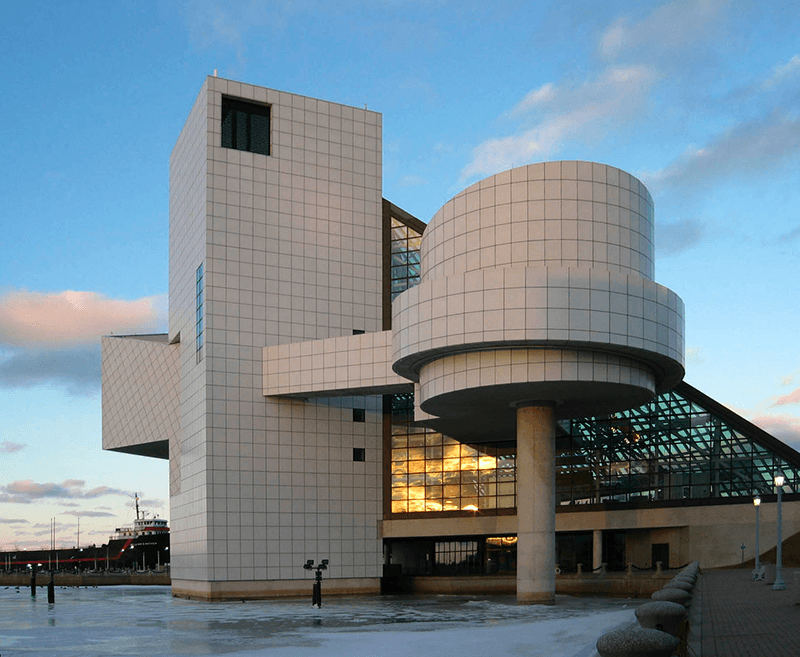N ella seconda metà degli anni Ottanta tre forme pure, dalla carica fortemente simbolica, appaiono nel tessuto urbano di Parigi. Figli della politica dei Grands Projets, i tre grandi edifici sono tra i progetti vincitori di altrettanti ambiziosi concorsi di architettura e di commissioni dirette promosse dal socialista François Mitterrand nel suo secondo mandato da presidente. Una sfera, la Géode, compare nel cuore del parco della Villette, alle estremità nord-est della capitale, permettendo al pubblico di specchiarsi sulla sua superficie. Un arco cubico quasi perfetto diventa la Grande Arche de la Defense, simbolizzando l’entrata monumentale al nuovo quartiere direzionale a ovest della città, allineato e a quattro chilometri dall’Arco di Trionfo. La terza, una Pyramide di vetro, è al centro del cortile di uno degli edifici più significativi di Parigi, il museo del Louvre, e ne incarna il nuovo ingresso monumentale.
Prendendo in prestito un’espressione comune nella musica pop, le prime due opere potrebbero essere considerate come delle one hit wonders, gli unici veri successi dei rispettivi architetti: se la géode è infatti firmata dai non certo celebri Adrien Fainsilber e Gérard Chamayou, la Grande Arche de la Défense è opera dell’architetto danese Johan Otto von Spreckelsen, autore quasi esclusivamente di piccole chiese nel suo paese d’origine. La terza, la piramide del Louvre, è invece l’opera più celebre di un prolifico architetto della seconda metà del Ventesimo secolo, attivo fino a pochi anni fa e scomparso il 16 maggio 2019, I. M. Pei.
Cresciuto a Suzhou, a ovest di Shanghai nel 1917, Ieoh Ming Pei è stato il primo architetto non occidentale a operare su una scala globale. Come avviene ancora oggi per molti figli di famiglie benestanti orientali, l’istruzione universitaria di Pei, figlio di un alto dirigente della Bank of China, passa per il Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) e Harvard, tra le più quotate scuole Ivy League per gli studi di architettura.
Come relatori di tesi Pei sceglie due maestri del movimento moderno, Walter Gropius, fondatore del Bauhaus, che nel 1937 era scappato dalla Germania nazista, e Marcel Breuer, architetto e designer ungherese, suo discepolo e protetto. I due contribuiscono fortemente alla diffusione del Movimento Moderno negli Stati Uniti, quella stessa modernità che una volta atterrata nel nuovo continente piega tutta la sua dirompente carica politico sociale in una versione pragmatica ma spesso banale chiamata ”International Style”.
In questo clima di transizione cresce lo studente Pei, all’interno di scuole che stavano progressivamente abbandonando l’insegnamento tradizionalista Beaux-Arts, all’epoca ancora diffuso negli Stati Uniti, e che avevano aperto le porte agli architetti europei del Movimento Moderno in fuga. Ma se la modernità si cristallizza in America in un linguaggio aziendale, nella sensibilità di Pei quella stessa modernità si confronta con la tradizione architettonica cinese. La sua stessa città d’origine, Suzhou, ebbe un ruolo significativo nello sviluppo della millenaria tradizione cinese dell’arte del paesaggio, con i suoi giardini rinchiusi da mura che riproducevano una natura rigogliosa a piccola scala e che accoglievano una serie di padiglioni isolati collegati fra loro da percorsi tortuosi. Gli elementi naturali e costruiti si intrecciavano per offrire al visitatore una serie di scene in successione, un principio che sarà poi ripreso dalla tradizione dei giardini pittoreschi inglesi del Diciannovesimo secolo.
Con la sua tesi di laurea, un museo a Shanghai articolato da cortili e giardini di taglia diversa, Pei intende dimostrare come sia possibile combinare modernità e tradizione, quella cinese in particolare, in netta contrapposizione con alcune delle voci più intransigenti del movimento moderno, tra le quali si allinea anche quella di Walter Gropius.
Il progetto non si affida a forme o materiali vernacolari, ma è capace di parlare un linguaggio allo stesso tempo moderno e tradizionale solo attraverso una precisa concezione spaziale che articola un rapporto continuo tra spazio interno ed esterno. Nonostante la sfida, sarà lo stesso Gropius a complimentarsi con il giovane Pei per i risultati ottenuti.
Poco dopo la laurea, abbandonate le ricercatezze dell’accademia e interessato alla concretezza della professione, Pei si avventura nel mondo pragmatico dell’architettura corporate entrando a far parte dello studio newyorkese Webb and Knapp. L’architetto naviga tra commissioni di taglie diverse diffuse sul territorio americano, uffici, edifici commerciali e pubblici e ricorre a soluzioni sempre specifiche pur applicando quel linguaggio impersonale che nel tempo costituirà lo sfondo di tante città americane. Autonomo ed efficace, nel giro di qualche anno si costruisce una solida esperienza sul campo e nel 1955 si mette in proprio fondando la I. M. Pei & Associates. Tuttavia, il solido rapporto con i Webb and Knapp, per i quali riveste ancora incarichi gestionali, lo tiene lontano dalla progettazione diretta di edifici.
Per poter sviluppare un proprio pensiero progettuale e realizzare gli edifici che lo renderanno famoso, Pei dovrà attendere ancora qualche anno, una totale indipendenza dallo studio precedente e l’opportunità di un progetto lontano dai contesti urbani, in cui ricominciare a mettere in questione i rapporti tra il costruito e la natura e tra tradizione e modernità che lo avevano interessato negli anni della formazione. Nel 1961 gli viene commissionato il progetto per il National Center for Atmospheric Research (NCAR), ai piedi delle montagne rocciose del Colorado, in un contesto naturale eccezionale. Pei si dedica completamente al progetto con l’obiettivo di costruire un’opera monumentale, un villaggio di volumi puri intersecati fra loro come in una fortezza moderna. Gli elementi primari dell’architettura, come porte e finestre, sono assorbiti in grandi tagli geometrici che fanno perdere il senso della scala umana per dare vita a un complesso che si misura con le montagne vicine. Lo stesso cemento rosato che ingloba l’intero edificio si confonde con il colore della pietra arenaria che gli fa da sfondo. L’architetto frequenta assiduamente i segmenti rurali del Colorado e si interessa alle abitazioni rupestri delle popolazioni Pueblo a poca distanza dal sito di progetto, quelle costruzioni oblunghe e scavate nella roccia che riecheggiano nel suo edificio. L’ordine geometrico della pianta serve un edificio massiccio ed espressivo che si confronta col contesto naturale e costruito dei dintorni, ancorandosi nella sua storia alla ricerca di continuità e permanenza.
Pei si apre quindi a una concezione critica della modernità architettonica, cercando di assorbire altri linguaggi e liberandola dai suoi dettami primordiali che la volevano in totale rottura col passato e lontana da problematiche simboliche e monumentali. Certamente, non è il solo e non è il più famoso a farlo nel panorama dell’architettura del secondo dopoguerra, durante il quale la grande narrazione universalistica e salvifica del primo movimento moderno è entrata in crisi. Dalla metà degli anni Quaranta, l’architetto americano Louis Kahn rimette sul tavolo la questione della monumentalità, mentre nei CIAM del dopoguerra (i Congressi Internazionali di Architettura Moderna fondati nel 1928 da Le Corbusier), i suoi colleghi iniziano a porsi nuove questioni che rianimano il significato stesso di modernità, come il rapporto con la storia, con la città, con la tradizione.
Pei è estraneo a tali dibattiti: non si dedica all’insegnamento o all’elaborazione di testi teorici ma fa evolvere il proprio linguaggio esclusivamente attraverso le commissioni che in seguito al successo dell’NCAR si moltiplicano. Musei, edifici universitari, biblioteche interpretati da volumi puri giustapposti che tracciano ombre drammatiche, accompagnati da sequenze spaziali che culminano in oggetti scultorei, come la scala all’Everson Museum of Art di Syracuse, o i lucernari piramidali alla National Gallery di Washington. Le città americane, spesso caratterizzate da pochi edifici emergenti e nelle quali è assente la stratificazione, si affidano a Pei per disegnare monumenti moderni capaci di costruire delle singolarità urbane nel tessuto regolare e interpretare valori civici e culturali privi di retorica.
Questa capacità di costruire simboli civici adatti all’epoca contemporanea porta la famiglia Kennedy a scegliere Pei, tra una rosa di ben quattordici nomi di rinomati architetti contemporanei, per l’incarico della Kennedy Library and Museum a Boston, in memoria di John Fitzgerald dopo il suo assassinio nel 1963. Tale commissione porta con sé una forte carica emotiva e un consistente budget in parte ottenuto grazie a donazioni provenienti da tutti gli Stati Uniti, e si trasforma nel più importante incarico nella carriera dell’architetto fino ad allora. Incarico che Pei assolverà con la consueta professionalità nonostante un tortuoso iter che trascinerà la progettazione per più di una decade. Il risultato finale riprende ed enfatizza le formule progettuali finora applicate e si materializza in una sequenza di volumi puri estrusi a differenti altezze e intersecati fra loro, con un enorme parallelepipedo in vetro e acciaio ad accogliere l’atrio.
Tra le tante commissioni che si susseguono in quegli anni, un progetto dall’esecuzione problematica rallenta l’ascesa di Pei e lo spinge a cercare nuovi incarichi oltreoceano: è la Hancock Tower di Boston, i cui grandi pannelli in vetro si frantumano durante la costruzione.
È però proprio oltreoceano che avviene la consacrazione definitiva dell’opera di Pei, quando i suoi volumi imponenti, sospesi fra modernità e permanenza, appaiono come la perfetta declinazione dei piani di Mitterrand, che gli commissiona appunto l’accesso monumentale al museo del Louvre.
La grande piramide a base quadrata in ferro e vetro, completata nel 1989, è in realtà solo il culmine di un progetto di una complessità enorme, che collega le tre sezioni del museo in un vasto ambiente sotterraneo. Ancora una volta Pei dimostra la capacità nel risolvere programmi complessi con un’estrema coerenza ed efficacia, con soluzioni spesso al limite di un’architettura generica, – da centro commerciale o aeroporto –, ma comunque capaci di assolvere a un ruolo fortemente simbolico. La poetica di Pei cerca agganci nella cultura francese e li trova nei tracciati geometrici di André Le Nôtre, il paesaggista dei giardini di Versailles e maggior interprete del jardin à la française, caratterizzato da simmetria e regolarità imposte agli elementi naturali.
Al suo completamento, la piramide non resterà immune da pesanti critiche, ma finirà progressivamente per essere accolta fra i simboli della città contemporanea.
La carriera di Pei non si conclude col Louvre, ma continua con commissioni di varia taglia che lo portano a costruire anche nel suo paese d’origine. Col finire degli anni Novanta, l’architetto, ormai quasi ottantenne, si concentra su progetti di dimensioni più modeste. Un’estrema coerenza lo porterà a non confrontarsi mai con la cultura postmoderna, che rimette in gioco i codici linguistici colti e popolari, ma a rimanere un autore di monumenti globali, eleganti e dalla potenza plastica, ultimi esemplari di una modernità aulica che rimarrà la sua firma fino all’ultimo.