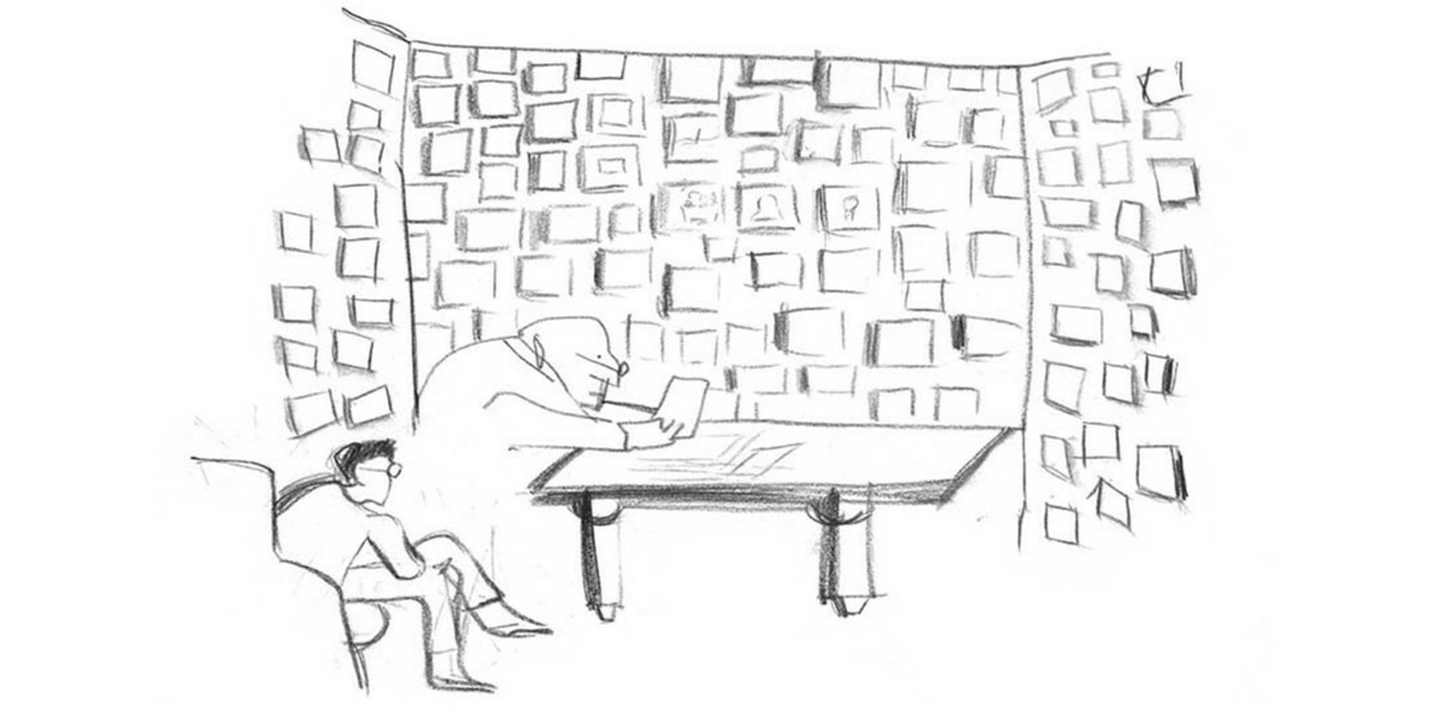
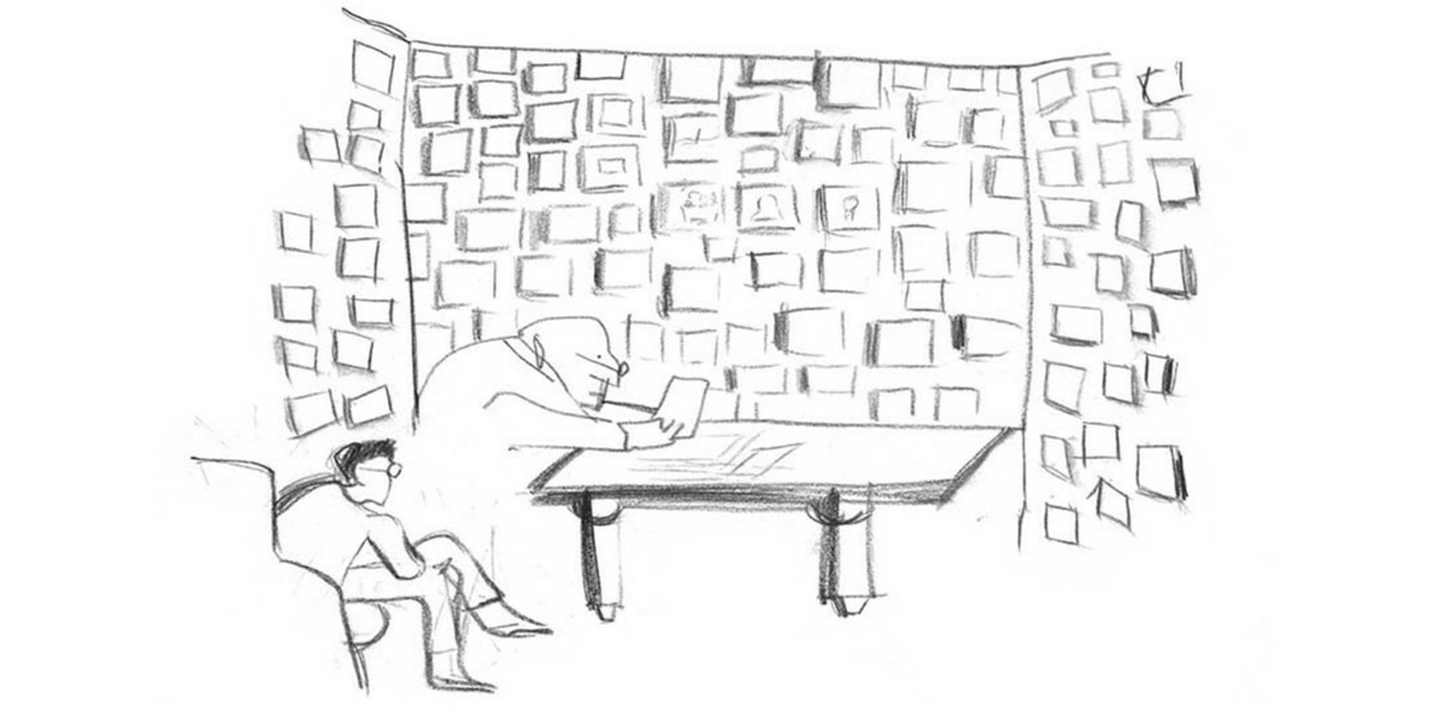
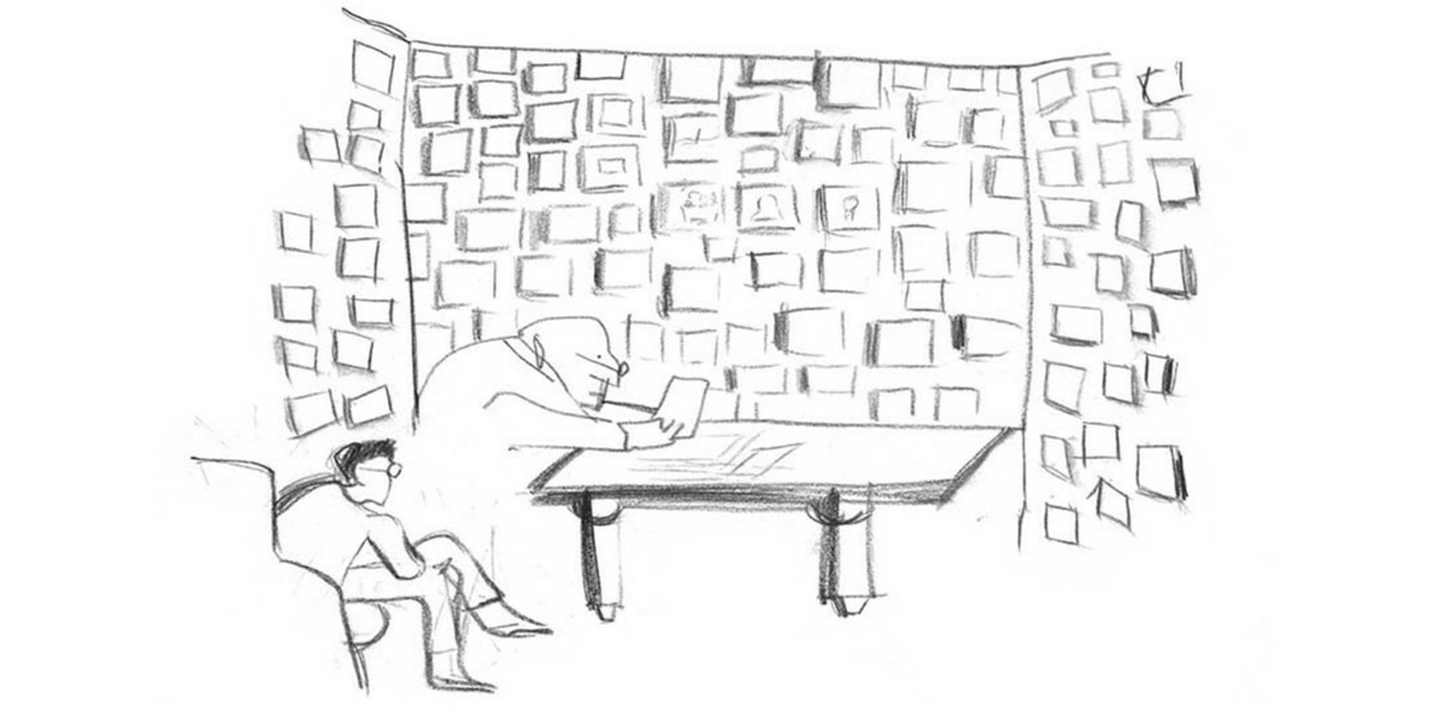
È una specie di monumento dell’intelligenza – quasi sempre maschile – quello che Tullio Pericoli descrive in Incroci, una raccolta di bozzetti che l’illustratore sembra tracciare con la consueta rapidità ed economia di tratti, in cui ritrae gli amici e maestri di una vita. Così scorrono davanti ai nostri occhi le conversazioni giovanili con Cesare Zavattini, l’amicizia di Emanuele Pirella, il professore di liceo Giuseppe Loggi e l’ultima cena con Umberto Eco.
Libro minuto pubblicato da Adelphi – la brevità, ecco, la brevità sembra la caratteristica fondante dell’opera di Pericoli – Incroci condensa quelli che dovremmo chiamare sodalizi artistici, se non fosse che questa espressione non sembra contenere abbastanza la qualità intima di questi incontri, che sono, letteralmente, incroci, cioè legami che si stringono, si intessono, fino a creare la trama stessa delle persone coinvolte.
“Racconterò questa storia così come mi riappaiono le immagini nella mente ogni volta che la ricordo”, scrive, introducendo la storia di Iolanda, una ragazza di servizio che viveva nel suo paese, Colli del Tronto, e dell’entusiasmo per il ritorno di Zè – un amato, un parente, non è dato saperlo. Una storia che sembra scritta nella lingua di Cassola o di quegli scrittori del dopoguerra, dove tutto era all’apparenza più limpido e semplice, ma anche ammantato dal mistero, pieno di cose che non si possono spiegare o raccontare fino in fondo.
E, a proposito, Giuseppe Loggi, il suo professore del liceo, iniziava ogni lezione dicendo che “voi non potrete capire”: non al presente, ma al futuro, come una maledizione o una severa constatazione.
Ma quel non potrete capire era poi così mortificante? Non del tutto. Anzi, schiudeva qualche porta: le porte del non spiegato, del non analizzato, del non teorizzato, del non moraleggiato. Ai miei occhi, che avevano soprattutto bisogno di vedere, appariva come una massa spigolosa e attraente, un diamante grezzo che prometteva splendori senza ancora mostrarli.
Quella frase si trasforma per Pericoli da un ammonimento a un consiglio, che vuol dire che non sempre c’è bisogno di capire le cose: ci ripensa di fronte a Hölderlin, a Zanzotto (alla cui amicizia dedica un brano) o a Beckett, all’indecifrabilità che “rivela una felice parentela tra le loro complessità e l’oscura complessità della mia mente”. “È in quel buio labirinto che nascono e si fanno pescare le mie figure, le idee, i quadri e i disegni”, continua.
Forme del paesaggio 1970-2018 è la grande mostra che Ascoli dedica a Tullio Pericoli (visitabile fino al 3 maggio 2020 al Palazzo dei Capitani, a cura di Claudio Cerritelli) e si ha l’impressione di comprenderla meglio se si accetta di partire da qui, da questa incomprensibilità delle cose e dello spazio di cui parla lo stesso Pericoli. Dagli alfabeti fantastici degli anni Settanta e Ottanta, dalla pittura materica agli acquerelli leggerissimi, alla frantumazione dello spazio, alla riflessione sul vedere, da pittore Pericoli ha sempre dipinto lo stesso soggetto: le Marche, i colli di Sopravena, Rosara, la sua Colli del Tronto.
Questa ripetizione infinita, questa declinazione continua di un soggetto unico e molteplice non è tanto un esercizio compiuto sugli strumenti di rappresentazione, ma piuttosto un esercizio di comprensione della propria patria, insieme materna e paterna. La trasformazione dei registri e dei mezzi pittorici – ora così pesanti e materici, ora così eterei, prima narrativi, poi astratti, prima realisti e poi simbolici – assomiglia allora a un tentativo di decodificazione del reale: è in questa ascendenza locale, provinciale, regionale che si conserva il nucleo inconoscibile, oscuro e misterioso della vita a cui Pericoli torna ogni volta.
Scrive Silvia Ballestra – che a lui dedica Le colline di fronte – in un testo introduttivo al catalogo della mostra (edito da Quodlibet, 2018), che in Pericoli convivono superficie e profondità, stratificazione:
Mi ritrovo a pensare che, dall’inizio, le Marche terrose, modeste e sconosciute sono per lui il sotto, la profondità, il materico che da sempre sostiene e nutre la sua pittura, la profondità, il gesto sin dalle Geologie, e Milano, invece, la superficie più nuda, eterea, frizzante, chiara, mondana dei segni dei volti degli scrittori, dei disegni per i giornali, delle copertine dei libri, della satira.
Ed è proprio a Milano, dove arriva per merito di Zavattini, che Pericoli riscopre le Marche: è il periodo in cui lavora a Il Giorno, in cui illustra – anzi “dipinge sui giornali” come dice lui – “Il racconto della domenica”, ovvero i racconti di Levi, Soldati, Gadda, Calvino (le sue Cosmicomiche nascono proprio qui).
Racconta in Incroci: “un giorno comparve davanti al mio tavolo il direttore. Italo Pietra. Alzai gli occhi incredulo e lo trovai davvero davanti a me, grande com’era, imponente com’era, con la soggezione che mi metteva”. Pietra, collezionista di Licini, Morandi e Guttuso, commissiona a Pericoli un dipinto preciso, “un quadro del tuo paese”:
Mi girò un po’ la testa: il mio paese? Perché il mio paese? E lui che ne sapeva? Non ero preparato a quella richiesta, e dentro di me sentii un piccolo crack. Un contenitore che si rompeva, non so se grande o piccolo, né dove fosse incastrato, né cosa contenesse. […] Quel contenitore si ruppe, e un insieme di cose si mise in circolo: figure, suoni, colori, facce che, ripensati e mescolati tutti insieme nel ricordo, davano forma e senso alla parola nostalgia.
È nel racconto di quel primo quadro e del ritorno ai suoi colli, nella trasformazione dello spazio in paesaggio che si rivela la poetica profonda di Pericoli, un’epifania improvvisa “come se si fosse rotto lo specchio incorniciato della mia memoria, e nella schegge vidi riflesse parti di me insieme a cose che non avrei mai pensato di poter rivedere. […] Mentre guardavo quelle case sulla collina, e gli alberi, i campi e la torre della chiesa, ebbi l’impressione che tutte quelle cose, per una forza nascosta, fossero affiorate dalla madre terra, emerse alla luce da una fertile spinta generatrice”.
Ancora profondità, stratificazione, ancora mistero, in una frase che sembra richiamare gli interminati spazi e i sovrumani silenzi leopardiani.
Manganelli si chiedeva, scherzando, Esiste Ascoli Piceno? (Adelphi, 2019, con dieci cartoline di Tullio Pericoli): rispondendo a una rivista della città che gli commissiona un pezzo, si interrogava sull’affidabilità dei suoi ricordi. “Rammento di aver bevuto l’anisetta in una piazza estremamente decorativa; ritengo improbabile che una piazza così ben fatta esista veramente; probabilmente è una allucinazione, come la parola rua per designare una strada, o le olive ripiene”. E così continua nell’analisi di quella che chiama la sua nevrosi ascolana, divertito e cauto nell’affermare che le carte geografiche mentono e sono generiche e elusive, che anche le corriere che portano in questa città sono coinvolte in una congiura provinciale “il cui scopo è appunto quello di far credere che Ascoli esista”. Manganelli conclude quelle poche cartelle di testo con l’augurio che Ascoli non esista, nel desiderio di immaginare una non città, “visitata continuamente dai messaggeri del nulla”.
È dunque nella provincia di un paese come l’Italia, che di sola (o quasi) provincia è fatto, che resta l’enigma, il mistero, l’antico non come stucchevole dolcezza o parziale esotismo, ma come segreta e intraducibile permanenza sotterranea. Ed è qui che Pericoli scava con la pittura, prima con le Geologie degli anni Settanta, poi nei diagrammi e nei cataloghi, e infine grattando sulla superficie pittorica con gli spazzolini e i punteruoli, quasi che la verità fosse lì, nascosta in piena vista davanti a noi.
Come ricorda bene Ballestra, però, Pericoli è anche la mondanità di Milano, i giornali, la satira di Tutti da Fulvia sabato sera, l’ironia sui salotti borghesi e i pubblicitari, lo Studio Marconi negli anni Ottanta, dove incontra Baj, Colombo e Tadini (altro pittore e scrittore, sempre troppo sottovalutato); Pericoli è la città che si trasforma, la psilocibina e i Beatles con Fachinelli, Montale incrociato in redazione e poi accompagnato in una cinquecento minuscola, lui alto, verso casa.
Ci sono parole come turbinio, entusiasmo ed esaltazione che sembrano le uniche adatte per raccontare gli anni milanesi di Pericoli, tanto diverse – quasi opposte – a quelle della sua pittura, delle sue Marche. Non c’è contrasto però tra i due mondi: così Pericoli resta sospeso a metà, in un equilibrio magico e perfetto, galleggiando come galleggiava Umberto Eco nella piscina della casa di Rosara, nell’ascolano (“Ci entrava e ci restava ore a galleggiare. Il suo corpo lo teneva a galla naturalmente, e me lo ricordo immobile, sdraiato sull’acqua a farsi cullare dalle onde degli altri bagnanti”).
Le pagine su Eco sono forse le più belle di tutta la raccolta: qui racconta di una sera di metà novembre del 2015, di una cena con Lina Bolzoni, Roberto Calasso e Fleur Jaeggy, in cui Eco esagera col burro e, di fronte alle rimostranze di Pericoli (“Ti fa male!”), risponde quasi fiero: “proprio per questo!”. Eco morirà pochi mesi dopo, in febbraio.
Il suo, più di altri, è un ritratto che Pericoli scrive con grazia e affetto: racconta anche che, quando entra nella camera ardente e vede il corpo dell’amico, gli sembra quasi galleggiare sulla bara, proprio come faceva in piscina. Viene da chiedersi se quella raccontata da Pericoli sia una stagione mitica e imprevedibile che a noi è dato solo ricordare, piena di uomini irripetibili; forse è così, o forse è una deformazione del tempo, quella che trasforma i ritratti di amici in icone.
Anche perché il tono con cui ripercorre la sua carriera in Pensieri della mano, una conversazione con Domenico Rosa pubblicata da Adelphi nel 2014, non è di nostalgia, ma di chi ancora indaga i propri mezzi e le proprie opere. Qui ripercorre la sua carriera, la mano come strumento di meditazione, le biografie come mito a cui non credere – ammette che più dell’alcol e le droghe per creare serva un po’ di stanchezza, come diceva anche Dalì. Della sua pittura Pericoli vorrebbe che “si percepisse questo sentimento dei millenni, piuttosto che la denuncia o la dichiarazione di un atto vandalico, che è effimero come siamo noi”; dice che “nel paesaggio c’è una diversa forma di coinvolgimento, addirittura c’è un senso di appartenenza”. E, infine, prende in prestito queste parole di Virginia Woolf:
Le mie radici affondano nella profondità del mondo, in una terra prima secca, dura, poi umida, sempre più giù, attraverso vene di piombo e di argento. Sono pura radice.