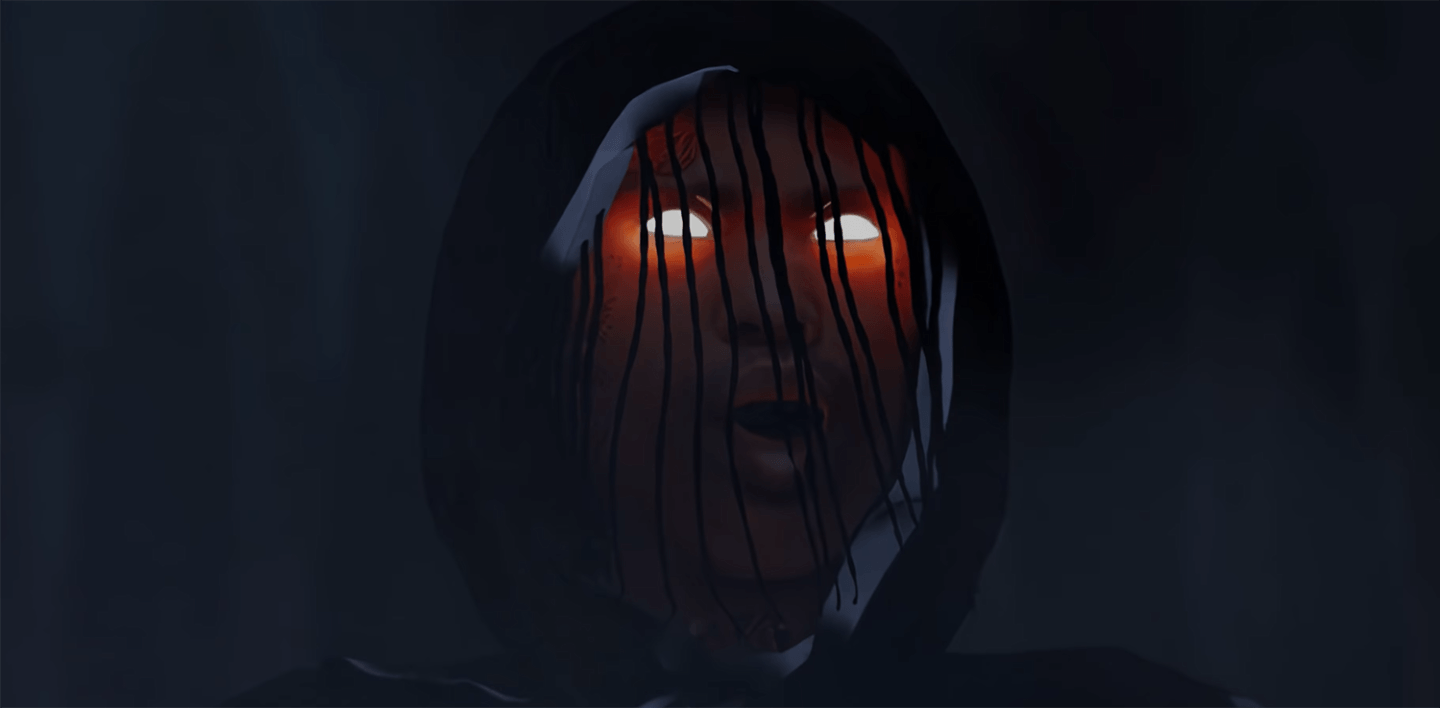
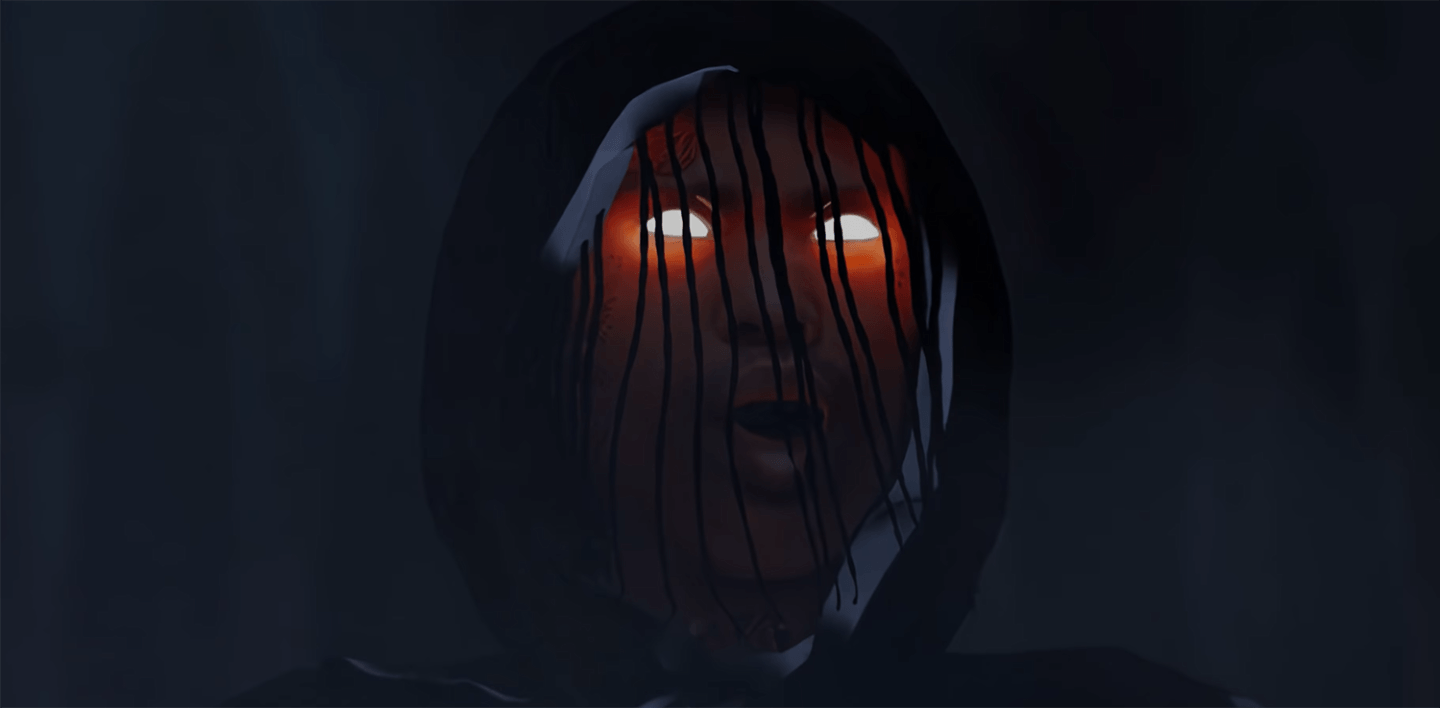
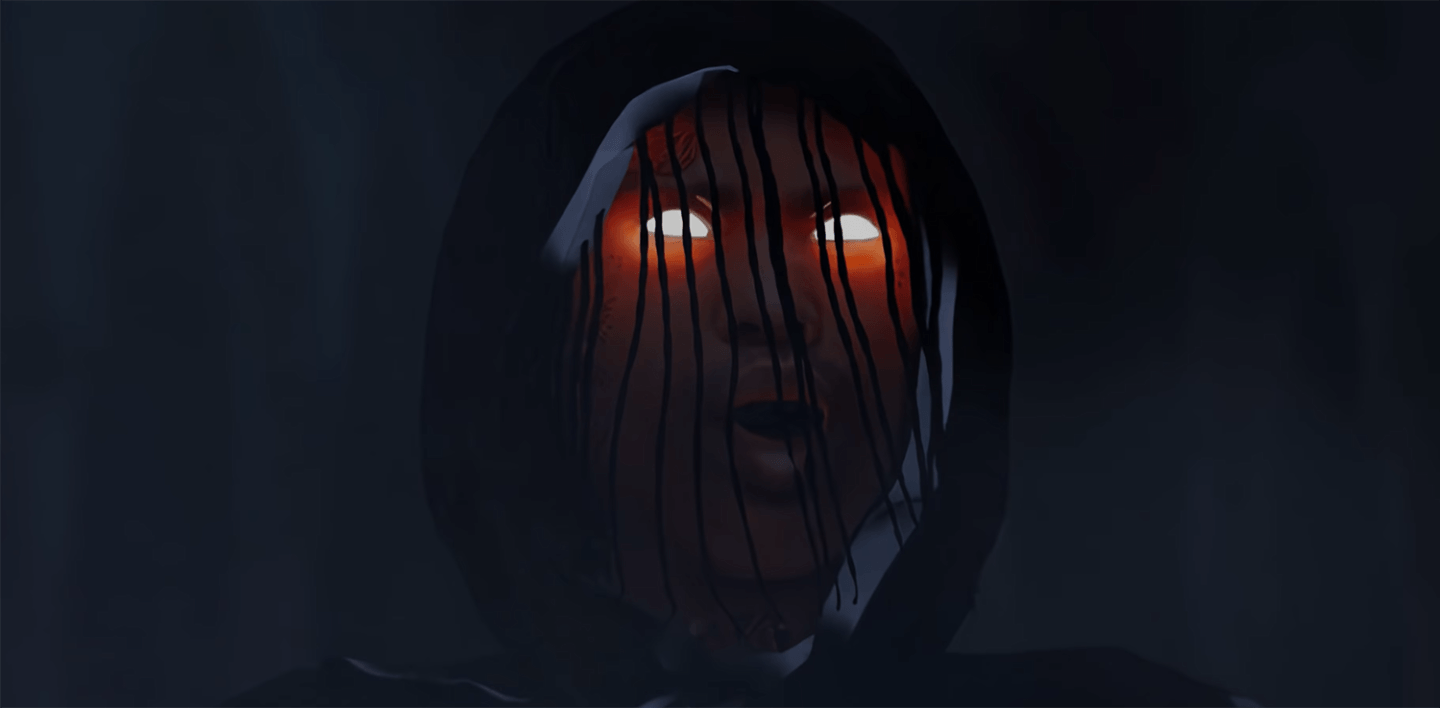
N eon Screams: “il neon urla”. Oppure “le urla del neon”. In ogni caso un titolo evocativo come pochi, che ci ricorda la superiorità dell’inglese sull’italiano quando si parla di musiche vive e in evoluzione, per le quali c’è bisogno di inventare neologismi agili, figure retoriche sperimentali e immagini audaci, infischiandosene di eventuali riverenze linguistiche. In quelle due parole, titolo originale del libro di Kit Mackintosh – pubblicato da NERO per la collana Not col titolo più funzionale di Auto-Tune Theory. Trap, Drill, Bashment e il futuro della musica, traduzione di di Michele Piumini– troviamo già riassunto il contenuto: l’unione tra umano e digitale resa possibile nei generi musicali da software che accordano la voce umana; la personificazione delle macchine e la digitalizzazione dell’uomo: i risultati musicali psichedelici e infestanti derivati da questa tecnica di produzione a partire dagli anni Dieci.
Al centro della ricerca di Mackintosh – giovane produttore, musicista e giornalista inglese – ci sono quelle musiche che hanno fatto dell’auto-tune uno strumento creativo e innovativo. Gli artisti dancehall, trap, drill, bashment e sottogeneri associati hanno preso un software vocale nato alla fine degli anni Novanta come strumento di correzione della tonalità (e quindi come ennesima estensione della sfiancante ricerca di una perfezione impossibile da parte dell’uomo – forse non è un caso che il programma nasca quando la chirurgia estetica è al suo apice di accessibilità e popolarità nel mondo) usandolo al contrario per iniettarsi elettricità pura nelle vene. Invece che inoffensive scale perfettamente intonate, dalla bocca di questi artisti hanno iniziato ad uscire rantoli digitali spaventosi tra il grottesco, l’affascinante, il repulsivo e l’irresistibile.
Mackintosh infila senza soluzione di continuità un’immagine cangiante dopo l’altra. Le parole invadono la mente del lettore e non facciamo in tempo ad assorbirle del tutto che già siamo travolti da una nuova invenzione.
La ricostruzione di Mackintosh è virtualmente perfetta. Seguendo la storia dell’utilizzo creativo dell’auto-tune, partiamo dalla Jamaica (senza ombra di dubbio il paese più influente per la musica mondiale a partire dalla metà del Ventesimo secolo) e dall’esplosione di Vybz Kartel; passiamo per Atlanta, la trap e i suoi predecessori e sottogeneri (frag rap, mumble rap); arriviamo quindi alla drill inglese e americana, per tornare al bashment jamaicano contemporaneo e altri generi caraibici come la Trinibad. Insomma, come scrive Simon Reynolds nell’introduzione, “questo Atlantico Nero riveduto e aggiornato è una diaspora digitale”. Il più grande merito del libro di Mackintosh è quello di impegnarsi in un’analisi critica e storica di generi verso cui un’attenzione di questo tipo è spesso mancata. In parte perché molto recenti, ma anche perché spesso sono stati presi incredibilmente poco sul serio proprio sul piano musicale, prima ancora che sociale. Un paradosso, soprattutto considerando quanto le fan base di queste musiche siano spesso fra le più integraliste, devote e appassionate: basti pensare a come i fan dei soundsystem jamaicani riescano a identificare al volo riddims di ieri e oggi spesso grammaticalmente in tutto e per tutto intercambiabili.
Quella di Mackintosh è una scrittura formato TikTok. Riga dopo riga l’inglese infila senza soluzione di continuità un’immagine cangiante dopo l’altra. Le parole invadono la mente del lettore e non facciamo in tempo ad assorbirle del tutto che già siamo travolti da una nuova invenzione: l’esatta sensazione dello scroll di video ipercinetici sul nostro telefono: “[con l’auto-tune] hai la sensazione di schiacciare carne cruda macinata fra le dita”; “Mavado ha una voce da quercia scheggiata”; “urla da banshee o suoni meccanici che sembravano i primi giri di una giostra diabolica illuminata dalle lucine delle anime perdute”; “le sue voci sono giunture di luce”.
Questo approccio sinestetico è sempre stato una delle tendenze della migliore critica musicale, dal New Journalism in poi, da Lester Bangs in giù: qui però la pratica raggiunge nuove vette di paranoia e opulenza. Non si tratta neanche di un vero e proprio senso di urgenza o di una scelta letteraria affettata – semplicemente, è un linguaggio che, prima della musica, rispecchia quello che ci circonda, il flusso di informazioni in technicolor dal quale siamo investiti senza sosta. Sembra che ogni lettera sia digitata accoltellando la tastiera del computer in preda ad un raptus maniaco. I periodi brevi sono in possesso della lucida follia, la smania, l’ossessività di una striscia di cocaina appena tirata – mescolata ad alcolici o psicofarmaci.
Per capire che cambiamento racconta e rappresenta questo tipo di scrittura possiamo prendere un altro libro della collana Not, il fondamentale e spericolato Più brillante del sole di Kodwo Eshun, che venticinque anni fa metteva insieme estetiche radicali, fantascienza e riflessioni filosofiche per parlare di musica nera, di afrofuturismo, di diaspora africana, di techno, jazz, dub e hip hop. Quella di Eshun era una scrittura ketaminoide e allucinogena, intrisa di una vitalità profonda, confusa e travolgente. Più brillante del sole è – per citare la recensione che ne fece The Wire – il lavoro di uno scrittore che cerca disperatamente di superare le barriere linguistiche per afferrare le ineffabili qualità della musica. La stessa cosa può essere detta oggi per Auto-Tune Theory. Ma possiamo aggiungere che se quello di Eshun è un testo in cui si ha ancora la sensazione di sognare pecore elettriche, con il libro e la scrittura di Mackintosh invece non sogniamo più un bel niente. Siamo colpiti in superficie fino allo sfinimento ma nulla passa dallo stato conscio a quello inconscio.
La psichedelia vocale creata dall’auto-tune non fa viaggiare dentro noi stessi, non apre mondi interiori, né ci fa immaginare universi alternativi allo squallore che ci circonda.
Perché la psichedelia vocale creata dall’auto-tune non fa viaggiare dentro noi stessi, non apre mondi interiori, né ci fa immaginare universi alternativi allo squallore che ci circonda. È una psichedelia epidermica: scorre a velocità alternata sulla nostra pelle, la osserviamo con la stessa narcotica lentezza di un cyborg che si esamina l’avambraccio per mettere in ordine dei fili fuori posto. Non entriamo da nessuna parte, rimaniamo a pattinare sullo schermo e fissare i nostri stessi occhi rossi e inespressivi nel riflesso. Quando parla della Trinibad è lo stesso autore ad ammettere che “al suo interno non esiste nulla. Non offre alcuna esperienza. Racchiude tutto lo squallore della nostra esistenza digitalizzata”.
Mackintosh sovrappone continuamente le grammatiche musicali dei generi trattati (e la sua scrittura vi si adatta riprendendone in qualche modo ritmo, cadenza e tonalità) al mondo dei social. “Familiarizzate con i ritmi vocali del frag e con l’economia dell’informazione dei social media: sono la stessa cosa, e ci stanno ritarando il cervello”. Lo osserva parlando del sottogenere della trap e del suo apice, l’album di Travis Scott e Quavo, “Huncho Jack”. Di Tommy Lee Sparta, uno dei nuovi leader dell’ultima generazione di dancehall jamaicana, ammette che l’ascolto è simile all’esperienza di “cambiare ininterrottamente i filtri snapchat della nostra capacità cognitiva: una volta che ci interfacciamo con le macchine chi assume il controllo, noi o loro?”. Rimanendo in Jamaica i suoni patinati e voluttuosi del nuovo bashment pop che ha conquistato il mondo sono “come fare sesso con un filtro Instragram”. Un tempo la musica del futuro sostituiva l’umano con il robot. Questa musica si avvicina di più alla realtà e realizza l’unico risultato possibile: il cyborg. È così morta e sepolta da tempo la club music, che in origine auspicava proprio quella sostituzione mai avvenuta, mentre “l’estetica biotech dei trapper ha sostituito l’afrofuturismo”.
Più che da ascoltare, queste musiche vanno sentite sul corpo. Timpani e cervello sono bypassati: bassi, batterie e voci manipolate si impossessano del nostro fisico.
Più che da ascoltare, queste musiche vanno sentite sul corpo. Timpani e cervello sono bypassati: bassi, batterie e voci manipolate si impossessano del nostro fisico costringendolo ad assumere una forma specifica, con gruppi di muscoli che si contraggono o rilassano istintivamente. Per averne conferma basta osservare i video musicali di tutti questi artisti, le posture assunte da chi li anima, così come quelle dei giovanissimi fan ai concerti. Nella dancehall e nel bashment si ricorre a una forma di ballo estrema e squisitamente pornografica, che attiva come magneti le parti basse maschili e femminili. Nella trap schiena e spalle si inarcano in avanti, la bocca distorta in una smorfia all’insù, mentre le braccia si induriscono e piegano come compassi pronti a disegnare gesti meccanici, brevi e concisi. Sembra di osservare le movenze di qualcuno che si sta scongelando piano piano. La drill, addirittura, “intesa nel suo senso più ampio non è un vero e proprio genere, ma un atteggiamento estetico” che richiama quello delle gang londinesi in modo parodistico. Insomma è come se premere il tasto “play” equivalesse all’inserimento nel retro del collo di un chip contenente tutte le informazioni per il rimodellamento del nostro corpo. Di nuovo: cyborg.
A proposito di uomini a metà tra mondo empirico e social: qualche tempo fa un amico mi ha inviato un reel, breve estratto di un podcast (“Coktails & Takeaways”) tenuto da Madame Joyce, inglese di origini nigeriane. Nella clip la conduttrice sostiene che le persone caucasiche quando ballano non lo fanno seguendo il ritmo del beat, bensì quello della voce. Nel breve video mentre le ragazze ridono, una di loro per giustificare questa incapacità afferma qualcosa di rivelatore: “sono overstimulated”, cioè troppo stimolati.
Troppi stimoli, troppe informazioni. Drill, dancehall e bashment sembrano fatti per venire incontro a questo sovraccarico: sono un liofilizzato di staticità ritmica.
Troppi stimoli, troppe informazioni. Questi generi (soprattutto trap e drill, in minor misura dancehall e bashment che mantengono nuclei ritmici fondamentali seppur sempre più robotici e schematizzati) sembrano fatti per venire incontro a questo sovraccarico: sono un liofilizzato di staticità ritmica. Annullano il concetto di beat, di poliritmia. Gilles Peterson, nella sua elegia per Tony Allen, spiegava come lo stile della leggenda afrobeat andasse incontro a diverse sensibilità: “se sei abituato a ballare sul quattro quarti puoi farlo sul suo beat, ma se vuoi ballare fuori dal beat, puoi fare anche quello. Ci sono diversi ritmi a cui aggrapparsi, a seconda di ciò che ti piace. E questo è davvero potente: è riuscito a incorporare lo swing e l’ipnotico, due mondi molto diversi”. Ecco invece Mackintosh sulla drill: “essendo la batteria drill così rigida e il resto dell’arrangiamento così amorfo, finisci per ballare sulla voce e non sugli strumenti”. La psichedelia narcotica della voce è l’unico filo di Arianna, il lumicino da seguire. Non può essere un caso che proprio questa tra le diverse musiche “nere” sia quella che in tempi recenti ha trovato successo globale e un audience caucasica così estesa. Non mette in imbarazzo ritmico, la compattezza e ripetitività del ritmo e gli slanci allucinati dell’auto-tune calano tutti nello stesso brodo ipnotico.
Mackintosh cita William S. Burroughs per descrivere “Cocoon” dei Migos e il suo taglia e cuci sillabico. Effettivamente la musica di cui parla a volte sembra più vicina alla letteratura. Gli esperimenti letterari e musicali dei futuristi italiani volevano evocare tridimensionalmente velocità, guerra, macchine; i cyborg autotunizzati vogliono squagliare la faccia di chi ascolta trasmettendo la sensazione dell’assunzione del lean (il beverone che mescola codeina e bevande gassate) oppure le interazioni estremamente codificate e automatizzate al limite dell’umanità delle trap house e delle gang. Nelle loro forme più estreme e autentiche queste musiche descrivono situazioni, stati d’animo e realtà in modo didascalico e allo stesso tempo trascendente. Come dice Mackintosh parlando di un altro brano, “Stacks On Deck” di Lil Wayne: “più che una canzone da ascoltare è una canzone da guardare”. La scrittura di Mackintosh in effetti riesce in quello che di solito è il problema numero uno per chi scrive di musica: aggiunge invece di sottrarre sensazioni all’esperienza d’ascolto. Le parole sparate come con un fucile mitragliatore infarciscono di sfumature sensoriali generi che solo in parte restituiscono la rivoluzione sognata dall’autore.
Il paradosso inspiegabile e crudele è proprio questo: la smania di futuro odora già di passato.
Per Mackintosh quella rivoluzione è il futuro. Secondo lui con la loro innovazione vocale queste musiche promettono squarci di ciò che aspetta l’uomo e, più importante, danno uno schiaffo a tutti i retromaniaci del mondo, incastrati nella nostalgia per un’innovazione musicale che sembra essersi arrestata agli anni d’oro della loro giovinezza. In questo senso l’appendice finale (un dialogo tra l’autore e il poeta Luke Davis) offre spunti interessanti. Uno su tutti l’analisi secondo cui siamo ancora schiavi di un’interpretazione del mondo a misura di baby boomer, per cui anche il filtro che applichiamo alle musiche del Novecento segue la loro evoluzione personale:
Le nostre idee sugli anni Cinquanta e Sessanta pre-hippie (quando questi giornalisti erano bambini) sono puerili; in sostanza la dipingiamo come una fase idilliaca tutta incentrata sulla famiglia nucleare. Fra l’era hippie e il punk questi commentatori culturali erano diventati teenager perciò associamo quel periodo alla ribellione, al disprezzo per le autorità e alla scoperta di sesso e droga.
Ma in qualche modo la costante reiterazione del concetto “vi hanno detto che il futuro era finito, mentivano” diventa una caricatura già dalle prime pagine. La puzza di paura e paranoia mista a entusiasmo drogato che ne deriva aleggia dall’inizio alla fine. L’autore sembra incastrato nel loop di dover dimostrare a tutti i costi che un futuro in musica è ancora possibile. Durante la lettura ci chiediamo tutto il tempo chi sia questa entità che lo angoscia così tanto, chi gli abbia chiesto di dimostrare tutto ciò. Arrivati alla fine realizziamo che la sua voce ha un solo reale destinatario: se stessa.
Il libro, pieno di passaggi critici brillanti, analisi azzeccate e una scrittura febbrilmente divertente, è così condizionato dalle paranoie da cominciare a sembrare una lunga lettera autoconsolatoria. La voce cyborg raccontata dall’autore diventa l’elemento di raccordo tra passato e presente, incarnandone la parte vuota, squallida, priva di contenuto. Soprattutto, ironia delle ironie, priva di futuro. Sembra essere questo il mostro che insegue l’autore durante le pagine, il mostro che lo fa scrivere così forsennatamente: la comprensibile incapacità di ammettere che, ad oggi, un futuro non esiste.
Non voglio fare moralismo, né professare chissà quale fiero stoicismo o divertito pessimismo. Queste musiche sono interessanti, sanno raccontare in modo efficace e sincero realtà sociali e musicali contemporanee. Se prese superficialmente sono divertimento allo stato puro o esperienze stranianti; se analizzate sono codici musicali più o meno nuovi che hanno avuto grande influenza su diversi generi musicali (lo stesso Mackintosh afferma come grazie al mumble rap da qualche anno la differenza fra cantanti e rapper si è fatta indistinguibile). Ma non credo siano la rivoluzione: al massimo uno dei sintomi del percorso che ci sta portando sempre più velocemente a quell’assenza, quel vuoto che fa soffrire lo stesso Mackintosh.
E in definitiva, il paradosso inspiegabile e crudele è proprio questo: la smania di futuro odora già di passato. Come tutte le eccessive dimostrazioni di vitalità, include in sé un elemento mortifero. Ha un qualcosa di perverso, di attorcigliato su se stesso e, ironicamente, sembra avere proprio il fortissimo gusto retromaniaco contro cui Mackintosh muove i suoi passi. L’auto-tune fa pensare a una mummia con i capelli tinti e il trucco pesante. Durante la lettura del libro sembra così di vedere ballare il cadavere del futuro, e non uno squarcio di futuro possibile.