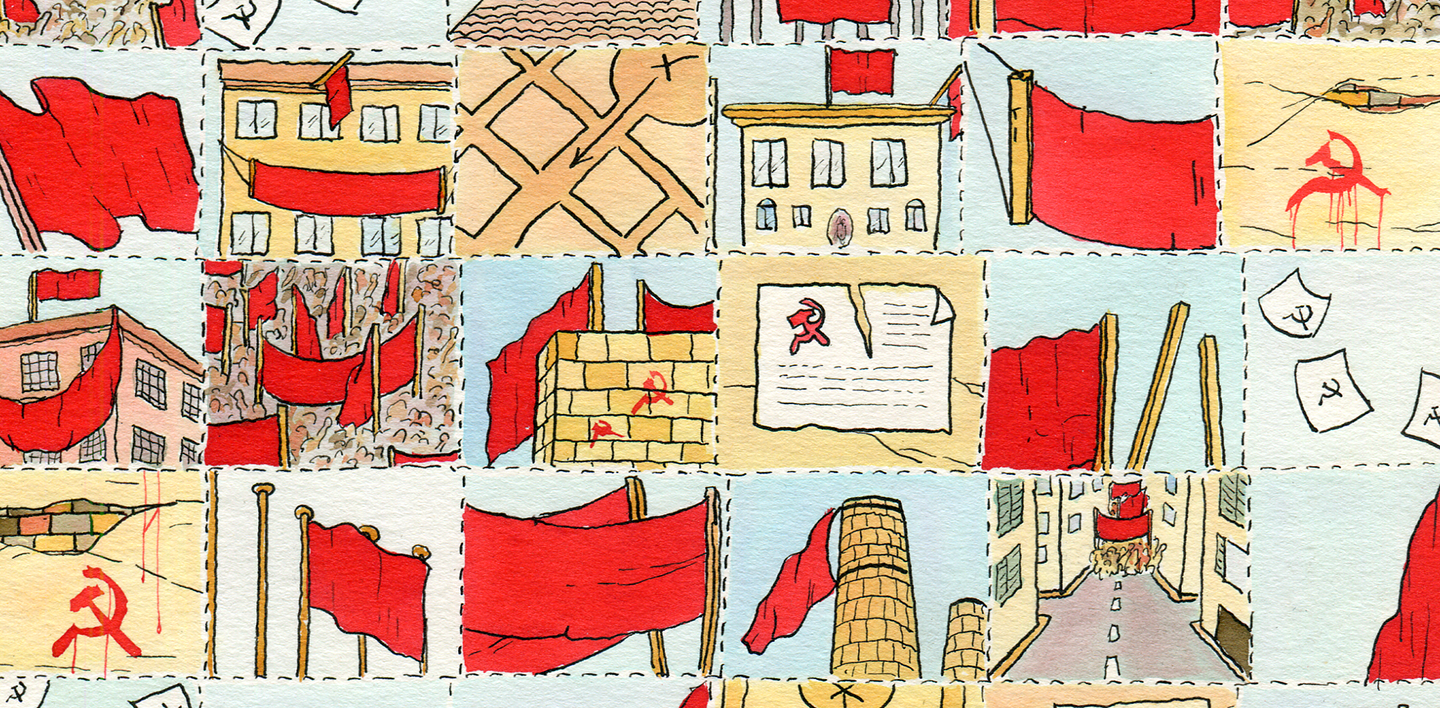
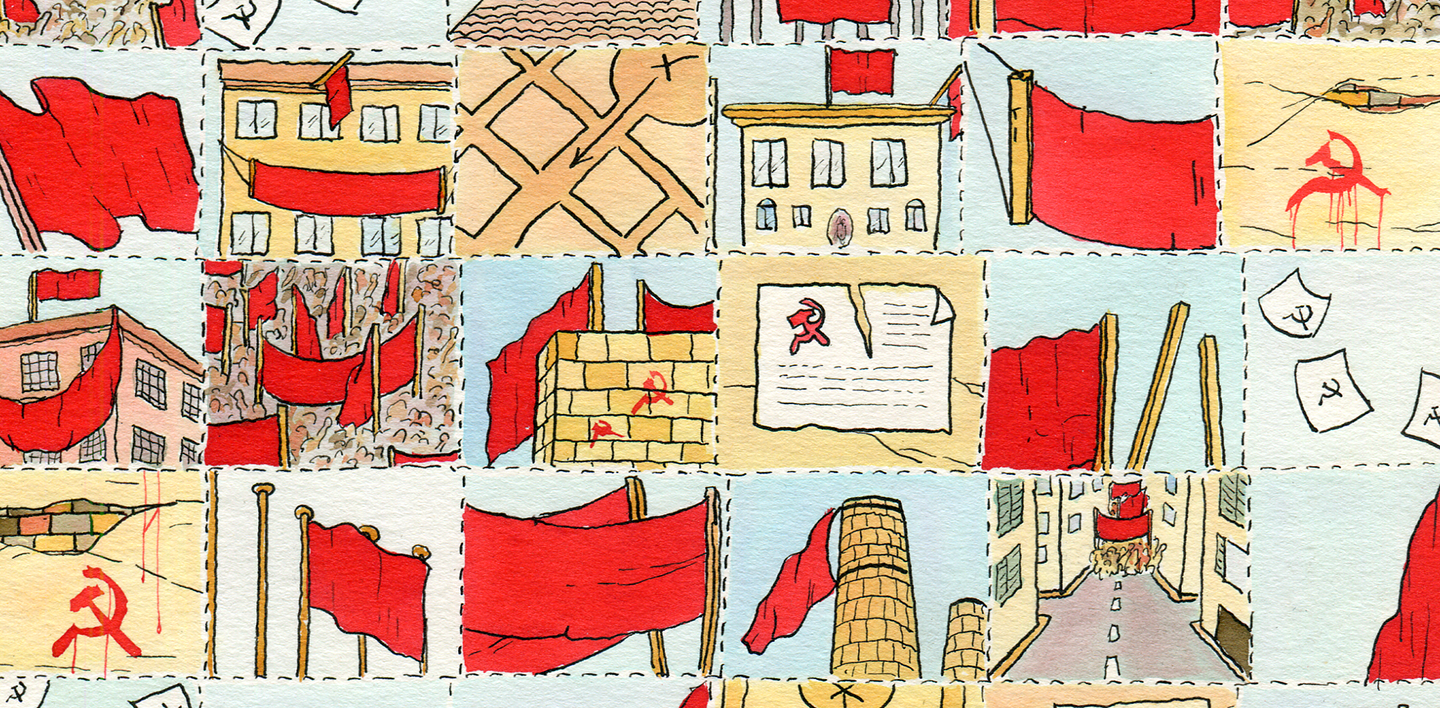
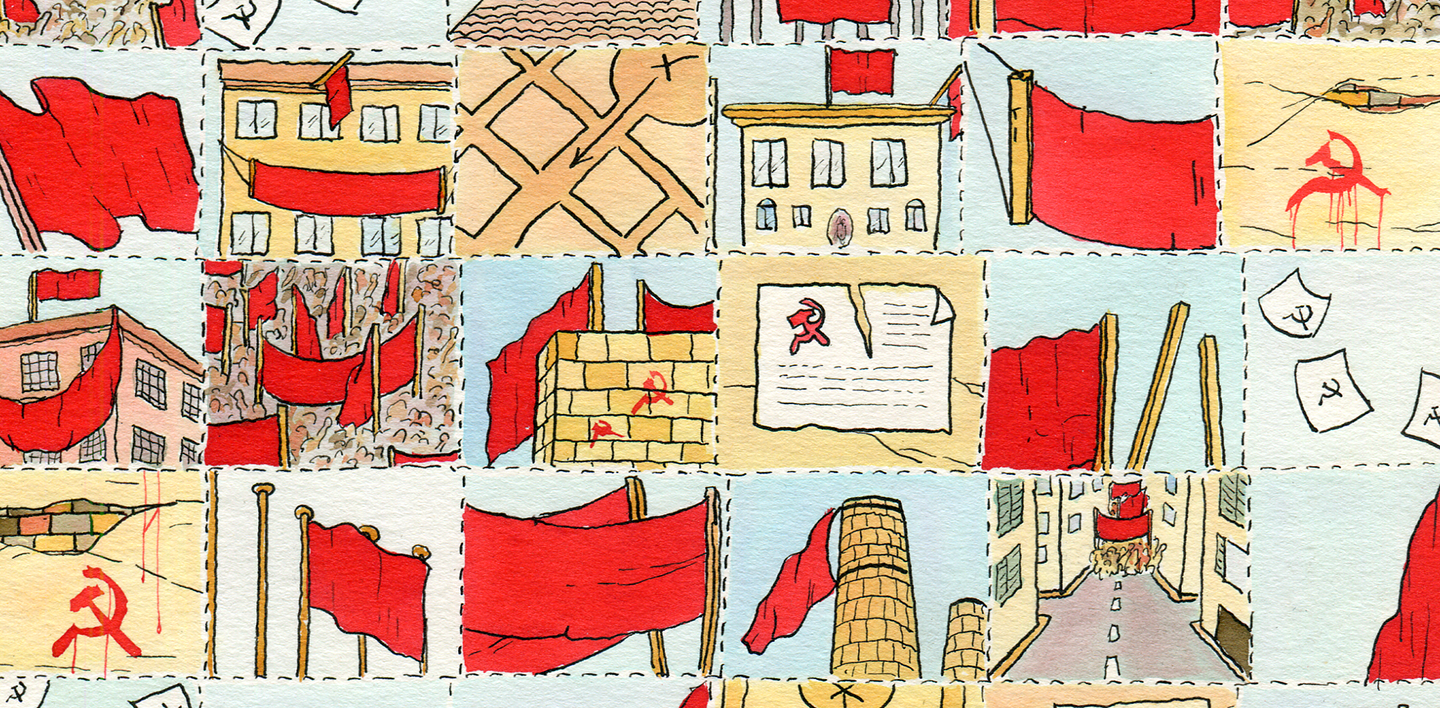
M algrado tutte le devastanti ripercussioni del Processo 7 aprile in termini di ostracismo e di amnesia politica, il processo non riuscì ad annichilire l’impulso di utilizzare l’arte come mezzo attraverso cui esprimere una posizione sulle rivolte degli anni Settanta. Durante il picco della repressione, quando anche solo il possesso di una copia della rivista A/traverso o del mensile Potere operaio poteva dar luogo a delle perquisizioni, gli artisti e gli architetti che non erano stati coinvolti nelle inchieste continuarono a dialogare con i compagni in carcere, realizzando opere che meritano un’analisi approfondita.
La rivalutazione internazionale che ha interessato l’operaismo e l’autonomia, iniziata in particolare dopo il successo mondiale di Impero (di Michael Hardt e Toni Negri), dimostra che la campagna di criminalizzazione di queste due correnti è fallita. A conferma della vitalità dell’operaismo e/o dell’autonomia, si può fare una breve lista di tutti quei pensatori, oggi di fama mondiale, che vi aderirono. Oltre a Negri e Mario Tronti – di cui nel 2019 è stata tradotta in inglese l’opera più importante, Operai e capitale (prima edizione, 1966) – si potrebbero menzionare Silvia Federici, Maurizio Lazzarato, Paolo Virno, Sandro Mezzadra, Christian Marazzi, Giovanni Arrighi, Mariarosa Dalla Costa, Franco “Bifo” Berardi, Leopoldina Fortunati e Sergio Bologna. Alcuni di loro hanno in parte preso le distanze dagli strumenti concettuali dell’operaismo, ma sarebbe difficile negare il ruolo fondamentale che questa corrente ha avuto nelle loro ricerche successive, che hanno affrontato ambiti diversi come l’idea di guerra, la funzione dei confini, il futuro della finanza o il ruolo delle donne nella divisione internazionale del lavoro.
L’operaismo non ha elaborato nessuna estetica generale, ma piuttosto una serie di categorie, posture e modalità di affrontare il lavoro artistico e architettonico.
La letteratura sull’operaismo e l’autonomia tende a esaminare queste due correnti dalla prospettiva della teoria politica e degli studi dei movimenti sociali. Benché questo approccio sia senza dubbio pertinente, esso può rivelarsi riduttivo. Infatti, oltre a trattarsi di due movimenti rivoluzionari, l’operaismo e l’autonomia costituivano forme socioculturali complesse, che comprendevano riflessioni epistemologiche, etiche ed estetiche. Qui il termine “estetica” richiede una precisazione. In questo testo va inteso in senso ampio: come un insieme di pratiche visuali e di strategie comunicative, che non presuppongono l’esistenza di un canone o di un sistema. L’operaismo non ha elaborato nessuna estetica generale, ma piuttosto una serie di categorie, posture e modalità di affrontare il lavoro artistico e architettonico.
Per indagare questa transizione – dalle nozioni alle immagini e alle pratiche comunicative – è necessario però concentrarsi non solamente sulla relazione tra le arti visive e la politica, ma piuttosto sui legami che intercorrono tra arti visive, idee politiche e produzione di sapere. Al fine di limitare la violenza ermeneutica insita nella trasposizione semantica delle idee in immagini (e viceversa), è importante sforzarsi di ricostruire il tessuto connettivo vivente – costituito da dibattiti, letture, ritrovi di militanti e conoscenze personali – che ha unito artisti e teorici. Va evitata anche una concezione aprioristica, tipica di una certa cultura “alta”, di ciò che sarebbe significativo nella produzione estetica – le gerarchie tra cultura alta e propaganda, tra comunicazione visiva e arte, oppure fra architettura e arti figurative – riconoscendo pari dignità a quadri, video, vignette, manifesti, fotografie, installazioni, caratteri tipografici, piani urbanistici, oggetti di design e progetti architettonici.
Questa spiccata eterogeneità solleva una questione fondamentale: le categorie di “arte” e “artista” sono, in ultima analisi, pertinenti? In una recente pubblicazione che ha rilanciato il dibattito sulla storiografia marxista dell’arte, Warren Carter ha delineato una polarità metodologica che si è sviluppata nella tradizione accademica anglofona tra gli anni Sessanta e Settanta, e che conserva tuttora una certa pregnanza. Da un lato, l’approccio di Otto Karl Werckmeister, per il quale una “storia marxista dell’arte” rappresenta una contraddizione in termini, in quanto la nozione di arte, così come i confini disciplinari che essa genera, sarebbe ideologica; dall’altro, la metodologia di T.J. Clark, che fa riferimento agli strumenti intellettuali del marxismo pur rimanendo nell’ambito delle “storia sociale dell’arte”.
L’investimento teorico nell’arte può rappresentare una ritirata strategica o un ‘punto di transito’ del pensiero politico.
Ponendo l’attenzione su una vasta gamma di oggetti, ma anche su traiettorie politiche che a volte eccedono il campo della storia dell’arte e dell’architettura, la prospettiva qui adottata testimonia la mia diffidenza nei confronti della disciplina. Tuttavia, invece che disfarmi delle categorie di “arte” e di “artista” a causa del loro presunto carattere ideologico, intendo valorizzarle, concependole però come territori conflittuali percorsi da tentativi di ridefinire queste categorie in senso materialista, ad esempio attraverso nozioni quali “designer sperimentale”, “operatore estetico”, oppure concetti come “lavoratore intellettuale”, “poiesis” e “techne”.
A metà degli anni Settanta, Perry Anderson si dimostrava scettico rispetto alla tendenza del marxismo occidentale a occuparsi di temi estetico-culturali. Certo, una virata verso l’estetica può a volte segnalare un fallimento politico o un amareggiato disincanto. Eppure, come ha fatto notare Alberto Toscano, l’investimento teorico nell’arte può anche rappresentare una ritirata strategica o un “punto di transito” del pensiero politico. L’osservazione di Anderson rivela, in fondo, una concezione statica dell’estetica e della politica, sfere che invece si sono spesso vicendevolmente influenzate, e non necessariamente a detrimento della politica. Come Gail Day ha fatto notare, lo slittamento criticato da Anderson può essere interpretato, a posteriori, come un rinnovato “investimento sociale delle categorie estetiche”. Questa transizione è diventata oggi ancor più evidente. In seguito alla crisi finanziaria del 2007-2008, al movimento Occupy, alla cosiddetta primavera araba e alle proteste della fine del 2019 che sono divampate dal Cile a Hong Kong, sono sorte diverse forme di arte militante (nota anche come artivism) in molte parti del mondo.
Un numero crescente di giovani scardina la dicotomia tra estetica e politica, dimostrando quanto possa essere sterile questa polarità. Dopotutto, per citare Peter Osborne, il mondo dell’arte occidentale resta, “nonostante tutte le sue fisime intellettuali, il luogo principale, oltre alle istituzioni di formazione superiore, dove […] possono essere discussi gli aspetti politici delle pratiche sociali e culturali, nonché il luogo in cui [le forme di questi] stessi discorsi possono essere trasformate”. Per queste ragioni, l’approccio al radicalismo politico attraverso le arti non deve essere considerato eccentrico o secondario rispetto alle vere ricerche sull’operaismo e l’autonomia. Un’indagine rivolta alle immagini e alle teorie estetiche non è solamente utile a evidenziare nuovi concetti, riflessioni e immaginari, ma rende anche più agevole il dialogo tra le lotte politiche passate e quelle presenti attorno a problematiche condivise, come appunto la comunicazione visiva, oggi onnipresente.
Un numero crescente di giovani scardina la dicotomia tra estetica e politica, dimostrando quanto possa essere sterile questa polarità.
Eppure, alcuni operaisti esprimevano preoccupazioni simili a quelle di Anderson. A tal proposito, citavano volentieri una famosa frase di Manfredo Tafuri che enunciava in modo conciso i loro dilemmi. Nel 1969 Tafuri scriveva: “come non può esistere un’Economia politica di classe, ma solo una critica di classe all’Economia politica, così non può fondarsi un’Estetica, un’arte, un’architettura di classe, ma solo una critica di classe all’Estetica, all’arte, dell’architettura, alla città”. L’analisi di Tafuri aveva il merito di circoscrivere la questione con la dovuta franchezza; tuttavia, la distinzione da lui postulata, che rispecchiava la consueta dicotomia “riformista” vs “rivoluzionario”, era nella pratica meno rigida.
È spesso opportuno evitare di mettere sullo stesso piano l’intransigenza di certe dichiarazioni con la concreta pratica politica. Una miriade di situazioni si sono sviluppate lungo il continuum che lega i due poli identificati da Tafuri. Ciononostante, simili prese di posizione (che in una circostanza un operaista ebbe la sottile perfidia di spiattellare nelle pagine di una rivista artistica) valsero all’operaismo l’accusa di disprezzare l’arte e di non avere alcun riguardo per la cultura. Si tratta di un malinteso. Alcuni potrebbero trovare questa affermazione alquanto strana, se non altro perché proprio Tronti ha apertamente propugnato la “critica della cultura”. Un estratto di uno dei testi fondativi dell’operaismo, Operai e capitale, non sembra lasciare dubbi:
Se cultura è ricostruzione della totalità dell’uomo, ricerca della sua umanità nel mondo, vocazione a tenere unito ciò che è diviso, – allora è un fatto per sua natura reazionario e come tale va trattato. […] La leggenda di una cultura “progressiva” della borghesia “rivoluzionaria“ […] ha portato nel regno della fantasia […]. Qui la critica dell’ideologia deve consapevolmente porsi dal punto di vista operaio come critica della cultura, – lavoro di dissoluzione di tutto quanto già c’è, rifiuto di continuare a costruire sul solco di questo passato. L’Uomo, la Ragione, la Storia, queste mostruose divinità vanno combattute e distrutte, come fossero il potere del padrone. Non è vero che il capitale ha abbandonato questi suoi antichi dei. Ne ha solo fatto la religione del movimento operaio […]. Mentre la negazione di essi, che tiene in sé un pericolo mortale per il capitale, viene da questo direttamente gestita: ridotta a cultura e quindi fatta appunto innocua e servizievole. Così l’antiumanesimo, l’irrazionalismo, l’antistoricismo, da armi pratiche che potevano essere nelle mani della lotta operaia, diventano prodotti culturali in mano alle ideologie capitalistiche.
L’operaismo muoveva una critica alla cultura elaborata dal “movimento ufficiale dei lavoratori”, costituito, in buona sostanza, dal Pci, dal Partito socialista (Psi) e dai sindacati. È sufficiente prestare attenzione alla primissima parola della citazione, “se”. Gli operaisti non si opponevo alla cultura in quanto tale. Disapprovavano invece il modo in cui il Pci sfruttava la nozione gramsciana di “egemonia culturale” per legittimare un approccio moderato e gradualista, l’unico che i quadri di partito ritenevano compatibile con il posizionamento dell’Italia all’interno della sfera di influenza americana.
Quando gli operaisti guardavano con favore alla “fine della battaglia culturale”, la parola “battaglia” identificava, per loro, l’appassionato scambio di opinioni di un’intellighenzia progressista e magari anche di “intellettuali organici” a un partito i quali però conoscevano ben poco delle brutali condizioni di lavoro e di vita degli operai. Gli operaisti sostenevano forme di cultura saldamente legate alle mobilitazioni e all’organizzazione delle lotte, mutando i loro riferimenti e il punto in cui situavano il nesso fra cultura e politica costituiscono.
L’operaismo muoveva una critica alla cultura elaborata dal ‘movimento ufficiale dei lavoratori’, costituito, in buona sostanza, dal Pci, dal Partito socialista (Psi) e dai sindacati.
Nanni Balestrini provò a chiarire questo aspetto controverso in una conversazione con Andrea Branzi nel maggio del 1977. Dopo la fine dell’esperienza di Potere operaio, Balestrini, importante scrittore e artista sperimentale, si avvicinò all’autonomia, cosa che gli costò in seguito il coinvolgimento nel Processo 7 Aprile e un lungo esilio. Branzi lavorava invece come architetto e designer, e aveva alle spalle una cospicua produzione teorica. Non fece mai parte di gruppi politici, ma il suo lavoro era in parte ispirato a Operai e capitale. Durante il loro dialogo, Balestrini dichiarò di apprezzare il fatto che parte del movimento dell’autonomia si affidasse spesso al linguaggio delle avanguardie storiche, sottraendolo però alle sue origini elitarie e trasformandolo in un fenomeno di massa. Branzi replicava che gli operai delle fabbriche non avrebbero saputo che farsene delle parodie dadaiste e dello humor nero dei surrealisti. Lo slogan più incisivo dell’operaismo non era forse “Più soldi e meno lavoro”? Per Branzi, la recente deriva culturale aveva “corrotto” i presupposti teorici dell’operaismo.
A questo Balestrini ribatteva che negli ultimi anni la composizione sociale dei lavoratori di fabbrica era profondamente cambiata; inoltre, fin dal principio, l’operaismo aveva rivendicato la necessità di riappropriarsi della cultura “alta”. Balestrini ricordava a Branzi un celebre passaggio di Operai e capitale: “Le parole, comunque le scegli, ti sembrano sempre cose dei borghesi. Ma così è. In una società nemica non c’è la libera scelta dei mezzi per combatterla. E le armi per le rivolte proletarie sono state sempre prese dagli arsenali dei padroni”. Sembra ironico che la presunta ostilità dell’operaismo verso la cultura venisse rivendicata proprio da Branzi, che aveva utilizzato l’operaismo per produrre cultura. Ma così è. In questo contesto, spesso ci si imbatte, in fecondi paradossi.
Un estratto dall’introduzione di Immagini di classe. Operaismo, Autonomia e produzione artistica di Jacopo Galimberti (Deriveapprodi, 2023).