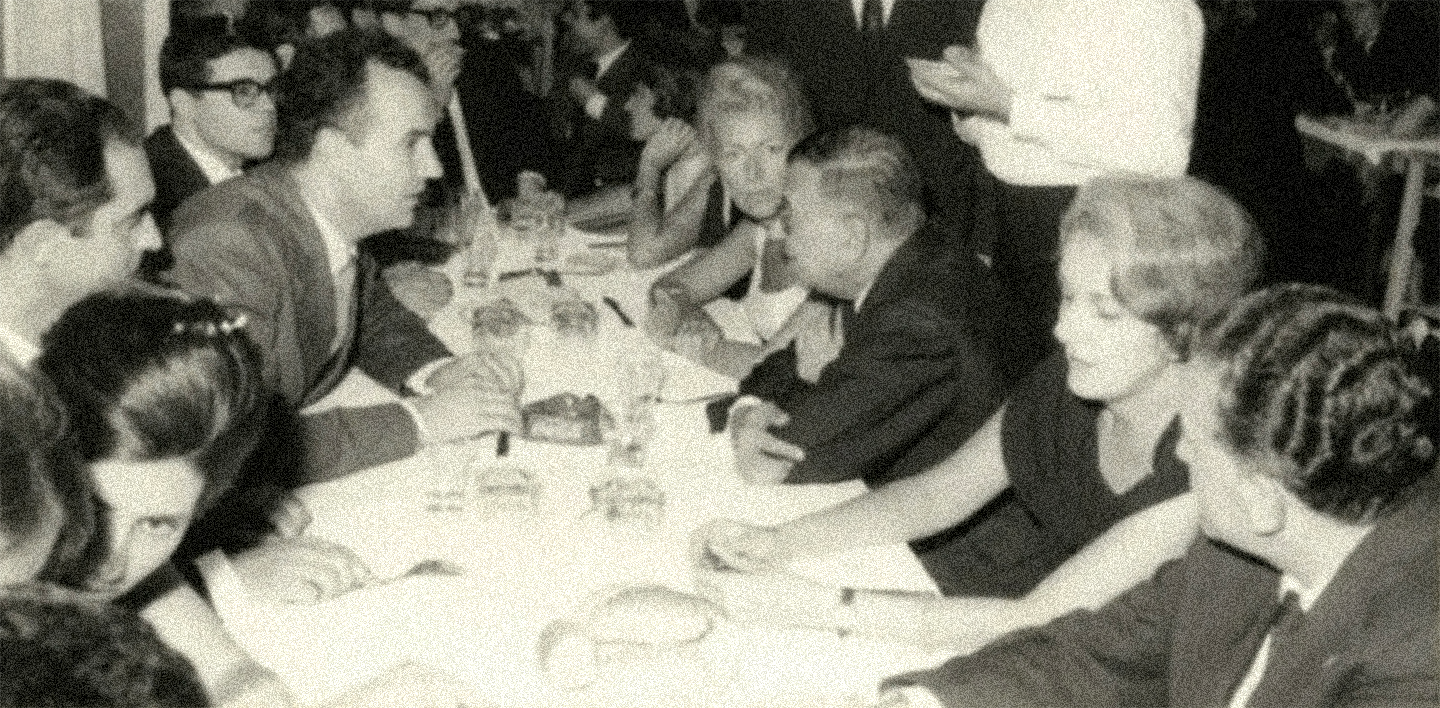N
el luglio 1959 un ventiduenne Carmelo Bene, insieme all’amico Alberto Ruggiero, riesce a ottenere un incontro con Albert Camus. Lo scrittore era all’epoca, con Sartre e contro Sartre, l’intellettuale verosimilmente più influente d’Europa, insignito, due anni prima, del Nobel per la letteratura. Quell’estate si trovava a Venezia perché, alla Fenice, andava in scena un suo adattamento dei Demoni di Dostoevskij, di cui aveva curato anche la regia. La passione per la scena, in Camus, era del resto tutt’altro che avventizia, e risaliva alla sua giovinezza d’attore e di fondatore del Théâtre du Travail, una formazione di teatro popolare e marxista, poi trasformata nel Théâtre de l’Équipe, ad Algeri, dopo la rottura di Camus con il Partito comunista francese. André Malraux, divenuto ministro della Cultura in quello stesso 1959, gli avrebbe proposto di lì a poco la guida della Comédie-Française, esperienza che non ebbe principio perché Camus morì nel 1960 in un incidente d’auto.
Il Camus che Bene avvicina all’ingresso artisti della Fenice è dunque, oltre che un autore celeberrimo (“un mito, in assoluto lo scrittore più letto”, ricorderà Bene), anche un uomo di scena, con solide preferenze e idiosincrasie. Aveva sospeso, ad esempio, la concessione dei diritti del suo Caligola in seguito a una rappresentazione milanese che l’aveva particolarmente sconcertato. È Bene a ricordarne maliziosamente le circostanze:
il
Caligola era stato anni prima una sorta di debutto del “Piccolo” di Milano alle sue origini, Renzo Ricci nella parte di Caligola, Paolo Grassi l’organizzatore. Oltre alla regia, Strehler ebbe anche la sciagurata idea (vizietto, quello di recitare, recidivato negli anni a seguire) di vestire i panni del poeta Scipione che, dopo Caligola, è il ruolo più importante. Camus visionò questo orrore e, in seguito, tolse i diritti di rappresentazione a tutto il mondo. In pratica divenne un testo proibitivo e non se ne parlò più per anni. Io e Ruggiero decidemmo che bisognava incontrare Camus.
I due, dopo quella prima imboscata davanti alla Fenice, presero appuntamento con lo scrittore in piazza San Marco, al Florian. Paolo Levi, amico sia di Ruggiero che di Bene, riferisce che Camus diede subito quell’assenso che aveva negato persino a Laurence Olivier, compiaciuto per l’energia e l’età dei due ragazzi. A convincerlo, in particolare, fu il fatto che Bene avrebbe interpretato Caligola, in qualche modo doppiando l’intuizione felice del debutto parigino con un giovanissimo Gérard Philipe. Alla prima, al Teatro delle Arti di Roma, ci fu il tutto esaurito. Il fatto che Camus avesse concesso, per di più gratuitamente, i diritti a questi due giovani sconosciuti contribuì enormemente a creare intorno allo spettacolo l’aura dell’evento e, a posteriori, seppur in assenza di studi specifici o di ricostruzioni d’archivio, si stabilì nel 1959 l’atto di nascita della neoavanguardia teatrale anche per il peso simbolico di questa circostanza. Dell’evento in sé restano alcune cronache e le memorie del suo protagonista:
Avevamo […] affisso manifesti stranissimi per tutta Roma. Frasi stralciate e lasciate lì sospese, senza spiegazione alcuna.
Io voglio soltanto la luna. Vivere è il contrario d’amare. C’era poi la polemica contro le accademie teatrali del tempo, molto sentita. Era, quella nostra, l’unica, vera scapigliatura che abbia avuto questa miseria del teatro italiano.
Lo spettacolo andò in scena con la Compagnia dei liberi: Alberto Ruggiero curava la regia, mentre Bene appariva come protagonista ma, per così dire, in “minore”: “Nelle locandine di allora figuravo come Carmelo Bene Junior. Volli applicare quel “Jr.” come un fatto minoritario, un atto di superba modestia. Toglierò questo “Jr.” quando l’esito lo deciderà, mi dissi. L’esito deciderà che, da quel Caligola in poi, potevo toglierlo. A ventidue anni ero diventato l’allievo di me stesso”.
Nel teatro dedicato ai futuristi da Anton Giulio Bragaglia, con lui in platea, Bene inizia dunque la sua carriera all’insegna dello scandalo. Il testo insiste sulla presenza di uno specchio, e la scena dello spettacolo apparve carica di specchiere di cui una, in particolare, destinata al finale: Bene, nella “parte dell’imperatore pazzo, mise in scena un incidente dalle radici culturali futuriste. Con un pugno premeditato mandò in frantumi una specchiera e centinaia di schegge colpirono l’indifeso pubblico borghese in prima fila, al grido: ‘Gli uomini muoiono e non sono felici!’”.
Il Camus che Carmelo Bene avvicina all’ingresso artisti della Fenice è, oltre che un autore celeberrimo, anche un uomo di scena con solide preferenze e idiosincrasie.
Nelle cronache abbondano i riferimenti alla recitazione di Bene, che presenta già i tratti di quanto caratterizzerà il suo genio scenico. C’è poi chiaramente all’opera la circostanza per cui il Caligola di Camus, assai più profondamente che un ritratto bozzettistico di Hitler, risulta essere un esorcismo giovanile del suo autore verso la propria ambizione, mentre a Bene il portato magnifico e ributtante del narcisismo del tiranno offre una maschera perfetta per l’esercizio di quell’amor proprio che lo aveva fatto autonominare in minore. Sandro De Feo coglie immediatamente questa solidarietà intima tra Bene e Caligola, scrivendo che l’attore: “con quell’aria di pagliaccio vizioso e di teppista provocatore, è riuscito a darci più d’una volta non solo il disagio di quella scandalosa grandezza ma anche la pietà di quell’anima angosciata e ‘pura nel male’”. Caligola è, in fondo, un intellettuale profondamente mediterraneo, una figura in tensione verso una libertà senza condizioni, ma che sciaguratamente detiene un potere privo di limitazioni se non quelle che egli stesso (non) è in grado di darsi.
Un elemento che non va trascurato è, inoltre, il debito che Camus contrae, sin dall’esordio della sua attività scenica, con Antonin Artaud, poiché tracce essenziali di questa influenza appaiono nel Caligola ponendo, di fatto, Bene in un’orbita artaudiana, che la maturerà consapevolmente quasi un decennio più tardi. Nel 1936 Camus inaugura la prima stagione del Théâtre de l’Équipe con un manifesto che dichiara, in apertura, il suo debito verso Artaud: “Le Théâtre de l’Équipe demandera aux œuvres la vérité et la simplicité, la violence dans les sentiments et la cruauté dans l’action”. Anche le opere teatrali di Camus sono profondamente imbevute della crudeltà artaudiana e il Caligola, in particolare, ne concentra la fascinazione. Bisogna poi ricordare che la prima versione risale al 1938-1939, pochi anni dopo la pubblicazione dell’Eliogabalo di Artaud, ed è legittimo assumere che Camus conoscesse l’opera sull’anarchico incoronato.
La dismisura, la violenza frenetica, la depravazione, ma soprattutto la teatralità connessa a un ruolo politico di brevissima durata accomunano le due figure imperiali nella lettura che ne danno rispettivamente Artaud e Camus: per Camus, questa teatralità si traduce nella capacità di Caligola di operare contemporaneamente come un tiranno sanguinario e come un istrione che costantemente svela al pubblico l’oscenità grottesca e il violento arbitrio di quello stesso potere che esercita. C’è dunque un fronte artaudiano che, per via di Camus, si installa da subito nella poetica beniana. Tuttavia, è Bene stesso a notarlo nelle sue memorie, il Caligola è “[u]n testo che oggi risulterebbe datato, ma che allora faceva una certa impressione”. Il giudizio di Bene è confermato dalla generale e rapida elisione di Camus dal repertorio drammatico occidentale, nei cui cartelloni l’autore de Lo straniero ha sempre occupato un posto defilato. (…)
Camus, che pure aveva partecipato attivamente alla Resistenza, aveva maturato negli anni una posizione profondamente scettica nei confronti del marxismo e poi apertamente antagonista verso il blocco sovietico.
I limiti del teatro di Camus, la relazione tra intelligenza e azione, il mandato politico dell’arte e il ruolo di guida dell’intellettuale sono riconducibili a una questione più vasta, che galvanizzò l’intellighenzia europea a partire dal 1951, l’anno che vede le stampe del suo L’uomo in rivolta. La disputa che impegnò, su estremi opposti e mai più conciliati, Sartre e Camus è interessante in prima istanza per la solidarietà diretta che manifesta con i limiti del teatro camusiano (e dunque per la saldatura tra azione scenica, compito dell’intellettuale engagé e azione politica nel mondo), e poi per la polarizzazione che intorno ai suoi protagonisti venne a crearsi anche in Italia.
Camus, che pure aveva partecipato attivamente alla Resistenza francese con il gruppo clandestino di Combat, aveva maturato negli anni una posizione profondamente scettica nei confronti del marxismo e poi apertamente antagonista verso il blocco sovietico, oltre a essere un critico radicale dello stalinismo. Ne L’uomo in rivolta l’assunto centrale consiste nel fatto che solo ribellandosi è possibile dare senso a un’esistenza. La posta in gioco è la libertà individuale, compromessa in maniera irreversibile quando il rivoltoso decide si sottomettersi alla rivoluzione. Per Camus è poi la radicale autonomia espressa dall’uomo che si rivolta l’unica a poter garantire agli altri una libertà altrettanto piena: “Io mi rivolto dunque noi siamo”, è il senso decisivo e la formula definitiva in cui viene a essere ricapitolato il suo pensiero.
Per contro Sartre, nello stesso periodo, è convinto che solo la rivoluzione marxista-leninista guidata dal partito possa offrire all’uomo la piena libertà. Sartre predica la necessità per l’intellettuale di portare il suo specifico contributo alla rivoluzione e pratica in questi anni un compagnonnage critique nei confronti dello stalinismo. Quello di Camus – con la sua analisi antistorica e antitotalitaria del comunismo sovietico – parve dunque un oltraggio all’ortodossia marxista tale da far insorgere il gruppo di intellettuali schierati con Sartre.
Sartre, nello stesso periodo, è convinto che solo la rivoluzione marxista-leninista guidata dal partito possa offrire all’uomo la piena libertà.
L’assalto sartriano su “Les Temps Modernes”, la rivista di cui era il fondatore, avvenne su procura e fu firmato da Francis Jeanson. Camus fu accusato d’essere un’anima bella, di professare un principio di inanità nei confronti dell’insurrezione degli oppressi: il suo uomo in rivolta fu definito un solitario, incapace di socializzare il suo moto di rifiuto. A partire dall’assunto che “rivoltarsi è sempre rivoltarsi contro”, si vide in lui una “coscienza ulcerata” che difettava di un oggetto rispetto al quale insorgere. Alla distanza intellettuale e all’umanesimo professati da Camus venne opposto il vincolo concreto all’azione politica, ma anche la necessità che le idee fossero radicate nella realtà e che se ne assumessero il rischio.
La replica di Camus non si fece attendere e venne pubblicata sulla stessa rivista da cui era partito l’attacco. Camus rispose direttamente a Sartre, scrivendo tra l’altro:
Se si ritiene che il socialismo autoritario sia la principale esperienza rivoluzionaria dei nostri tempi mi pare comunque difficile non mettersi in regola con il terrore che esso presuppone proprio oggi o, per esempio, sempre per rimanere sul piano della realtà, con il dato concentrazionario […]. La verità è che il suo collaboratore [si riferisce a Jeanson, n.d.r.] vorrebbe che ci si rivoltasse contro tutto, tranne che contro il partito e lo Stato comunista. È sì favorevole alla rivolta; e come potrebbe non esserlo nelle condizioni che gli pone la sua filosofia? Ma è attirato dalla rivolta che assume la forma storica più dispotica. […] sembra essere d’accordo con una dottrina per poi tacere sulla politica che essa comporta.
Quando Bene incontra Camus il quadro geopolitico, rispetto alla situazione in cui si era svolta la polemica con Sartre sette anni prima, appariva profondamente trasformato: Stalin era morto, l’Armata Rossa aveva invaso l’Ungheria e le lotte anticoloniali che avevano portato all’indipendenza della Tunisia e del Marocco stavano infiammando l’Algeria. Camus era nato e cresciuto in Algeria, e propendeva per una soluzione collaborativa con la Francia, lontana dunque dall’istanza di piena indipendenza per cui lottava il Fronte di Liberazione Nazionale per cui parteggiava Sartre e in cui militava Frantz Fanon.
Il funerale della cosa
Nel 1960, la guerra d’indipendenza algerina brucia intanto in un altro evento che si svolge a Venezia e che registra quello che è considerato il primo happening europeo. La galleria al Canale ospita la seconda manifestazione dell’Anti-Procès, “atto collettivo d’opposizione”, organizzato da Jean-Jacques Lebel e Alain Jouffroy, al quale partecipano decine di artisti, musicisti e poeti. Il processo cui l’evento si oppone programmaticamente dal titolo è quello al Réseau Jeanson, fondato da quello stesso Francis Jeanson, collaboratore di Sartre, che aveva attaccato Camus sulle pagine di “Les Temps Modernes”. I membri del Réseau, militanti francesi sostenitori del FLN algerino, erano stati sottoposti a processo per tradimento. L’Anti-Procès, come il Manifesto dei 121. Dichiarazione dei diritti di insubordinazione della guerra d’Algeria, insorgeva contro l’accusa e si schierava decisamente a fianco della lotta anticoloniale, denunciando tra l’altro il ricorso sistematico alla tortura da parte dei militari francesi. Lebel aveva iniziato la sua insurrezione contro la guerra d’Algeria appena ventenne, quando aveva abbandonato la Francia per trasferirsi in Italia, e qui aveva preso a pubblicare una rivista di arte, poesia e politica, “Front Unique” (1956-1960), a Firenze.
L’evento veneziano era preceduto da una sorta di manifesto, la Déclaration pour l’Anti-Procès 2, dove si istituiva un legame direttamente generativo con l’azione rivoluzionaria delle avanguardie storiche e veniva dichiarata la “necessità di un’arte che faccia della pittura, della poesia e della musica un solo grido, il grido organico dell’uomo”. Anticolonialismo, lotta politica, avanguardia storica e sperimentazione contemporanea si saldano in nome della necessità di un rinnovamento radicale nell’espressione e nel sistema delle arti.
Nel 1960, la guerra d’indipendenza algerina brucia intanto in un altro evento che si svolge a Venezia e che registra quello che è considerato il primo happening europeo.
Lebel sostiene che l’arte debba essere pienamente e fondamentalmente contro tutti i regimi e le forme di coercizione, ma soprattutto contro coloro che la piegano ai loro fini: “A questa concezione mercantile, controllata dallo Stato, opponiamo un’arte combattente, pienamente consapevole delle sue prerogative, un’arte che non si sottrae dal dichiarare la propria posizione, dall’azione diretta, dalla trasmutazione”.
Il vernissage veneziano porta la data emblematica del 14 luglio e segna la storia dell’happening con un’azione intitolata Enterrement de la Chose de Tinguely. Si trattava di un funerale simbolico, con letture di Sade e Huysmans, in cui il feretro della “cosa”, una scultura dell’artista svizzero Tinguely esposta nello stesso evento, veniva prima vegliato, poi caricato su una gondola e accompagnato con un piccolo corteo acquatico di imbarcazioni messe a disposizione da Peggy Guggenheim fino all’isola di San Giorgio Maggiore, dove veniva gettato in acqua. Il pubblico era considerato parte integrante dell’evento sin dall’invito, in cui veniva indicato di vestire abiti formali e appropriati alla cerimonia funebre.
Con questa sepoltura dell’oggetto Lebel dichiarava l’“abolizione del diritto di speculare su un valore commerciale arbitrario e artificiale, attribuito, non si sa come, a un’opera”.
Con questa sepoltura dell’oggetto Lebel dichiarava l’“abolizione del diritto di speculare su un valore commerciale arbitrario e artificiale, attribuito, non si sa come, a un’opera”, insieme anche all’“abolizione del privilegio di sfruttare artisti intellettualmente ‘sanguinanti’ per appropriazioni di volgari intermediari e mediatori che detestano l’arte”. Nell’happening, per definizione inappropriabile, Lebel proclamava così il primato dell’azione come immediato sovvertimento dall’espropriazione a fini economici della creatività artistica, e della “aberrante relazione soggetto/oggetto” dominante nell’arte moderna. L’happening era dedicato a Nina Thoeren, giovane artista e amica di Lebel, che pochi giorni prima era stata violentata e uccisa a Los Angeles. Nell’Enterrement si compiva dunque un funerale a un tempo polemico e straziante, e una rivolta contro la violenza coloniale, il mercato artistico e la cultura stupratoria. Lebel era persuaso della necessità e della praticabilità di un fronte comune e internazionale tra artisti e spettatori volto a realizzare il potenziale trasformativo dell’evento, all’insegna di una sessualità emancipata e di un radicale rifiuto della morale borghese e cattolica che, mentre la reprime, contemporaneamente pratica forme continue di violenza e accetta la tortura come un “male necessario”.
È essenziale ricordare questa declinazione europea perché, nonostante Lebel e Allan Kaprow ebbero numerosi rapporti e collaborazioni, Lebel sostenne da subito la fondatezza di una via europea all’happening che, nel suo caso, originava da Dada, dal Surrealismo e in particolare dal teatro della crudeltà artaudiano (il primo Anti-Procès ebbe tra i suoi protagonisti Roger Blin), laddove nella formazione e nello sviluppo statunitense, attraverso Kaprow, la genealogia di riferimento comprendeva John Cage e Jackson Pollock. È tuttavia Lebel stesso a sottolineare le vicinanze tra i due movimenti in un ritorno di quello che dovrebbe essere “il fine dell’arte, del quale è stata espropriata dalla società del consumo”: l’happening infatti restituisce “all’attività artistica ciò che le è stato strappato: l’intensificazione del sentimento, il gioco dell’istinto, un senso di festività, l’agitazione sociale. L’Happening è soprattutto un mezzo di comunicazione interiore; quindi, e per inciso, uno spettacolo”.
Interrogato alla fine degli anni Settanta sulle colonne di “Flash Art” da Bernard Blistène a proposito della forma happening, che nel frattempo s’era consolidata al punto da essere ricondotta in molti casi nei circuiti artistici e di mercato che furiosamente contestava, Lebel risponde: “L’happening è l’irruzione e l’eruzione del simbolico nel reale. Spesso per effrazione, per accidente, per slittamento, per confusione mentale, e anche per disperazione”. E a Blistène che lo incalza “Per te, allora, quando comincia veramente?”, replica:
Soggettivamente, per me cominciò veramente durante la Guerra d’Algeria. Ho visto un tizio ammazzato dai poliziotti, sotto casa mia, vicino alla Place Maubert. Un tizio con cui avevo mangiato e fumato in uno dei piccoli caffè algerini della “medina” parigina che noi – quei pochi “disertori” culturali e politici – frequentavamo inorriditi e disgustati della “molto francese” civiltà. Era l’epoca della grande manifestazione dei 30.000 algerini per le strade di Parigi. La repressione poliziesca era stata totalmente isterica e barbara. Ci fu sangue, botte, uccisioni. I poliziotti avevano rastrellato e rinchiuso centinaia di manifestanti nel Velodromo d’Inverno (proprio là dove gli stessi poliziotti francesi, durante la Seconda guerra mondiale, sotto l’occupazione nazista, avevano rinchiuso gli ebrei prima di consegnarli alle ss che li spedirono ai campi di sterminio). L’indomani furono trovati nella Senna decine di cadaveri di algerini. Questo non bisogna mai dimenticarlo quando si parla degli anni ’50 e ’60. […] Era questa l’“atmosfera parigina” in cui noi soffocavamo. […] la scena politica e culturale era occupata da spettri.
Estratto da Annalisa Sacchi, Inappropriabili. Relazioni, opere e lotte nelle arti performative in Italia (1959-1979) (Marsilio, 2024).