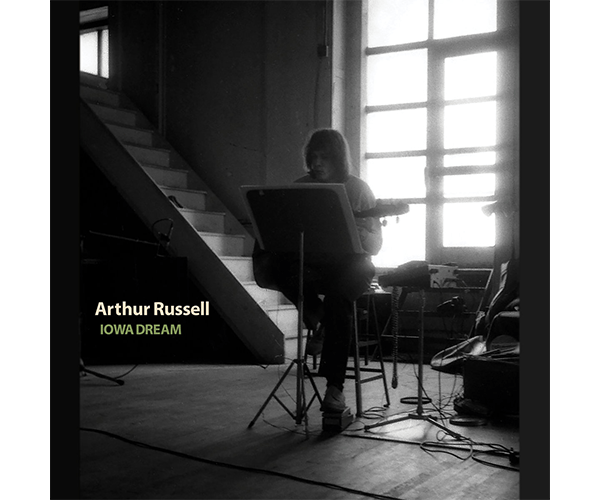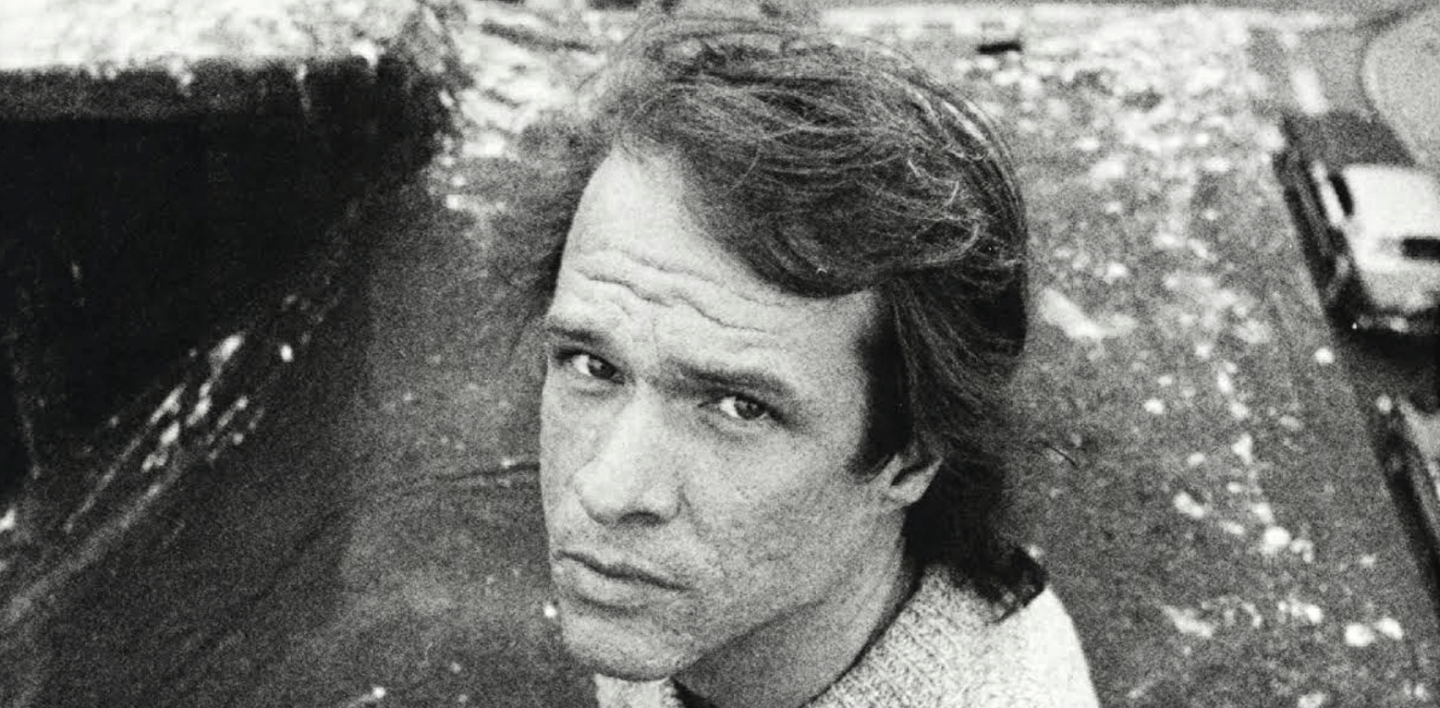
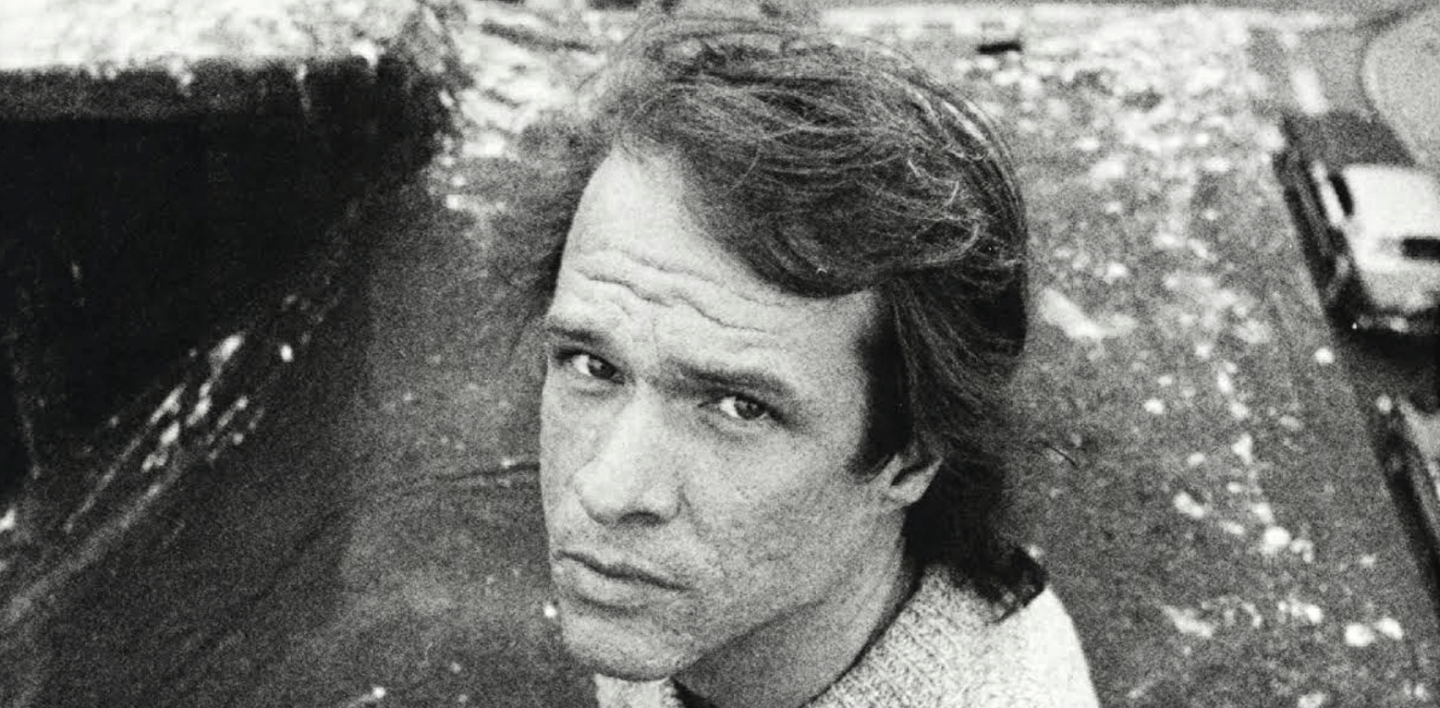
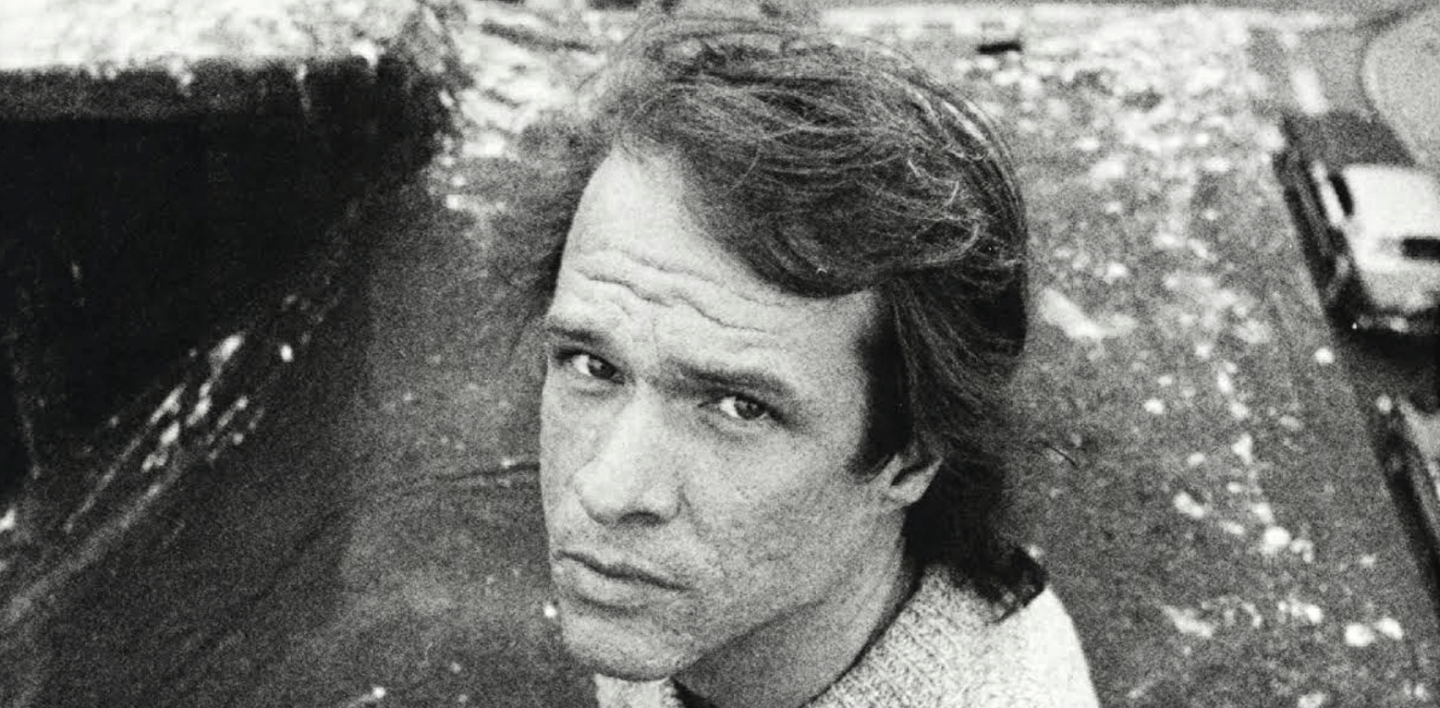
D all’ascolto di Iowa Dream, raccolta di 19 provini risalenti in larga parte a metà anni Settanta, affidati nella circostanza alla revisione di Peter Broderick, trapela un profilo da cantautore bislacco e naif: una delle molte facce nel prisma espressivo di Arthur Russell. Edito lo scorso novembre, è il sesto disco ricavato dall’archivio amministrato dall’etichetta Audika Records, creata nel 2004 da Steve Knutson proprio allo scopo di divulgare il composito linguaggio di Russell, che fu capace di anticipare il corso degli eventi musicali, intuendone gli sviluppi con impressionante perspicacia. Da allora si è riacceso l’interesse intorno alla sua figura, elevandone lo status oltre il rango del culto per pochi adepti: milioni di streaming annuali su Spotify e l’apprezzamento dei contemporanei: Frank Ocean ne è ammiratore dichiarato e Kanye West ha campionato un suo brano, Answers Me, in una traccia – 30 Hours – di Life of Pablo; tra gli adepti ci sono anche James Murphy degli LCD Soundsystem e Anohni. Di altre celebrità consta il cast dell’album di tributo Master Mix: Red Hot + Arthur Russell, uscito nel 2014: Sufjan Stevens, Devendra Banhart, Scissor Sisters, Robyn, Hot Chip, Blood Orange, Colin Stetson, Richard Reed Parry degli Arcade Fire e Glen Hansard, fra i tanti. A ciò si aggiungano il dettagliatissimo volume biografico Hold on to Your Dreams di Tim Lawrence (pubblicato in Italia da Key Note Multimedia nel 2009) e il documentario Wild Combination di Matt Wolf (in anteprima alla Berlinale del 2008). Nella primavera del 2017, poi, la Brooklyn Academy of Music ha ospitato la mostra Do What I Want: The Experimental World of Arthur Russell, basata su una selezione di reperti appartenenti all’imponente lascito (centinaia di bobine e cassette, dozzine di Dat, migliaia di pagine di appunti) acquisito l’anno prima dalla New York Public Library for the Performing Arts al Lincoln Center su mandato di chi lo aveva gestito fino a quel punto: il suo compagno Tom Lee e lo stesso Knutson.
Charles Arthur Russell, Jr. era nato il 21 maggio 1951, in una notte di luna piena (dipese forse da questo il vezzo che aveva di registrare ogni plenilunio, dopo essersi fatto tagliare i capelli), a Oskaloosa: cittadina dell’Iowa con poco più di diecimila abitanti, nel cuore del Midwest, dove il panorama è definito dai campi di mais (non a caso vocabolo ricorrente nel suo percorso creativo: dal singolo In the Corn Belt all’album Corn). Terzogenito della famiglia costituita da Charles “Chuck” Russell, assicuratore di professione e poi sindaco del paese, e la moglie Emily, violoncellista amatoriale, che trasmise al figlio la passione per lo strumento e lo spinse a esercitarsi in tenera età al pianoforte: impegno affrontato dal piccolo Arthur dimostrando di possedere un orecchio musicale fuori del comune. Di carattere timido e con il volto segnato dall’acne, bazzicando da adolescente “cattive compagnie” s’immerse quindi nell’esperienza psichedelica e prese a modello la figura di Timothy Leary, decidendo di abbandonare la scuola per trasferirsi – non ancora diciassettenne – in California, seguendo il canto delle sirene hippie di Haight Ashbury, appena prima che l’utopia del Flower Power andasse in frantumi. Là condusse inizialmente un’esistenza randagia, culminata nell’arresto con l’accusa di vagabondaggio. Posto dal giudice davanti a un bivio, anziché tornare a casa, scelse di accettare l’affidamento presso l’ashram buddista di Neville G. Pemchekov Warwick, assumendo il nome di Jigme. Fu in quel periodo che studiò la tradizione classica indiana al College Of Music istituito dal maestro bengalese Ali Akbar Khan a San Rafael, oltre a frequentare il conservatorio di San Francisco, ma soprattutto ebbe modo di conoscere – attraverso Warwick – Allen Ginsberg, di cui divenne partner artistico, accompagnandone i reading al violoncello. In cambio, il guru della Beat Generation lo portò con sé a New York nel novembre 1971, invitandolo a partecipare a una seduta di registrazione nella quale era coinvolto Bob Dylan, testimoniata dall’improvvisazione September on Jessore Road presente nel disco di inediti incluso nel cofanetto The Last Word of First Blues, uscito nel 2016.
Da quel primo contatto con New York maturò la scelta di stabilirvisi: così, dal giugno 1973, prese dimora nell’appartamento al sesto piano dell’edificio situato al 437 di East 12th Street, dove aveva residenza Ginsberg, soprannominato perciò “la casa del poeta”. Nello stesso palazzo abitava Richard Hell, futuro caposcuola del punk, e si affacciava di tanto in tanto Laurie Anderson: Russell era entrato dunque a far parte della comunità di creativi spiantati che alimentava lo straordinario laboratorio artistico della Lower East Side. Nel frattempo proseguiva il proprio percorso educativo alla Columbia University, in un corso di linguistica, e alla Manhattan School Of Music, con specializzazione in elettronica (benché il docente Charles Wuorinen giudicasse la sua composizione City Park “la cosa meno attraente che abbia mai ascoltato”). A porlo sotto la luce dei riflettori fu la responsabilità di direttore musicale a The Kitchen, covo dell’avant-garde locale, allora nella sede storica di SoHo, attribuitagli nel settembre 1974 su indicazione del suo predecessore e coinquilino Rhys Chatham, figura di rilievo assoluto nel sottobosco cittadino: rimase in carica fino all’estate successiva, mettendo in cartellone, fra gli altri, i Modern Lovers di Jonathan Richman e i neonati Talking Heads. Addirittura arrivò a un passo dall’essere reclutato da questi ultimi, che erano ancora senza Jerry Harrison: “All’inizio erano un trio e cercavano un quarto elemento. Diventammo amici, ma alla fine non entrai nella band: venivano dalla scuola d’arte e avevano un aspetto freddo e austero, non facevano per me”, raccontò in un’intervista concessa nel 1987 al settimanale inglese “Melody Maker”. David Byrne: “Arthur suonava il violoncello e apparteneva a una frangia dell’avanguardia di Downtown, eppure se ne distingueva perché aveva un debole per la musica pop. Era un grande fan degli Abba e di certa roba italiana patinata”. Unico risultato concreto: la partecipazione di Russell alla registrazione di una versione acustica di Psycho Killer, allegata nel 2006 alla riedizione dell’album d’esordio dei Talking Heads.
Era insomma un astro nascente nel firmamento newyorkese, quotato sia in ambito sperimentale (avendo suonato con John Cage a The Kitchen, unendosi come batterista alla Fast Food Band di Laurie Anderson e incantando Philip Glass, che nel 1976 gli avrebbe affidato l’esecuzione delle musiche composte per la pièce di Samuel Beckett Cascando messa in scena dalla compagnia Mabou Mines) sia sul versante pop (con Ernie Brooks, appena uscito dai Modern Lovers, aveva organizzato un gruppo chiamato Flying Hearts, ai margini del quale gravitavano i vari Peter Gordon, Rhys Chatham, Jerry Harrison e David Byrne, in seguito ribattezzato Necessaries e con quel nome intestatario di due dischi targati Sire, Big Sky ed Event Horizon, datati rispettivamente 1981 e 1982). Si era accorto di lui persino il celebre talent scout della Columbia John Hammond, che finanziò i provini registrati fra l’ottobre 1974 e il marzo 1975 insieme ai “cuori volanti”, rimasti inediti fino al 2008, quando Audika li ha raccolti nell’album Love Is Overtaking Me, rivelandone un aspetto insolitamente tradizionalista: quasi cantautore country con intonazione alla James Taylor. Lo stesso Hammond dichiarò a quei tempi: “Il giorno in cui scriveranno il mio epitaffio, diranno: ‘Ha scoperto Billie Holiday, Charlie Christian, George Benson e poi Dylan, Springsteen e Arthur Russell”, immaginandolo già star. Frattanto in città, sull’asse CBGB/Max’s Kansas City, stava germinando il punk, ma l’istinto spingeva Russell altrove: “Una notte andai in discoteca e ne fui davvero impressionato: si trattava del Gallery e il Dj era Nicky Siano”. A sua volta, quest’ultimo ne serba un ricordo curioso: “Ci prendevamo gioco di lui perché ballava in modo stranissimo”. Lo zoccolo duro del club al 172 di Mercer Street era costituito da neri omosessuali e ciò contribuì a trovare una piena consapevolezza del proprio orientamento sessuale.
Il 1986 fece da spartiacque nella vita di Arthur Russell: fu l’anno in cui risultò positivo al test dell’Hiv, ebbe la prima opportunità di realizzare a proprio nome materiale assegnato a una distribuzione su vasta scala.
L’esperienza lo stimolò a percorrere nuove strade musicali: nel 1977, con la dicitura Dinosaur, produsse insieme allo stesso Siano il singolo Kiss Me Again, primo titolo “disco” nel catalogo Sire all’inizio dell’anno seguente. Nell’edizione su 12 pollici, una cavalcata di 13 minuti abbondanti in cui si ascoltano la chitarra di David Byrne, alcuni musicisti di Gloria Gaynor e la cantante Myriam Valle: fu un best seller da circa 200mila copie, efficace persino sulla pista dello Studio 54, per mano del Dj Steve D’Acquisto. Con quest’ultimo Russell creò nel 1979 i Loose Joints: collettivo nel quale figuravano tre vocalist del Loft – il leggendario party itinerante di David Mancuso – e la sezione ritmica di Ingram Brothers e Patti LaBelle. Il nome dichiarava quanto alto fosse il tasso di Thc in quelle musiche, registrate durante interminabili sessions la cui inclinazione free form ricalcava le modalità dell’improvvisazione jazzistica. “Pensavamo di fare il White Album”, ha confessato – alludendo ai Beatles – D’Acquisto nelle note di copertina della compilation The World of Arthur Russell, pubblicata nel 2004 da Soul Jazz e contenente due dei tre brani editi all’epoca, Is It All Over My Face (nella versione remixata da Larry Levan, che la rese un classico dei suoi set al Paradise Garage, riti di passaggio verso l’house music) e Pop Your Funk. Si trattava di prototipi dell’ibrido sonoro definito successivamente mutant disco, a simboleggiare il quale fu – nel 1980 – un’esibizione allo Studio 54 di Arthur Russell con il violoncello al collo, tipo chitarra elettrica.
L’ingresso nel nuovo decennio coincise con un’altra avventura: affidando la parte gestionale all’impresario Will Socolov, Russell fondò nel 1981 l’etichetta Sleeping Bag (a lungo andare rilevantissima nelle vicende dell’hip hop dando voce a pionieri quali Mantronix, EPMD e Just-Ice), che inaugurò l’attività con l’album 24→24 Music attribuito a Dinosaur L, evoluzione dello show di “disco orchestrale” proposto due anni prima a The Kitchen, da cui derivarono i singoli Go Bang (valorizzato in particolare da un remix di François Kevorkian) e In the Corn Belt (rielaborato viceversa da Larry Levan). La relazione con la sfera dell’avanguardia non si era affatto interrotta, comunque: nell’ottobre 1980 Philip Glass gli aveva commissionato le musiche per un allestimento di Medea firmato dal regista Robert Wilson, che tuttavia – poco convinto del risultato – si rivolse infine al compositore inglese Gavin Bryars. Deluso dall’esperienza, Russell decise di allontanarsi dai circoli accademici, anche se Glass – volendosi sdebitare – pubblicò il lavoro nel 1983 con il proprio marchio discografico Chatham Square Productions, battezzandolo Tower of Meaning. Nel medesimo ambito, l’anno dopo, vide la luce grazie all’indipendente belga Another Side Instrumentals: opera presentata a The Kitchen nel 1975 e poi registrata fra il giugno 1977 e il maggio 1978 impiegando musicisti del giro Flying Hearts, che nella stesura integrale – concepita per sonorizzare le foto paesaggistiche della sua guida buddista Yuko Nonomura – durava 48 ore (se ne trovano tracce nel doppio antologico del 2006 First Thought Best Thought).
Il 1986 fece da spartiacque nella vita di Arthur Russell: fu l’anno in cui risultò positivo al test dell’Hiv, mentre sul piano artistico le crescenti divergenze con Socolov, innescate dall’ostracismo verso i vari abbozzi di Corn (suite dai vaghi accenti hip hop rappresentata parzialmente nella collezione del 2004 Calling Out of Context e infine ricostruita integralmente da Audika nel 2015), lo indussero ad abbandonare Sleeping Bag al suo destino. Ebbe tuttavia la prima opportunità di realizzare a proprio nome materiale assegnato a una distribuzione su vasta scala: il chitarrista Gary Lucas (già fedelissimo di Captain Beefheart e in futuro al fianco di Jeff Buckley) lo aveva introdotto a Geoff Travis, boss della londinese Rough Trade, che rimase affascinato dal suo estro anomalo e non esitò nel dare alle stampe il singolo Let’s Go Swimming (visionario esperimento “avant-house” nella versione remixata dall’ex Dj ed evangelista Walter Gibbons, implicato anche nel passo d’addio di Russell da Sleeping Bag con lo pseudonimo Indian Ocean, ossia il 12 pollici School Bell/Treehouse) e soprattutto l’album World of Echo. Era come se là convergessero armonicamente tutti i vettori che avevano indirizzato la sua azione creativa: dance e avanguardia, libera improvvisazione e attitudine pop, senso dello spazio sonoro (lo denuncia il titolo…) e audacia formale. Un capolavoro che suona avveniristico ancora ai giorni nostri, in virtù di una ricchezza inventiva in apparente contrasto con la pochezza dei mezzi (in fondo è musica fatta solo di voce e violoncello). La critica espresse commenti favorevoli, ma fu un fiasco. Da quel momento in poi, a causa della malattia, l’attività si diradò ma non cessò: in cantiere c’erano un disco per Point Music (edito in parte postumo nella raccolta Another Thought del 1994), il progetto elettronico 1-800-Dinosaur destinato a Rough Trade (alcuni provini del quale sono inclusi in Calling Out of Context) e la rifinitura di varie tracce, fra cui “Springfield” (resa pubblica nel 2006 con l’intervento del team DFA guidato da James Murphy). Le ultime apparizioni dal vivo, alla Knitting Factory, risalgono al 1991: l’anno precedente la sua scomparsa, avvenuta il 4 aprile 1992. In un brano del poema The Charnel Ground Allen Ginsberg scrisse nell’agosto seguente: “L’artistico compositore buddista al sesto piano giace semincosciente con i piedi gonfi in ammollo, morendo lentamente di Aids in capo a un anno”. Dopo la cremazione, le ceneri vennero sparse dai suoi cari nell’Oceano Atlantico da Baker Island, al largo della costa del Maine, dove si era recato alcuni mesi prima di morire, registrando il suono delle onde sulla roccia.
Aveva voce fragile e garbata, venata di malinconia (“Essere tristi non è un crimine”, recita un verso di “Love Comes Back”, in Love Is Overtaking Me), stile Nick Drake. Maneggiava il violoncello con dolcezza e sensualità, a volte distorcendone il timbro in chiave hendrixiana. Componeva con grafia obliqua, resa tale dall’incrocio tra le influenze assorbite (la tradizione classica indiana e l’avanguardia minimalista, la dance e l’hip hop, il jazz e il post punk: fonti alle quali si abbeverò per restituirne poi i contenuti centrifugati in forme tuttora ineffabili nella loro grazia enigmatica), e in sala di registrazione lavorava in maniera ingegnosa (l’uso insistito di echi e riverberi rimandava al dub giamaicano e anticipava i “trucchi” della house e della techno). Era di temperamento irrequieto e soffriva di perfezionismo: di “Let’s Go Swimming”, ad esempio, esistono su nastro magnetico 49 versioni differenti. “Per natura, Arthur era un bastian contrario. Se dicevi di apprezzare la sua musica, non ci credeva”, raccontava Knutson. Fu questo risvolto della sua personalità a frenarne l’efficienza produttiva: non era però banale pignoleria, riguardava bensì un’idea dell’arte come “processo” anziché oggetto statico. Chi ebbe a che farci ne ha attestato il valore con eloquenza: dall’accademia (Philip Glass: “Suonava il violoncello e ci cantava sopra in un modo che nessun altro sulla faccia della Terra aveva mai fatto prima, né rifarà mai”) alle discoteche (David Mancuso: “Era tipo Dylan e Coltrane in una persona sola”). Concepiva musica libera nel senso pieno del termine (“Bubblegum music buddista”, la chiamava Ginsberg), proprio perché – avendo mente aperta – non poneva barriere fra “alto” e “basso”. Spiegava Ernie Brooks, che gli fu accanto a lungo: “Quando suonavamo insieme, il suo obiettivo era creare musica pop trascendentale. Adorava i Fleetwood Mac e gli Abba. Pensava che il pop avesse qualcosa che mancava alla classica, qualcosa di più autentico e democratico”. Volendo, potremmo considerarlo l’equivalente musicale di ciò che ha rappresentato per l’arte figurativa Keith Haring, a lui accomunato da un percorso biografico al tempo stesso elettrizzante e tragico. Intervistato nel marzo 1977 dal foglio settimanale SoHo Weekly News, a un certo punto aveva affermato: “Se usi male le tue doti di musicista, usi male le tue doti di essere umano e spingi l’umanità nella direzione sbagliata”.