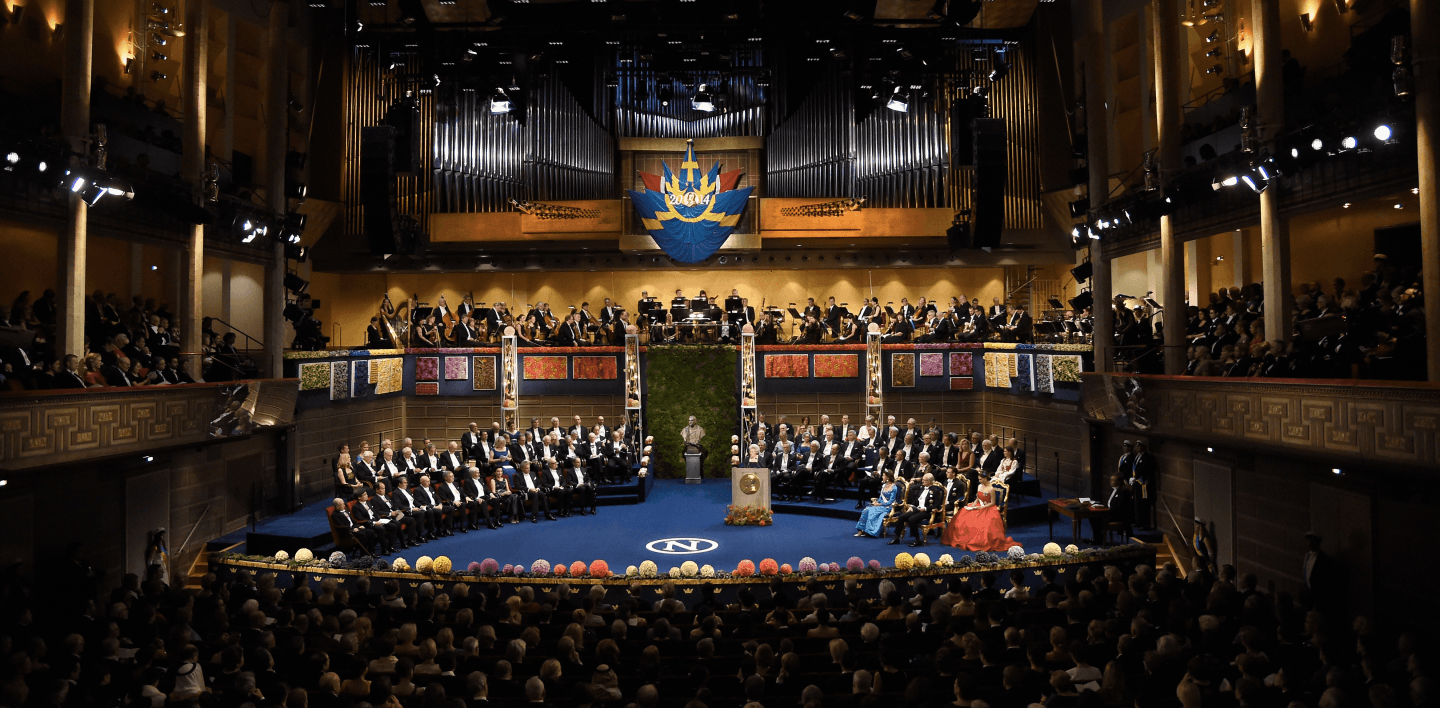
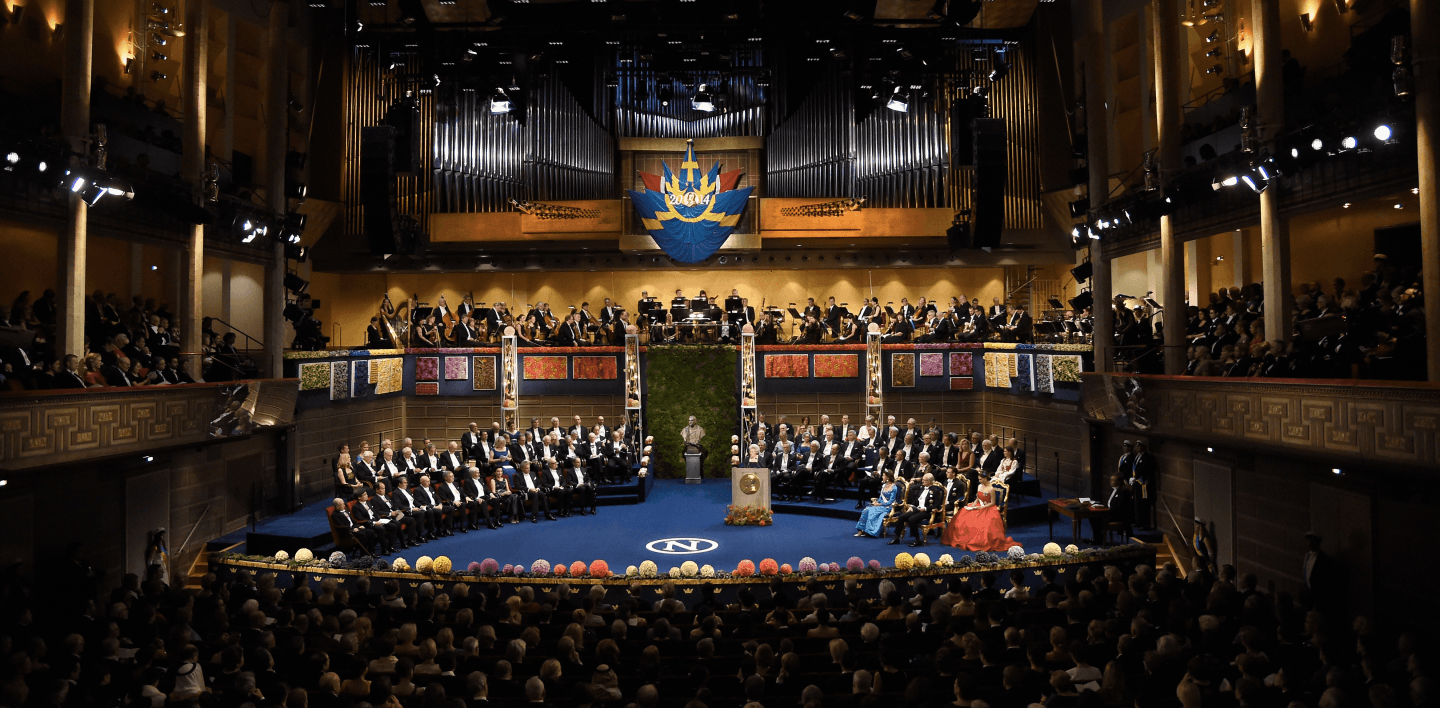
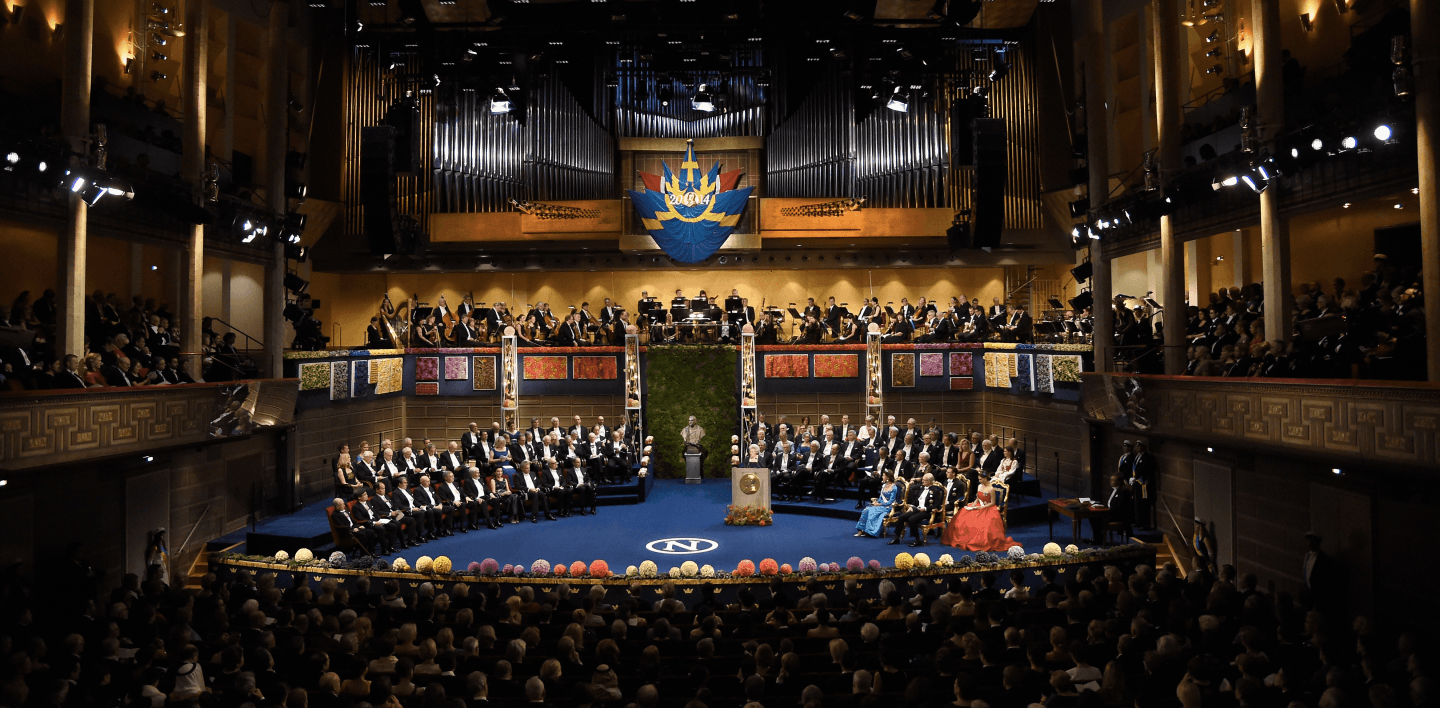
La decisione di assegnare il premio Nobel per la Letteratura 2016 a un cantautore ha suscitato numerose riserve, perplessità e critiche vere e proprie, che nella loro grande maggioranza si basano su una obiezione di metodo (“la letteratura è un’altra cosa”): piuttosto che soffermarsi su di esse, vogliamo analizzare gli argomenti di quegli scrittori e intellettuali che invece hanno salutato con entusiasmo – o comunque con favore – la scelta dei giurati, considerandola quindi pienamente legittima.
Tra le voci più autorevoli si è segnalata quella di Claudio Giunta, che sul Domenicale del 16 ottobre ha proposto un confronto con alcune forme letterarie considerate in passato alla stregua di generi minori: “C’è stato un tempo in cui un autore di sonetti non avrebbe vinto il Nobel, perché i sonetti erano considerati nugae; e c’è stato un tempo in cui non lo avrebbe vinto un romanziere, perché i romanzi venivano liquidati come roba per signorine”. Ora, non saprei dire quanto realmente Petrarca considerasse davvero ‘cose di poco conto’ i Rerum vulgarium fragmenta, alla cui stesura e revisione dedicò decenni di lavoro; ma è indubbio che i romanzi sono stati a lungo considerati un genere-spazzatura, come si direbbe oggi. E come non citare a questo punto Donald Sassoon quando mette in parallelo (e in ridicolo) le preoccupazioni pedagogiche vecchie e nuove:
al giorno d’oggi genitori e insegnanti piangono lacrime di gioia se un bambino preferisce i romanzi alla televisione o ai videogiochi; all’inizio dell’Ottocento, invece, molti letterati guardavano con preoccupazione alla crescente passione per i romanzi nelle famiglie borghesi, temendone i possibili effetti sui soggetti più ‘impressionabili’, cioè donne e bambini’’.
Il confronto tuttavia non è pertinente, perché la questione di metodo (o di principio, se si preferisce) sollevata in relazione al caso-Dylan non riguarda una forma o un genere considerati quanto si vuole minori o marginali, ma dei quali nessuno potrebbe mai negare che essi facciano comunque parte del sistema letterario: un po’ come, nella disputa tra musica classica e musica cosiddetta leggera, nessun partigiano della prima si spingerebbe ad affermare – se non per iperbole – che la seconda “non è musica”. Il caso in questione è evidentemente diverso: il punto è se una forma artistica nella quale la componente musicale – o una qualunque altra componente non testuale – è inscindibile dalla componente testuale, e nella quale quindi quest’ultima non è autonoma, sia o meno assimilabile alla letteratura in senso stretto. A questo Giunta non risponde, anzi quanto scrive subito dopo (“la sola carta non basterebbe a contenere l’invettiva di Like a Rolling Stone, o l’inno di Chimes of Freedom, o il sogno medievale di All Along the Watchtower. Se non sai metterli in musica, non li puoi dire”) sembrerebbe confermare indirettamente tale obiezione.
Se Dylan invece di cantare le sue canzoni ne avesse pubblicato il testo in forma di poesia, oggi sarebbe considerato uno dei massimi poeti viventi a livello mondiale?
Eppure – si dirà ed è stato detto, con una sorta di excusatio non petita, dalla stessa Accademia svedese per voce del segretario permanente Sara Danius – anche Omero e Saffo “scrissero testi che dovevano essere interpretati o ascoltati […] con l’accompagnamento di strumenti musicali”. Ma anche questo è un confronto poco pertinente, dal momento che all’epoca dei poemi omerici e dei lirici greci non esisteva ancora quella che per noi è la “letteratura”, e che nasce – nella forma nella quale noi la conosciamo (e semplificando molto una questione che è in realtà assai più complessa) – nel periodo alessandrino, quando – non a caso – anche alle opere di Omero e degli altri autori arcaici viene data forma propriamente editoriale; ed è in questa fase che esse, ormai definitivamente slegate dall’occasione e dalle originarie modalità di esecuzione, divengono opere letterarie, per così dire, autonome, lette per i loro valori propriamente ed esclusivamente testuali. Come ha scritto Marco Grimaldi su Le parole e le cose a proposito del confronto con i testi scenici, “è un dato di fatto che moltissime persone leggono il teatro invece di assistere agli spettacoli. […] Non è tanto importante che la destinazione ideale del testo di Amleto sia la scena; è più importante che finora molte generazioni, e non solo di parlanti inglesi, abbiano letto Shakespeare ben prima di vederlo rappresentato”.
È ragionevole pensare che questo non avverrà mai per le opere dei cantautori, stante l’evoluzione tecnologica: perché mai qualcuno dovrebbe volersi limitare a leggere il testo di una canzone, quando può ascoltarla con un clic? Ma in linea di principio – non sarebbe forse incongruo chiedersi – sarebbe potuto avvenire? In altri termini: se Dylan invece di cantare le sue canzoni ne avesse pubblicato il testo in forma di poesia, oggi sarebbe considerato uno dei massimi poeti viventi a livello mondiale? Al di là della formulazione paradossale, questa sembra essere, a prima vista, la domanda decisiva, ed è una domanda alla quale molti hanno provato a rispondere in un senso o nell’altro.
Di chiarezza esemplare, da tale punto di vista, è la posizione espressa da Giulia Cavaliere in un articolo uscito il 14 ottobre sul Tascabile: “non esiste un modo per incontrare, conoscere e dunque amare Bob Dylan che non sia entrare nelle sue parole, dimenticare per un po’ i suoi dischi e le sue voci […]. Per nessun musicista come per Bob Dylan la musica potrebbe essere lasciata – anche solo per poco – da parte, per nessuno di loro come per lui vale questa eccezione quasi assurda alla regola”. Il problema però è che l’eccezione può essere giustificata esclusivamente dalla qualità dei testi (“non serve la voce per convincerci che sia poesia”): ma questo è già, ad ogni evidenza, un giudizio di valore, mentre quella sul tavolo è una questione di metodo, che non si può eludere facendo ricorso a una versione aggiornata della vecchia, comoda distinzione crociana tra “poesia” e “non poesia”.
E allora la vera domanda da porsi è: quale idea di letteratura presuppone la scelta di assegnare il Nobel a un cantautore? È un’idea legittima? È un’idea condivisibile? Semplificando molto, appare evidente che la concezione della letteratura presupposta da tale scelta è quella per la quale qualsiasi testo è – potenzialmente – letterario: un romanzo, una poesia, un saggio, un testo teatrale, una canzone, una sceneggiatura cinematografica, ma anche un fumetto, un articolo di giornale, una réclame, persino il post del vostro amico che avete appena letto su Facebook. Ciò che fa la differenza può essere individuato, di volta in volta, nel valore estetico: assai impropriamente, come si è detto, perché – per citare Francesco Orlando (Per una teoria freudiana della letteratura) – “la qualificazione come letteratura o no è una cosa e quella come buona o cattiva letteratura è un’altra cosa” (sebbene sia verosimilmente proprio così che devono aver ragionato i giurati del Nobel); nel grado di elaborazione formale (o, sempre con Orlando, nel “tasso di figuralità”), sebbene sia un criterio piuttosto scivoloso (dove sarebbe da collocare la soglia tra il massimo grado di elaborazione o di figuralità che può avere un testo senza essere letterario e il minimo che deve avere per esserlo?); o ancora su base empirica (“è letteratura ciò che ciascuna epoca considera tale”).
L’apparente possibilità di un accesso autonomo alle informazioni e alle conoscenze sta generando l’illusione di poter fare a meno di quelle figure e di quelle strutture che hanno la funzione di garantire, nei diversi ambiti, la correttezza o fondatezza delle stesse.
Una simile concezione della letteratura è perfettamente legittima (sospetto anzi che sia oggi largamente prevalente anche tra gli studiosi), ma non è l’unica: è infatti possibile individuare un testo letterario anche, in alternativa, in base alla sua funzione; recentemente, ad esempio, Guido Paduano (Il testo e il mondo) ha proposto la seguente definizione: “sono letterari i testi che nei confronti del destinatario avanzano la pretesa di toglierlo […] dalla vita quotidiana per inserirlo in una dimensione esistenziale alternativa, costituita in forma autosufficiente dalla letteratura medesima” (corsivo mio). È evidente che, se si accoglie tale definizione o se comunque si accetta una prospettiva teorica di questo tipo, il campo si restringe di molto: un romanzo e una poesia sarebbero senz’altro letteratura, un post su Facebook o una canzone – per ragioni diverse – no.
Detto questo, è chiaro che basta intendersi: a patto che siano esplicitate e applicate in modo coerente, tutte le definizioni di letteratura che non siano palesemente irragionevoli sono di per sé legittime; ed è per questo che non mi pare che si debba gridare allo scandalo per un premio letterario assegnato a un cantautore. E tuttavia, se è vero che ogni concezione della letteratura è legittima, ciò non significa che non ci si possa anche interrogare, allo stesso tempo, su ciò che essa significhi in una prospettiva più ampia e su come essa agisca nel contesto culturale e sociale dal quale è prodotta e che contribuisce a sua volta a definire.
Una delle principali e più controverse questioni alle quali ci pone di fronte l’avvento della società digitale è quella della possibile fine di ogni intermediazione: un fenomeno del quale si è parlato in relazione alle dinamiche della partecipazione politica e a quelle dell’informazione giornalistica, ma che non è meno cruciale nell’ambito della conoscenza e della cultura. L’apparente possibilità di un accesso autonomo alle informazioni e alle conoscenze sta generando l’illusione di poter fare a meno di quelle figure e di quelle strutture che hanno la funzione di garantire, nei diversi ambiti, la correttezza o fondatezza delle stesse: sulla base del presupposto che – dato un qualunque argomento – l’opinione del primo che passa per strada ha lo stesso valore di quella di chi magari ha dedicato un’intera vita a studiare quell’argomento (non è un paradosso: qualche mese fa il servizio pubblico televisivo ha incredibilmente posto a confronto, sul tema dei vaccini, un medico e un deejay!); e con la conseguenza di una deriva che molti definirebbero (non a torto) populista o anti-intellettualistica, ma che personalmente preferirei descrivere più semplicemente come regressione a una forma di pensiero adolescenziale: quella che l’individuo in genere supera nel momento in cui, apprendendo un mestiere o una disciplina, comprende che esistono metodi e protocolli per mezzo dei quali è possibile distinguere ciò che è fondato da un punto di vista epistemologico da ciò che non lo è; che esistono competenze nei diversi ambiti e settori; che un deejay non è un medico e che un cantautore potrà essere un artista di eccezionale valore, ma è qualche cosa di diverso da un romanziere o da un poeta.