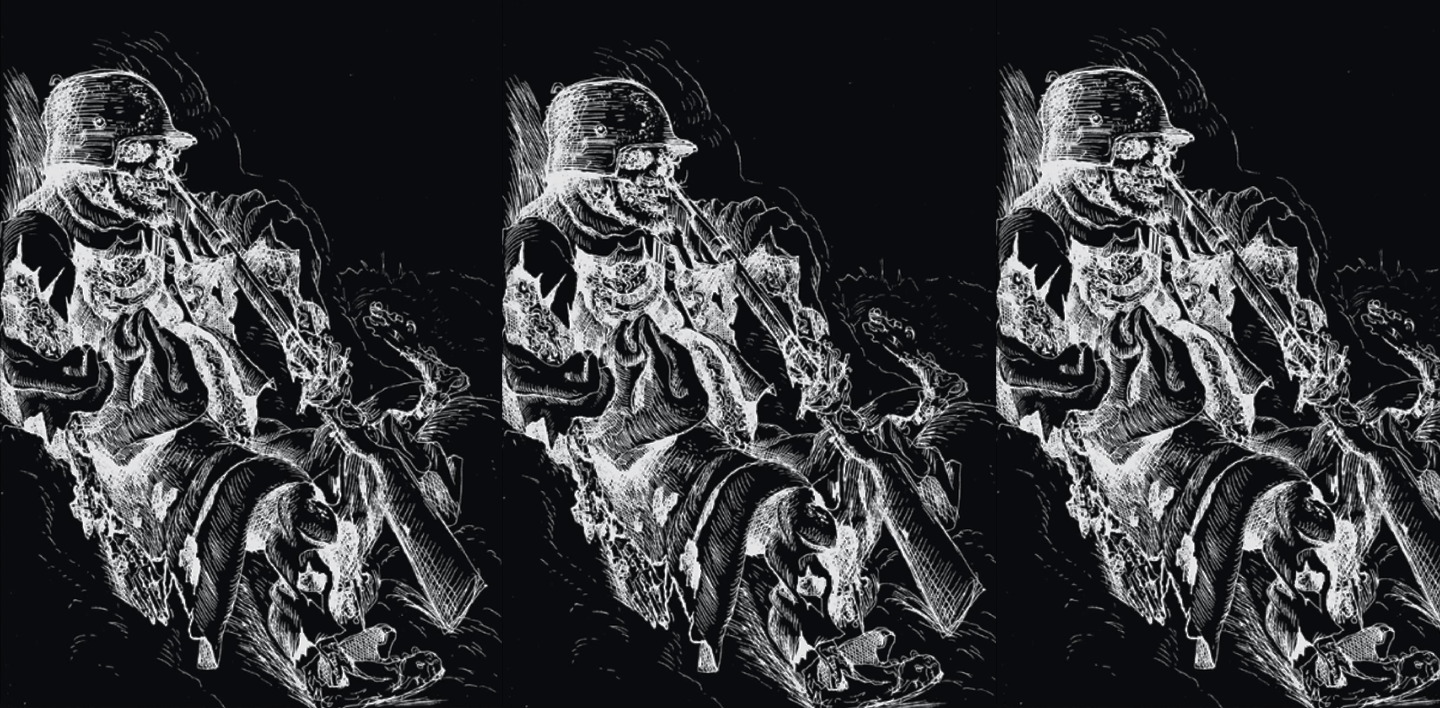
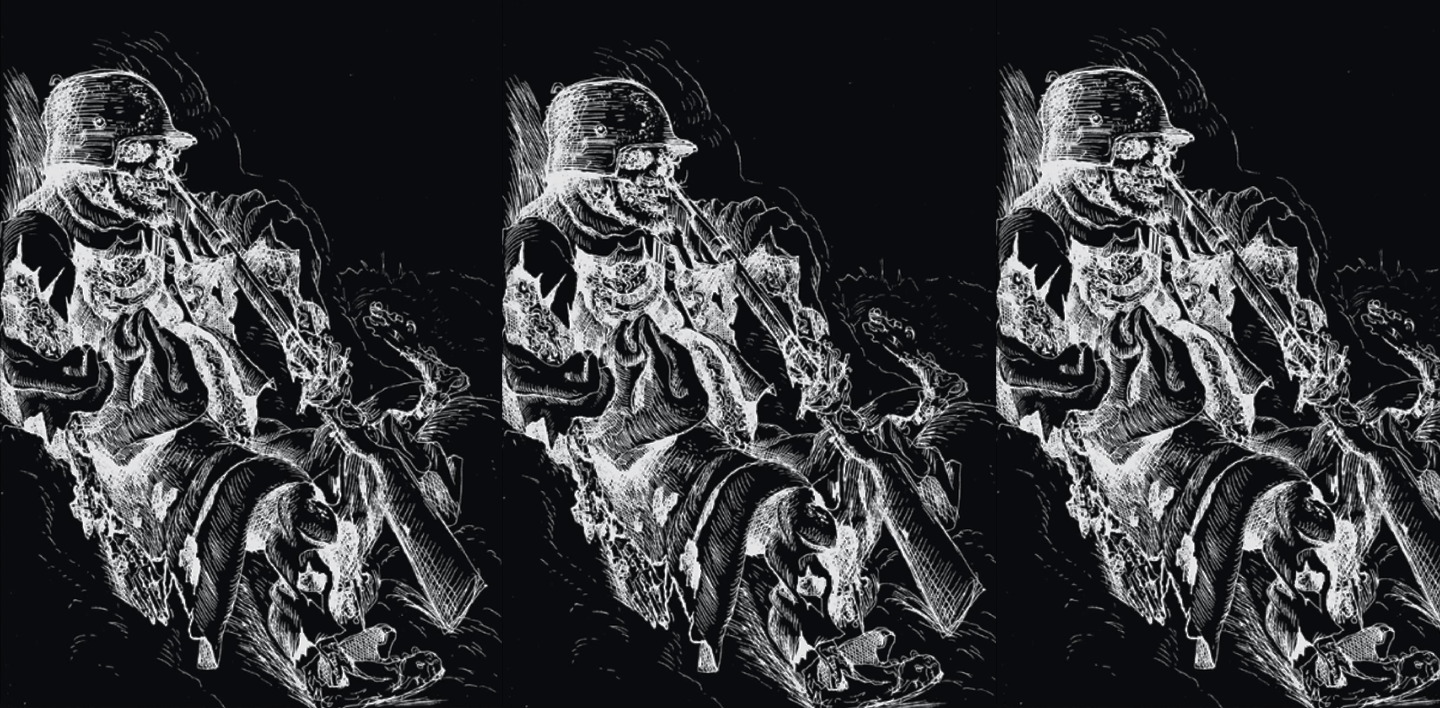
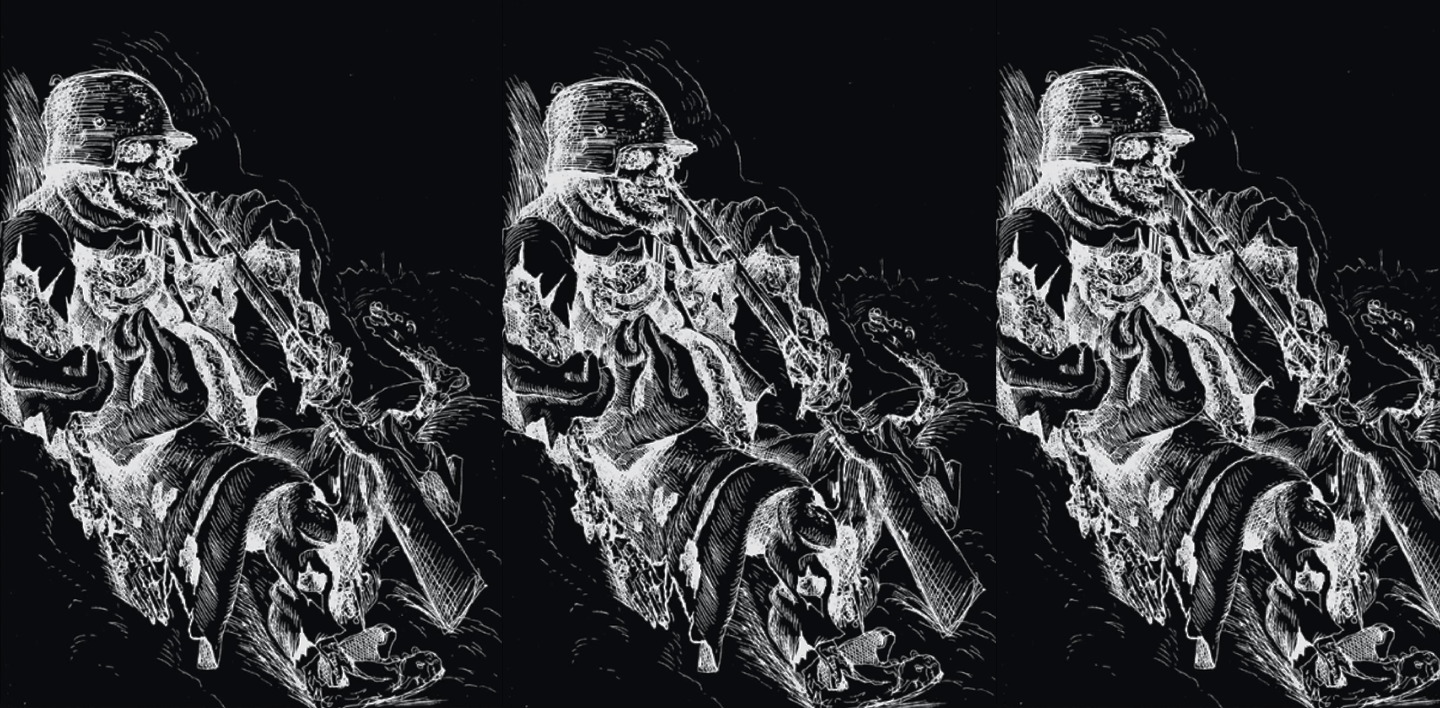
A volte scompaiono intere biblioteche. I diari di Byron furono gettati nel camino dell’ufficio di John Murray, il suo editore, il 17 maggio 1824, non molto tempo dopo la morte del poeta. Le carte di Cristina Campo, contenenti chissà quali dolcezze, finirono dentro un cassonetto. Altre volte, invece, per quanto infinitamente più di rado, le biblioteche perdute riemergono dalle cantine. Com’è accaduto alle migliaia di pagine inedite di Louis-Ferdinand Céline ricomparse sessant’anni dopo la sua morte.
La stesura dell’epico racconto medievale La volonté du Roi Krogold, citato nelle pagine più allucinate di Morte a credito; importanti integrazioni di Casse-pipe; i duecentocinquanta fogli manoscritti di Guerre, che l’autore avrebbe voluto dare alle stampe con Londres, anch’esso ritrovato, ed Enfance: di questi testi, fino a poco tempo fa accomunati all’Arca dell’Alleanza, ai canti di Saffo e al tesoro di Montezuma, è oggi in corso la pubblicazione presso Gallimard e, in Italia, per Adelphi. Guerra, nella traduzione di Ottavio Fatica, è il primo della serie. Un evento pressoché senza precedenti nella storia letteraria.
Anche perché l’ormai arcinota vicenda della loro scomparsa e del ritrovamento già di per sé appartiene all’ordine della letteratura ben più che alla realtà, per l’usuale assai più scialba. Autore di tre famigerati pamphlet antisemiti, Céline si diede alla fuga il 17 giugno 1944 insieme alla moglie, Lucette Almansor, e al loro gatto Bébert. Si lasciava alle spalle, nell’appartamento di Montmartre, pagine e pagine di manoscritti, poi trafugati con ogni probabilità dai combattenti della Liberazione, e se ne persero le tracce. Vennero dati per irrecuperabili, perduti per sempre, quasi certamente distrutti. Lo stesso Céline, fino alla fine, ne pianse la scomparsa.
Era stato il prezzo da pagare, si direbbe, per restare in vita, come un sacrificio, un alleggerimento. Basti pensare a cosa accadeva, negli stessi anni, agli altri scrittori che, ciascuno in modo diverso e per motivi differenti, avevano collaborato, sostenuto o ben accolto il regime d’occupazione. Il dandy Pierre Drieu La Rochelle, rivoluzionario e reazionario come tutti i dandy, si diede la morte il 15 marzo 1945 aprendo i tubi del gas e ingerendo, per precauzione, una massiccia dose di gardenal: aveva letto sul giornale del mandato di comparizione emesso contro di lui. Robert Brasillach, a cui De Gaulle rifiutò la grazia, fu l’unico scrittore collaborazionista che subì la pena capitale. Era stato condannato a morte anche Lucien Rebatet, al quale furono sequestrati i beni, ma la pena fu commutata nei lavori forzati. A Sigmaringen, dov’era fuggito con il governo di Vichy (e lo stesso Céline), aveva iniziato il suo capolavoro, Les deux étendards, punito con la damnatio memoriae ancor prima di essere concluso.
Non molto tempo dopo la morte di Lucette nel novembre del 2019, il giornalista Jean-Pierre Thibaudet ha rivelato di essere entrato in possesso, una quindicina di anni prima, delle carte perdute di Céline.
Maurice Sachs, maestro d’ogni abiezione, che aveva lavorato come spia per la Gestapo infiltrandosi negli ambienti antinazisti e omosessuali parigini, morì il terzo giorno di marcia forzata verso Kiel, quando un ufficiale delle SS decise che era diventato un peso inutile. Di lui sarebbe rimasta la leggenda nera di “Maurice la Tante” ucciso a mani nude dai compagni di prigionia a Fuhlsbüttel (dov’era stato rinchiuso dai Tedeschi, stanchi della sua proverbiale inaffidabilità) a cui aveva estorto informazioni e confidenze prontamente girate ai secondini. Il suo cadavere, si sarebbe a lungo raccontato, era stato dato in pasto ai cani. In confronto, la fuga in Germania, l’esilio danese, il ritorno in Francia nell’infamia, la solitudine e la miseria di Céline sono forse un destino preferibile.
Il resto della storia, in ogni caso, già appartiene al mito. Non molto tempo dopo la morte di Lucette nel novembre del 2019, quando aveva 107 anni, il giornalista Jean-Pierre Thibaudet ha rivelato di essere entrato in possesso, una quindicina di anni prima, delle carte perdute di Céline, dono di qualcuno che, in cambio, chiedeva di restare nell’anonimato e che i manoscritti rimanessero un segreto fino alla morte della vedova Destouches. Il donatore le aveva tenute in cantina per anni senza sapere cosa farne, forse senza comprenderne il valore. Doveva aver compreso, tuttavia, l’eccezionalità di ciò che ne sarebbe scaturito.
Guerra, nello specifico, è importante per diverse ragioni. Innanzitutto, è un romanzo dedicato a quella ferita alla testa che Céline lamentò tutta la vita, e che diceva di aver ricevuto in guerra il 27 ottobre del 1914 a Poelkapelle, nelle Fiandre occidentali. Soffriva infatti di nevralgie e insostenibili acufeni, talvolta sfocianti in vere e proprie allucinazioni uditive, che lui stesso autodiagnosticò come intrattabili, con tutta l’irrevocabilità dell’addetto ai lavori (era medico e campione di quel “nichilismo medico in letteratura”, e non solo, a cui Walter Benjamin riconduceva anche Jung e Gottfried Benn e al quale avrebbe voluto dedicare una conferenza).
Più che raccontare la guerra in sé, queste pagine dal titolo parzialmente fuorviante, che si muovono fra il racconto di fantasia e il resoconto, tracciano il corso di una degenza e un’impossibile convalescenza, in parallelo con la biografia dell’autore. Il quale realmente aveva riportato una grave ferita al braccio (quella al cranio non fu mai appurata) dopo essersi offerto volontario per consegnare un ordine tra un reggimento di fanteria e la sua brigata sotto l’incessante fuoco nemico. Dopo quest’episodio, che pure gli valse onori, croci e medaglie militari, l’idea stessa della guerra rimase per lui il più grande dei terrori: “In me ho mille pagine di incubi di riserva”, scrisse a Joseph Garcin nel 1930, “prima di tutti naturalmente quello della guerra”. Questo testo che si pensava perduto porta, attraverso la prospettiva del ferito di guerra, dritti “in quella melassa piena di granate che passavano fischiando, in tutto il rumore che hanno voluto fare, […] cioè insomma nell’orrore”.
Più che raccontare la guerra in sé, queste pagine tracciano il corso di una degenza e un’impossibile convalescenza, in parallelo con la biografia dell’autore.
Scegliendo di raccontare, di tutto l’orrore, proprio quest’episodio, Guerra riempie altresì un buco fra Morte a credito e il Voyage. Nel suo secondo romanzo, dopo la serie di esilaranti disavventure in cui il protagonista, il solito, picaresco Ferdinand, passa dalle cure di una coppia a quella successiva ossia da un fallimento all’altro – i suoi genitori e la vita di bottega nel Passage des Bérésinas (il Passage Choiseul), i Gorloge e i loro orridi gioielli, il collegio di Mr e Mrs Merrywin, fino a Courtial des Pereires e sua moglie Irène –, lo zio Édouard, unica figura luminosa per centinaia di pagine, lo avverte infine che ben di peggio è in arrivo, mentre il protagonista scalpita per arruolarsi. Era la guerra che stendeva la sua ombra sulle ultime pagine, e non per nulla: vi sarebbero morti otto milioni e mezzo di soldati in tutto simili al giovane Destouches. La sua generazione, quella nata negli ultimi anni del XIX secolo, ne sarebbe uscita decimata, e i sopravvissuti in stato di trauma permanente. Basti pensare alle prime pagine del Voyage, che sugli orrori della guerra restano tuttora insuperate. Dai budelli di Parigi – i Passages senz’aria né luce naturale, contaminati dal gas delle lampade, dai fumi della loro combustione, dal piscio dei cani – a quelli della storia: le trincee.
Nonostante la sostanziale coincidenza tra il suo esordio letterario e Guerra, quest’ultimo non è però da intendersi come un esubero o un’appendice del Voyage. La perizia filologica permette infatti di datarlo al periodo successivo alla sua pubblicazione, conferendogli perciò un’autonomia letteraria in quanto romanzo non sulla guerra, come si diceva, ma ai margini della guerra. La guerra del titolo non è quella reale, sulla quale, come scriveva nel Voyage (la traduzione è di Ernesto Ferrero), “È difficile arrivare all’essenziale”, perché “la fantasia resiste a lungo”. Dopo le prime pagine, presumibilmente incomplete, gli scontri bellici restano perlopiù sullo sfondo, giungendo piuttosto a disturbare e inquietare come rumore costante, Leitmotiv: è la guerra chiusa in testa nel ritornello dell’acufene, nel trauma disumanizzante. Il centro del racconto si rivela così – appunto – la ferita alla testa, e la distorsione percettiva che ne risulta.
Del periodo in clinica per disintossicarsi dall’oppio, Jean Cocteau ricordava i complimenti di un medico che gli confessava di non aver mai incontrato un paziente altrettanto capace a raccontare i propri sintomi. Céline qui è invece diagnosta e malato al tempo stesso: un terapeuta che non può guarire se stesso – né, stando a quel che leggiamo nel Voyage e in Morte a credito, la maggior parte dei suoi assistiti insolventi. La ferita e la malattia sono allora la condizione indelebile, costante e logorante dell’essere umano: questa è la consapevolezza maturata, ancor prima che in una capanna del Camerun alle prese con la malaria o praticando la medicina fra gli indigenti dei sobborghi, proprio nel rapporto con la madre Marguerite (nel romanzo Célestine o Clémence), orridamente claudicante per via di una gamba atrofizzata, possibile conseguenza della polio, così come sul letto dell’ospedale militare in attesa che si decida sul suo conto, nel terrore di dover tornare al fronte, mentre tutt’attorno “non facevano altro che andare e uscire, per la terra o per il cielo”, chi prima, chi dopo, indifferentemente. E dalla malattia al delirio il passo è breve, per chi “è appena separato dalla morte da tre pellicine di vita tremante”.
“Ho sempre dormito così nel rumore atroce del dicembre del ’14. Mi sono beccato la guerra nella testa. Ce l’ho chiusa nella testa”, scrive Céline nelle prime righe dell’inedito, dando voce al suo alter ego. La pallottola conficcata nel cranio di Ferdinand non è solo letterale: è la guerra in sé, sub specie aeternitatis. E insegna “a fare musica, sonno, perdono e, come vedete, anche bella letteratura, con piccoli tocchi strappati al rumore che non finirà mai più”.
È un romanzo che la guerra la avversa dal profondo, e la mostra senza imposture: un incubo, un errore a cui sottrarsi.
E infatti Guerra è anche un’opportunità per gettare uno sguardo privilegiato sul laboratorio di letteratura dell’autore: come spiega Fatica nella nota conclusiva, se i romanzi pubblicati nascevano da “diverse riscritture, mirate al perfezionamento di ogni pagina, ogni frase, ogni parola”, questo è invece “una prima stesura di getto” in “stato non rifinito”. Ma non significa che manchi la bellezza, anzi. Un’eccitazione morbosa, quale può esistere soltanto nell’irrefrenabile esuberanza vitale che si ha a un passo dalla morte, anima il racconto. In attesa di sapere dal tribunale militare quando dovrà pagare il proprio debito con la morte, e preso nel frattempo dalla voglia di vagabondare, di schernire, di esagerare, di ridere a crepapelle, di fare l’amore, di sentirsi vivo, Ferdinand, personaggio di carattere quale pochi altri nella letteratura del Novecento, vaga sfidando la sorte con quel po’ di furberia che gli rimane dalle febbri e con l’istinto di sopravvivenza (l’unico che “non inganna”) in un carnevale di infermiere perverse, medici incapaci, prostitute senza scrupoli, disertori attaccabrighe e vomitevoli soldati, il tutto condito dalla consueta “visionarietà allucinata” (così Fatica) di Céline.
Infine, è un romanzo che la guerra la avversa dal profondo. E la mostra, quando lo fa, senza imposture: è un incubo, e poi, se si è fortunati a sufficienza da sopravviverle abbastanza a lungo, un errore a cui sottrarsi, un’atrocità da cui scappare con ogni menzogna, sotterfugio o escamotage. Quando, per esemplificare l’asfissiante mediocrità piccoloborghese dei genitori, Céline vuole che il padre di Ferdinand si complimenti con lui per la sua temerarietà, non manca altresì di commentare, in merito al coraggio: “Non sapeva cos’era, e manco io”. È difficile non pensare alle straordinarie pagine analoghe del Voyage in cui Ferdinand scopre – o meglio riscopre – “un gran gusto per tutte le cose che mi allontanavano dalla guerra”. Lì era Lola, amante favolosa ma patriota a spese degli altri, a rinfacciargli di essere un vigliacco o alla meglio un pazzo per aver paura di tornare a combattere, per rifiutare il dovere e la patria col suo pervicace rifiutare innanzitutto la guerra. E Ferdinand, moderno Archiloco, rispondeva:
La rifiuto recisamente, con tutti gli uomini che contiene, voglio averci niente a che fare con loro, con lei. Fossero anche novecentonovantacinque milioni e io solo, sarebbero loro che hanno torto, Lola, e io che ho ragione, perché sono il solo a sapere quel che voglio: non voglio più morire. […] Allora vivano i pazzi e i vigliacchi! O piuttosto sopravvivano i pazzi e i vigliacchi! Ti ricordi un solo nome, per esempio, di uno dei soldati ammazzati nella guerra dei Cent’Anni?… Hai mai cercato di conoscere uno solo di quei nomi?… […] Ti sono altrettanto anonimi, indifferenti e sconosciuti quanto l’ultimo atomo di questo fermacarte davanti a noi, quanto la tua cacca mattutina… Vedi allora che sono morti per niente, Lola! Per assolutamente niente di niente, ’sti cretini! Te lo dico io! […] Non c’è che la vita che conta. Fra diecimila anni, ci scommetto che questa guerra, per quanto sublime ci sembri adesso, sarà completamente dimenticata…
Basterebbero pagine come queste su “quello schifo di avventura” che è la guerra, e che nel romanzo che ha questo nome si inseguono, per avere l’incontrovertibile conferma dell’importanza di Céline, anche – e specialmente – in questo momento.