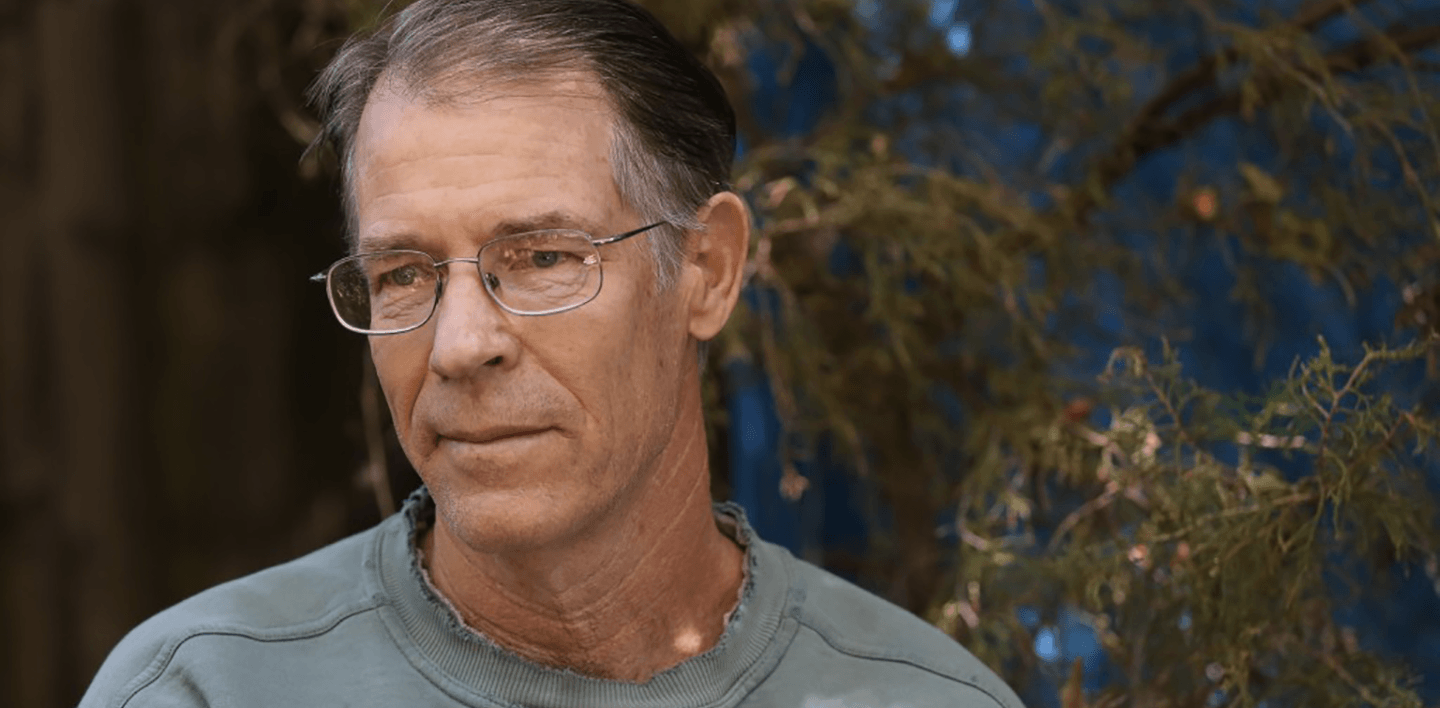
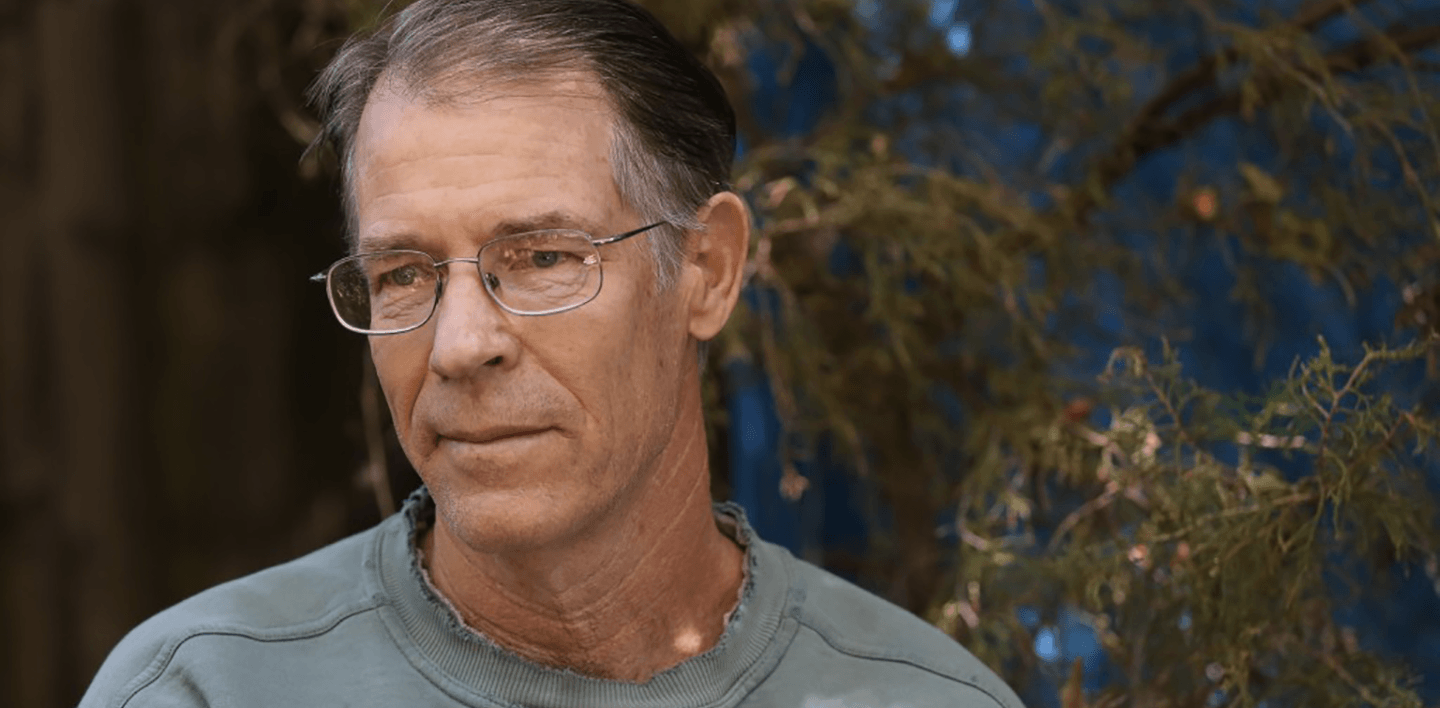
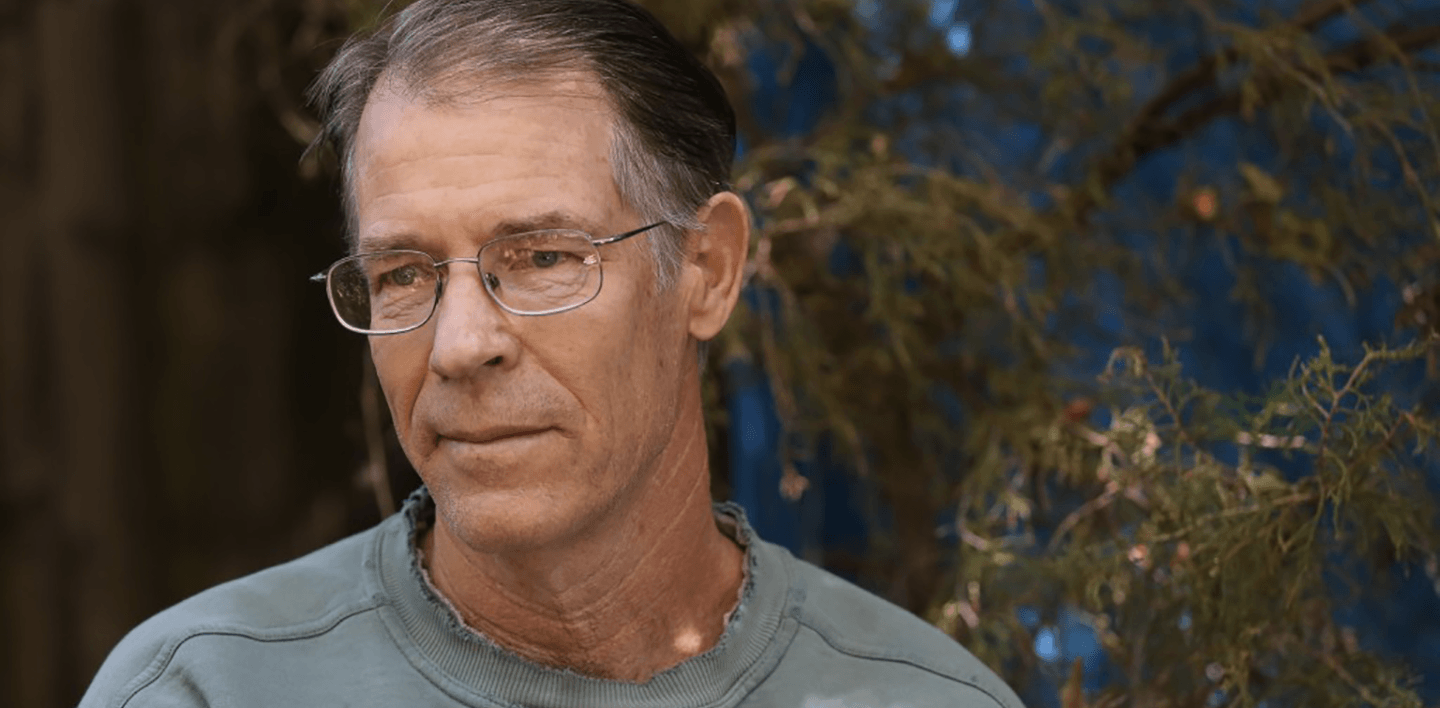
A utore ad oggi di venti romanzi e di diverse decine di racconti riuniti in cinque antologie (più una raccolta della sua migliore narrativa breve), insignito di prestigiosi riconoscimenti internazionali (tra cui i premi attribuiti alle eccellenze del settore: due Hugo, tre Nebula, sei Locus e un World Fantasy Award), conferenziere brillante, Kim Stanley Robinson è stato tradotto in ben 24 lingue, ma l’Italia non è mai stata generosa nei suoi confronti.
Prima che tra il 2016 e il 2017 approdassero in libreria, per i tipi di Fanucci, i tre poderosi volumi della trilogia marziana, caposaldo della fantascienza degli anni ‘90, della sua vasta produzione i lettori italiani avevano potuto apprezzare a malapena cinque romanzi e una manciata di racconti, sparsi tra riviste e antologie. La trilogia marziana è un buon inizio per promuovere la scoperta di un autore imprescindibile, in grado di spaziare con personalità dalla fantascienza al fantastico, dall’avventura al thriller politico, e di esprimersi nei più diversi filoni del genere: nel romanzo catastrofico come in quello utopico, nella distopia cyberpunk e nella space opera, fino all’ucronia, al planetary romance e alla hard science fiction.
Il rosso di Marte (Red Mars, 1993), Il verde di Marte (Green Mars (1994) e Il blu di Marte (Blue Mars, 1996) rappresentano il miglior biglietto da visita possibile, un affresco all’altezza di pietre miliari come la Fondazione di Isaac Asimov o la saga di Dune di Frank Herbert.
I personaggi, terrestri approdati su Marte nel corso della più grande impresa di colonizzazione della storia – i primi cento della missione scientifica originaria, i pionieri che si aggiungono a loro nei decenni successivi – e i loro discendenti, affrontano le contraddizioni della nostra società ciascuno a modo proprio: chi sostenendo lo slancio utopico di ideali socialisti resuscitati dalla bara della storia, chi portando avanti una lotta “democratica” per riformare l’economia di mercato in maniera graduale, chi opponendo la violenza della reazione armata alla forza bruta dello sfruttamento capitalista. Il processo non è indolore e nella discordanza dei percorsi immaginati per raggiungere il comune obiettivo finale il suolo marziano finisce inesorabilmente per macchiarsi di sangue. Le guerre per l’indipendenza assumeranno progressivamente i tratti di una rivoluzione contro i conglomerati multinazionali (anzi, per usare le parole di Robinson, “metanazionali”), per poi addirittura rasentare il cupio dissolvi della guerra civile. Passaggi dolorosi ma necessari alla fondazione di una società migliore di quella che sulla Terra non ha saputo prevenire il collasso ambientale, i conflitti armati per il controllo delle risorse in via di esaurimento e le stragi di milioni di civili inermi. Il critico e americanista Salvatore Proietti, al riguardo, ha scritto:
Come per l’America e come per la fantascienza, anche il Marte di Robinson è mosso da un sogno (“areofania”) di salvezza in un luogo da costruire dal nulla o almeno dall’immaginazione. […] In Robinson, natura e cultura sono categorie in continuo cambiamento, e l’evoluzione della comunità va insieme alle descrizioni del paesaggio trovato, e di quello in corso di perpetua ricostruzione da parte dei coloni. […] Ma quello che conta, sempre, è la spinta al miglioramento che muove la comunità: nella Frontiera sempre in movimento, mai soddisfatta di sé stessa, sempre pronta a criticarsi anche radicalmente, senza illusioni di innocenza o perfezione, Robinson scorge l’utopia.
Un interesse, questo, quasi anacronistico e sicuramente atipico, assuefatti come siamo a produzioni incentrate sulle derive distopiche della società in cui viviamo, ma che nelle opere di Robinson ricorre genuinamente fin dagli esordi. La trilogia marziana è un’opera totale, che non tralascia nessun aspetto della vita dei futuri coloni del pianeta rosso, e attraverso di loro traccia con rigore scientifico e con convincente realismo la storia futura della civiltà umana, nel suo spingersi oltre i limiti della culla terrestre e nella graduale presa di coscienza da parte loro (ma anche di noi lettori) delle responsabilità che ci legano alla biosfera, sia essa naturale o artificiale, da cui tutti dipendiamo.
Solo apparentemente separati, costruiti su una serrata continuity interna, i tre volumi potrebbero essere in realtà altrettanti libri quanti sono i protagonisti che si passano il testimone da un capitolo all’altro, ciascuno portatore di una propria prospettiva e di un proprio bagaglio di ideali e convinzioni personali. Intersecandosi e completandosi reciprocamente, i loro punti di vista finiscono per essere, come le facce di un diamante, parti di un unico grande libro-mondo che li contiene tutti. Come scrive l’autore stesso in un articolo apparso di recente sul mensile Le Scienze (“La grande incognita. Possiamo fidarci delle nostre previsioni?”, in Le Scienze n. 579, novembre 2016):
Le disuguaglianze del nostro sistema economico, la distruzione della capacità della nostra biosfera di darci sostentamento, la possibilità che saremo noi a provocare una sesta estinzione di massa nella storia della Terra, tutto ciò diventerà chiaro a tutti gli abitanti del pianeta. Si farà evidente il bisogno di cambiare i nostri sistemi tecnologici e sociali per evitare una catastrofe e creare un mondo giusto e sostenibile per tutti. […] Il capitalismo come lo mettiamo in pratica oggi, dal punto di vista delle tecnologie contemporanee, è come l’impianto di produzione di plutonio di Chelyabinsk-65: sporco, brutale, distruttivo, stupido. Non è in grado di risolvere i problemi che abbiamo di fronte, ed è anzi esso stesso il problema.
Nato in Illinois nel 1952 (per l’esattezza a Waukegan, la stessa città che diede i natali a un altro scrittore “marziano”, Ray Bradbury), cresciuto nel sud della California, Kim Stanley Robinson pubblica i suoi primi racconti a partire dal 1975. All’Università della California di San Diego si dedica in quegli anni allo studio delle opere di Philip K. Dick per la sua tesi di PhD (poi pubblicata in volume nel 1984 con il titolo The Novels of Philip K. Dick). Suo relatore è il critico e studioso marxista Fredric Jameson, esperto di postmodernismo e delle risonanze culturali tra crisi del tardo capitalismo e immaginario che in esso trovano espressione, che lo sprona ad approfondire Dick definendolo senza mezzi termini “il più grande scrittore americano vivente”.
Nei suoi lavori teorici Jameson rivendica per altro la necessità di ideare “forme [di racconto, NdA] radicalmente nuove” in grado di rispondere alla complessità della nostra epoca. Come scrive il critico Larry McCaffery: “Queste forme contengono le possibilità di un nuovo tipo di arte politica che va al di là della nostalgia del passato o della mera rappresentazione del nostro attuale ‘spazio globale del capitale multinazionale’”. “Arte politica” che Jameson concepisce come una svolta ancora inimmaginabile, che dovrà metterci in condizione di “riconquistare la nostra posizione di individui e di soggetti collettivi, ritrovando la capacità di agire e di lottare, attualmente neutralizzata dalla nostra confusione”. E se per McCaffery “la fantascienza postmoderna deve essere considerata come la svolta ‘realista’ della nostra epoca”, secondo Jameson non c’è alcun dubbio che il romanzo storico del futuro scaturirà necessariamente dall’alveo della fantascienza.
In un’epoca storica in cui la cosiddetta letteratura mainstream tradisce problemi sistemici nell’affrontare la complessità crescente del mondo, al punto da indurre sempre più autori a confrontarsi con i codici e gli stilemi di un genere come la fantascienza storicamente assimilato nel quadro della letteratura popolare, scopriamo avverate molte di queste “profezie”. Esito tutt’altro che scontato, se si considera il fatto che tra tutti i generi popolari, anche restringendo il campo alla sola letteratura non-mimetica e al fantastico puro, la science fiction non è certo il più accessibile del pacchetto. Ma grazie agli strumenti e alle risorse del suo armamentario, la SF ha saputo offrire come nessun altro segmento dell’immaginario torri di osservazione privilegiate sul nostro tempo e sui mutamenti sempre più rapidi che lo coinvolgono.
Diversi autori formatisi nel vivaio delle riviste e dell’editoria di settore figurano oggi nel novero delle voci più rilevanti e autorevoli del panorama letterario internazionale, svincolati da ogni etichetta: dai veterani Ursula K. Le Guin e George R. R. Martin a Neil Gaiman, Jeff Vandermeer e China Miéville, passando per William Gibson, Iain M. Banks (di recente scomparso) e lo stesso Kim Stanley Robinson. Questi ultimi appartengono all’ondata di nuovi autori emersi dalla fantascienza degli anni ’80, un periodo di enormi contraddizioni ma anche di rigenerazione cruciale, che grazie ai mass media ha sancito la definitiva saldatura tra immaginario di genere e cultura popolare.
Gli ’80 sono gli anni che decretano il trionfo delle istanze della New Wave, il moto di rinnovamento che nei due decenni precedenti era stato a sua volta fortemente influenzato dalle tesi del postmodernismo. Quando Robinson arriva sulla scena, la fantascienza comincia a essere attraversata dalle prime scariche elettriche che avrebbero poi dato vita alla corrente cyberpunk, sull’onda del successo dei lavori di Gibson e di altri autori, quali Bruce Sterling, John Shirley, Lewis Shiner, Pat Cadigan e Rudy Rucker. Il filone porta alla ribalta una fantascienza “sporca”, che potremmo definire quasi “da strada”, grazie alla quale la tecnologia entra nei corpi, trasforma le menti e ridefinisce i contorni di identità, personalità e memoria, diventando in mano a fuorilegge ed emarginati un’arma non convenzionale da rivolgere contro le concentrazioni di potere (sia esso politico, industriale o finanziario) nel futuro di turno.
L’estetica cyberpunk riceve ampia diffusione grazie a film come Blade Runner e 1997: Fuga da New York, che a prima vista hanno più punti di contatto con l’hard-boiled che con la fantascienza classica, e a dimostrazione della sua polivalenza la troviamo declinata in opere diversissime tra loro: i film della saga di Alien e la serie dedicata a Mad Max, Videodrome, Terminator, Robocop, fino ai più recenti Strange Days e Matrix. Esploso con il successo planetario di Neuromante (in cui William Gibson riformula in una sorta di inconsapevole manifesto letterario le folgoranti intuizioni già alla base dei suoi primi racconti, poi riuniti nell’antologia La notte che bruciammo Chrome), il cyberpunk diventa presto una cassa di risonanza da cui irradiare in altri media – il cinema, appunto, ma anche l’arte, la moda, la musica, l’animazione, il fumetto, la tv – una sensibilità che non avrebbe mai potuto maturare senza gli anticorpi della fantascienza di J. G. Ballard, Samuel R. Delany e Philip K. Dick (per citare solo qualche nome).
Tra i maggiori meriti del cyberpunk, Jameson e McCaffery individuano la lucidità analitica nel puntare i riflettori sull’informazione come risorsa globale, atteggiamento che fa di questa corrente l’interprete per eccellenza della critica al capitalismo post-industriale. Solo incidentalmente Kim Stanley Robinson si trova a toccare l’immaginario cyberpunk, ma non esita a dissociarsi nei fatti dalla logica dualistica che tenta di annoverarlo tra i rappresentanti di una presunta “fantascienza umanista”, da contrapporre al movimento di Gibson e Sterling. Non accontentandosi di mettere a fuoco i nuovi modelli di sfruttamento derivati dal dilagare del liberismo negli anni dell’edonismo reaganiano, presto Robinson riesce addirittura a sorpassare il cyberpunk, radicalizzandone le istanze fino a mostrare le possibilità del sapere strutturato e della conoscenza organizzata come armi più efficaci della semplice informazione.
Nel leggere il ricco corpo di opere che ha dato alle stampe in questi trent’anni sembra di assistere – discorso peraltro valido anche per lo stesso Gibson – a una costante, progressiva, implacabile attuazione delle tesi di Jameson. Robinson esordisce nel romanzo nel 1984 con The Wild Shore (in italiano La Costa dei Barbari, Interno Giallo, 1990), titolo inaugurale della terza serie degli Ace Science Fiction Specials, la collana che segna il ritorno di Terry Carr alla Ace in veste di freelance e che proseguirà quello stesso anno con titoli di Lucius Shepard e William Gibson, confermando la leggendaria abilità di Carr come scopritore e valorizzatore di talenti. Il 1984, anno emblematico per la letteratura d’anticipazione, è così sì l’anno di Neuromante, che esplode come una supernova cambiando per sempre il panorama della fantascienza, ma è anche l’anno di Robinson, che a pochi mesi dal primo romanzo replicherà con Icehenge, sempre per Ace (a pubblicarlo in Italia, solo due anni più tardi, sarà con ammirevole tempismo la gloriosa Editrice Nord di Gianfranco Viviani). Come scrive Piergiorgio Nicolazzini nella presentazione italiana del volume:
L’influenza di un autore come Dick […] non assume toni clamorosi nella SF di Robinson, e si coglie semmai in alcuni valori di fondo: l’impiego delle convenzioni SF mediate da una grande sensibilità letteraria, la lucida tensione morale e la sottile analisi psicologica. Diversamente da altri colleghi (e coetanei), la qualità della SF di Robinson non dipende tanto dalla concentrazione delle immagini e dalla vertigine delle estrapolazioni tecnologiche, quanto dalle risorse naturali del grande narratore: una prosa elegante e meditativa, che coinvolge gradualmente il lettore attraverso un’emozione interiore suscitata dall’intensa caratterizzazione e dalle relazioni dei personaggi con l’ambiente, la coscienza, il tempo, la storia.
In questi primi due romanzi troviamo condensati tutti i principali tratti distintivi che torneranno nelle opere successive, rivelando l’interesse di Robinson per le questioni ambientali, la ricerca scientifica, l’applicazione della conoscenza, le responsabilità degli uomini verso il proprio ecosistema, i principi di funzionamento delle organizzazioni e delle società umane. The Wild Shore costituisce il primo tassello di una trilogia atipica, che con i successivi titoli (The Gold Coast, 1988, e Pacific Edge, 1990, solo il primo dei quali tradotto in italiano come Costa delle Palme, 1994, Interno Giallo / Mondadori) svilupperà un’ambiziosa esplorazione di tre distinte versioni della California del futuro, rispettivamente da una prospettiva post-apocalittica, distopica/cyberpunk e utopica, a seconda dei diversi gradi di avanzamento raggiunti dalla tecnologia: pressoché spazzata via da un olocausto nucleare, tenuta rigidamente sotto controllo dalle multinazionali, in pacifico equilibrio con la natura in un’utopia green d’ispirazione socialista.
Icehenge presenta invece il tipo di scenario spaziale che negli anni diventerà familiare a una parte significativa della produzione di Robinson: l’umanità che colonizza progressivamente il sistema solare, mette a punto tecniche di estensione della vita che consentono di vivere secoli, e comincia a confrontarsi con la propria intrinseca “inadeguatezza” ad affrontare tutto questo. Il nostro cervello non si è evoluto per immagazzinare centinaia, migliaia di anni di esperienze e di sapere, e come conseguenza della frammentazione dei ricordi la personalità assume una forma liquida, camaleontica, mutevole, spingendo gli uomini e le donne di questo futuro a elaborare strategie “letterariamente” sofisticate per preservare la propria integrità e la consapevolezza di sé. “La memoria è l’anello debole della catena”, per citare uno dei protagonisti, alle prese con un’opera di scavo archeologico in un passato di cui pure è stato testimone, ma di cui non ha più memoria. “Ma pur impalpabili come ragnatela questi ricordi potranno ora rimanere alla portata della mia coscienza: ciò che ci colpisce di più viene ricordato più facilmente. È l’anello più debole”.
Già in Icehenge troviamo quindi in opera lo sforzo apparentemente anacronistico di costruire una società più equa, che si mescola a tematiche più classiche come la semi-immortalità, le trappole della memoria e soprattutto Marte, tutti ingredienti che verranno diffusamente ripresi a partire dal 1993 nella già citata trilogia marziana. Anzi, talmente poco abituati al lieto fine da diffidarne, viene quasi da chiedersi se l’esito finale del processo di areoformazione, che plasma il pianeta rosso e i suoi nuovi cittadini nella trilogia, non sia solo il sogno di uno dei discendenti dell’umanità nel mondo di Icehenge, un falso ricordo, il resoconto di come vorremmo che fossero andate le cose.
In maniera del tutto analoga possiamo trovare echi di tutti e quattro questi romanzi in un futuro ancora diverso, quello rappresentato in 2312 (2012), che ci conduce attraverso tutto il sistema solare, da Mercurio alle lune di Giove e Saturno, alla scoperta di habitat artificiali, città semoventi, ambienti terraformati e tecnologie postumanizzanti di adattamento agli ecosistemi spaziali. Esplorando la Storia dei prossimi tre secoli e mettendola in risonanza con le singole storie individuali dei suoi personaggi, ancora una volta Robinson riscrive le basi delle sue società. Questa volta immagina un’economia interplanetaria di tipo pianificato, con ciò che resta del libero mercato confinato sulla Terra, mentre le multinazionali sono state soppiantate dappertutto da entità cooperative definite mondragon (sul calco della federazione basca delle cooperative dei lavoratori, un concetto che già aveva fatto capolino nella trilogia di Marte), e numerose fazioni umane e postumane a contendersi l’egemonia avvalendosi dell’inconcepibile potere dei qubes, intelligenze artificiali supportate da processori quantistici. Un altro soggetto divenuto quasi un cliché, che nelle mani dell’autore di razza svela insospettabili riserve di originalità.
Robinson aveva recuperato temi e situazioni della trilogia anche in Antarctica (1997), in cui immaginava l’imminente corsa delle multinazionali alle risorse del Polo Sud a ridosso della scadenza del Trattato Antartico. La storia si svolge in larga parte nelle stazioni di ricerca e negli avamposti del continente di ghiaccio, di cui l’autore ha potuto maturare esperienza diretta grazie al Programma Antartico per Artisti e Scrittori predisposto dalla National Science Foundation americana.
La preoccupazione per i cambiamenti climatici, anch’essa prefigurata nella trilogia di Marte, diventa la problematica centrale con cui si confrontano gli scienziati della NSF alle prese con intrighi di spie, politici e lobbysti di Washington, nella serie Science in the Capital: Forty Signs of Rain (2004), Fifty Degrees Below (2005) e Sixty Days and Counting (2007), poi condensati e parzialmente riscritti per l’edizione omnibus del 2015, Green Earth. Questa trilogia guadagna a Robinson l’inclusione tra gli “Heroes of the Environment” del Time, che nel 2008 scrive:
In un genere pieno di allarmi ambientali, il dono di Robinson consiste in una visione che usa l’ambiente e la sua complessità come il fulcro di tutto ciò che accade […]. [Robinson] considera la creazione di utopie alla stregua di una sfida tecnica per il suo mestiere, per la loro difficoltà a farsi rappresentare in maniera convincente e interessante. Ma le considera anche una nicchia ecologica lasciata vuota nell’immaginario; anche solo per arricchire la biodiversità culturale, si prefigge di occupare questa nicchia.
S’inserisce a pieno titolo nel filone della cosiddetta climate fiction anche New York 2140, il suo ultimo romanzo (uscito lo scorso 14 marzo), che ci trasporta in una Manhattan sommersa dall’innalzamento del livello degli oceani, che ne ha trasformato le strade in canali navigabili e i grattacieli in isole.
La precedente fatica, Aurora (2015), per la prima volta ci porta a scoprire un altro sistema stellare, a bordo di una nave generazionale il cui autosostentamento è una sfida tecnologica e concettuale: una sfida che offre lo spunto per un parallelo con la necessità ormai improrogabile di adoperarsi per salvare il nostro pianeta. Citando l’accurata disamina di Gianluca Didino, la nave è un “iperoggetto” che pone i protagonisti in relazione a “una scala temporale diversa da quella degli esseri umani”, dischiudendo l’accesso a una prospettiva inedita sui problemi della Terra. Come scrive l’autore stesso in un illuminante saggio che ha accompagnato l’uscita del romanzo:
Allora dovremmo smettere di raccontare queste storie? Forse no. […] I romanzi sono legittimati a prendere in considerazione l’idea, su questo non c’è dubbio. Ma quando consideriamo come dovremmo comportarci adesso, dovremmo tenere bene in mente che l’idea che se distruggiamo la Terra avremo un secondo posto dove andare è semplicemente falsa. Dobbiamo tenerlo bene in mente, per dare il giusto valore al nostro solo e unico pianeta […]. Non abbiamo un Pianeta di Riserva! La Terra è la nostra unica casa possibile!
Se ne renderanno conto i coloni di Aurora, reduci da un viaggio durato centosessanta anni, sbarcando su un mondo che si rivela più ostile del previsto e li obbliga a una sequenza di scelte sempre più difficili e dolorose.
Non c’è contraddizione con quanto abbiamo visto in questa rapida, parziale carrellata. Dopotutto, già Marte veniva presentato nella trilogia come una sorta di laboratorio in cui testare su scala planetaria possibili soluzioni ai nostri problemi attuali e futuri. Citando uno dei personaggi in un brano particolarmente ballardiano de Il blu di Marte:
Marte è uno specchio nel quale la Terra vede la sua stessa essenza. […] Lo spostamento su Marte è stato un viaggio purificante, che ha rimosso tutto tranne le cose più importanti. Ciò che alla fine è arrivato era in tutto e per tutto terrestre, e quello che è successo da allora è stato un’espressione del pensiero e dei geni terrestri. Quindi, più che con qualsiasi aiuto materiale fatto di metalli rari o di nuovi geni, noi possiamo aiutare il pianeta soprattutto servendo come uno specchio in cui possiate vedere voi stessi, come un mezzo per mappare un’immensità inimmaginabile. Così, nel nostro piccolo mondo, facciamo la nostra parte per creare la grande civiltà che trema sull’orlo del divenire. Siamo i primitivi di una civiltà ignota.
L’intera opera di Kim Stanley Robinson può essere letta come un appello alla responsabilità e un invito all’azione in difesa del nostro pianeta, un esercizio che non può prescindere dalla comprensione dei problemi che scaturisce da un percorso di scoperta e conoscenza.
Del 2009 è Galileo’s Dream, quasi un ponte tra le forme del romanzo storico e la fantascienza, per tornare alla previsione di Jameson. Descrizione minuziosa della vita dello scienziato toscano, il romanzo mette in risonanza lo scontro tra scienza e religione tracciando un parallelo tra il processo per eresia istruito dal Sant’Uffizio e il dibattito che nel 3020 divampa intorno alla possibile interferenza terrestre con una forma di vita aliena. Diventa così progressivamente una storia di primo contatto e di viaggi nel tempo, trasportando Galileo negli insediamenti umani stabiliti sui satelliti medicei di Giove, da lui stesso scoperti nel 1609. I critici non hanno mancato di notare il sapiente lavoro di ricostruzione storica. Ma per il lettore italiano il libro contiene anche degli spunti particolari, rievocando l’appello di Italo Calvino (che peraltro, in polemica con i suoi colleghi, ebbe modo di definire Galileo “il più grande scrittore della letteratura italiana di ogni secolo”), a costruire un ponte tra la cultura scientifica e quella umanistica, con un invito implicito ai due mondi a non arroccarsi nelle rispettive convinzioni di supremazia ma a intessere invece un dialogo che non potrà che rivelarsi proficuo per entrambi.
A questo proposito, Kim Stanley Robinson non poteva individuare una figura più emblematica per farne il fulcro del romanzo, imbastendo attraverso le sue scoperte e vicissitudini una maestosa riflessione sulle dimensioni temporali della coscienza e catturando, ancora una volta meglio di chiunque altri, il ruolo e il significato della ricerca scientifica. Nel già citato articolo per Le Scienze, Robinson esordisce con una precisazione importante e quasi programmatica:
tutti questi futuri possibili presentati dalla fantascienza non sono solo previsioni ma affermazioni metaforiche sul sentimento del presente. […] Se le si vede solo come previsioni, si perde il potere della fantascienza, il che sarebbe un errore, perché questo genere letterario ha sempre parlato del presente più che del futuro. È un tentativo, allo stesso tempo, di ritrarre un futuro possibile e di descrivere il senso del nostro tempo. Questi due aspetti sono come le due immagini in uno stereoscopio: quando la mente le fonde insieme, compare dal nulla una terza dimensione che, in questo caso, è il tempo, la storia, resa più vivida del solito grazie alla visione fantasiosa tipica della fantascienza.
Forse troviamo l’esempio più compiuto di questa funzione nelle sue storie ucroniche. Come ad esempio nel romanzo Gli anni del riso e del sale (The Years of Rice and Salt, 2002, edito in Italia da Newton Compton nel 2007), che segue oltre sette secoli di storia alternativa a partire dal 1348, anno in cui la Peste Nera elimina il 99% della popolazione europea (contro le stime ufficiali del 30%), escludendo di fatto l’Europa Occidentale dal suo ruolo di primo piano giocato nel progresso dell’umanità e aprendo così la strada all’ascesa delle culture araba, indiana e cinese, con conseguenze rilevanti per lo sviluppo scientifico e la storia della filosofia. O nel racconto “Il Lucky Strike” (1984), che pone il protagonista, capitano della squadra di riserva dell’Enola Gay, di fronte al dilemma morale di sterminare migliaia di civili innocenti per porre fine alla guerra. Con un gesto minimo, il piccolo esercizio di volontà di un singolo uomo, il volo del Lucky Strike su Hiroshima riesce a cambiare il corso della storia, se non negli avvenimenti di certo nella consapevolezza dei suoi interpreti, che poi siamo tutti noi. E probabilmente è questa la caratteristica più spiazzante che emerge dalle opere di Kim Stanley Robinson: una fiducia assoluta nella capacità degli uomini di scegliere la cosa giusta, se messi alle strette. Una qualità che lo pone esattamente agli antipodi – visto che lo abbiamo citato – rispetto al nichilismo di Ligotti.
A spiegarci il perché lasciamo che sia lo stesso Robinson. Dall’articolo già menzionato: “sulla base di tutte le tendenze che vedo all’opera, prevedo che la nostra intelligenza e il nostro desiderio di fare del bene per i nostri figli ci condurranno verso la costruzione di una civiltà che avrà un rapporto stabile con la biosfera. Dopodiché, prevedo che le cose si faranno ancora più interessanti”. Riusciamo addirittura a convincercene, misurandoci con la tenacia, gli sforzi e le conquiste dei suoi personaggi.

