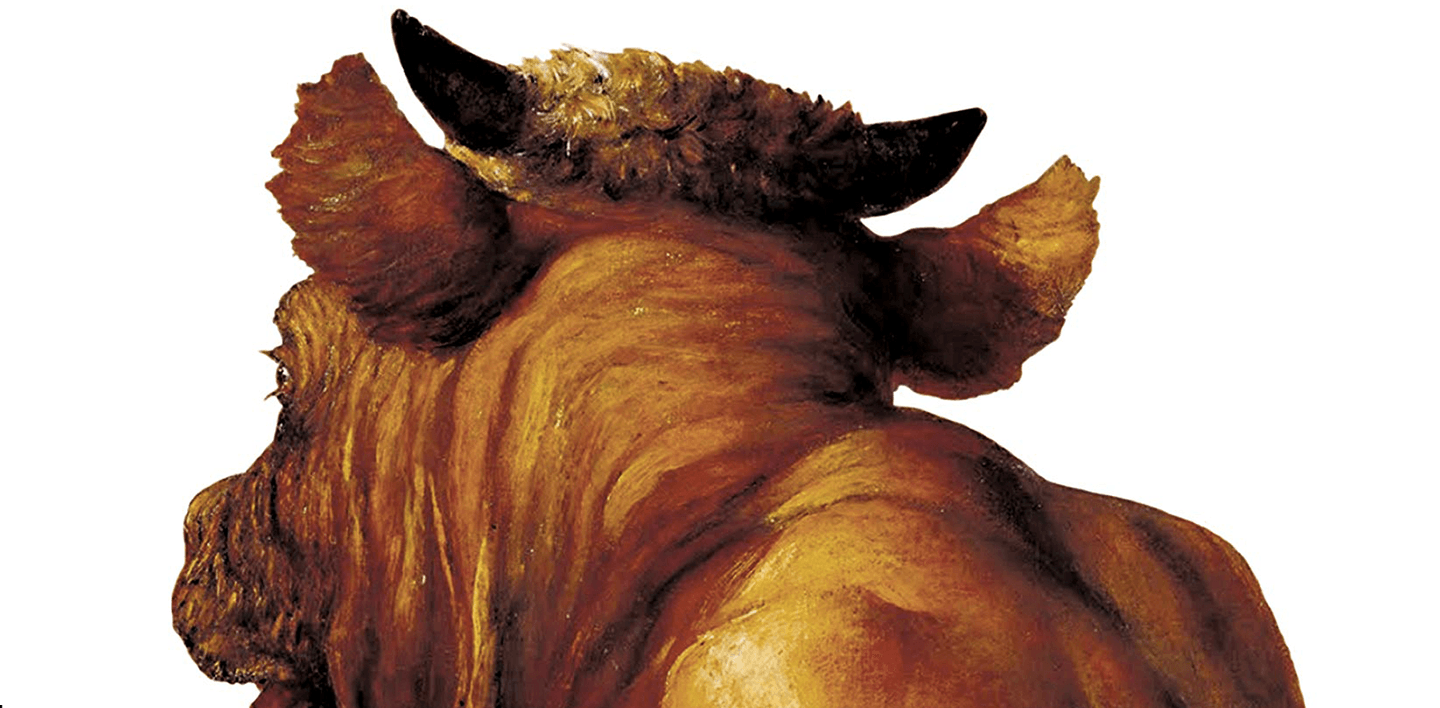
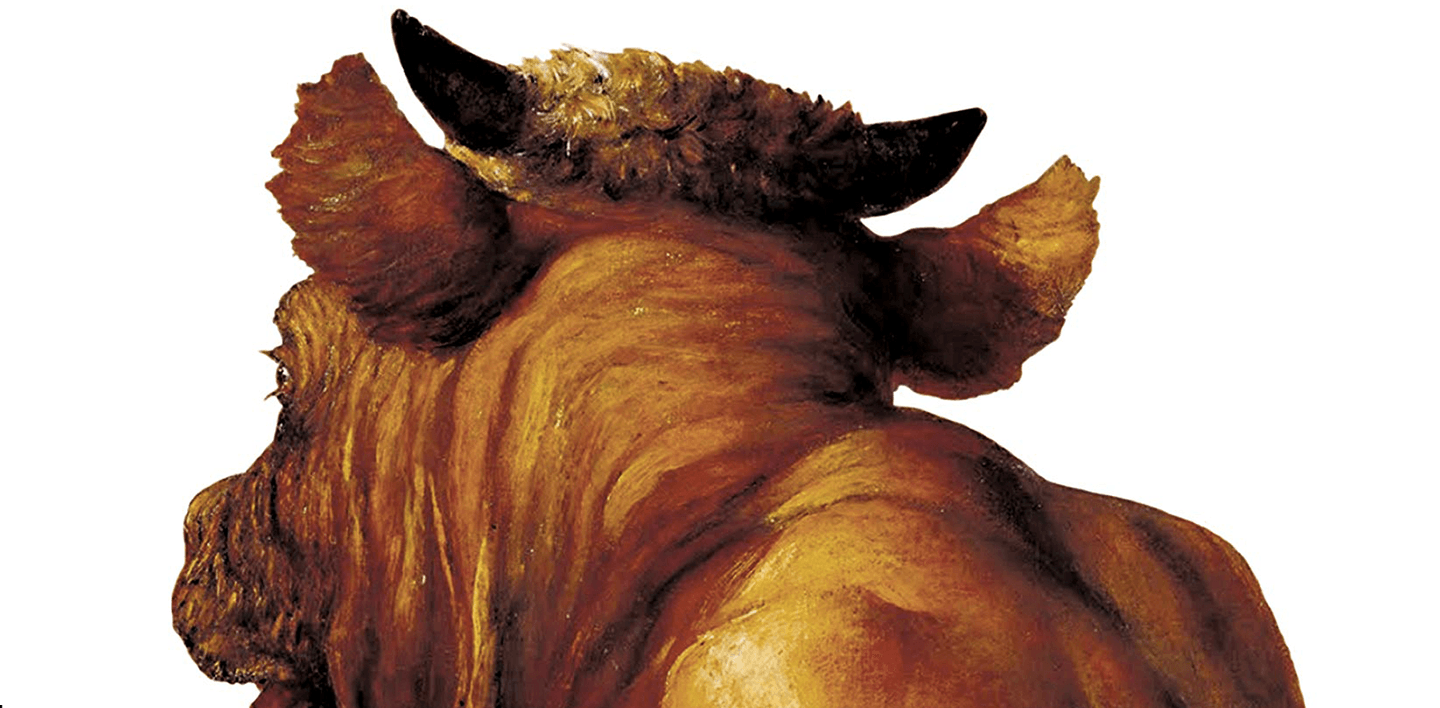
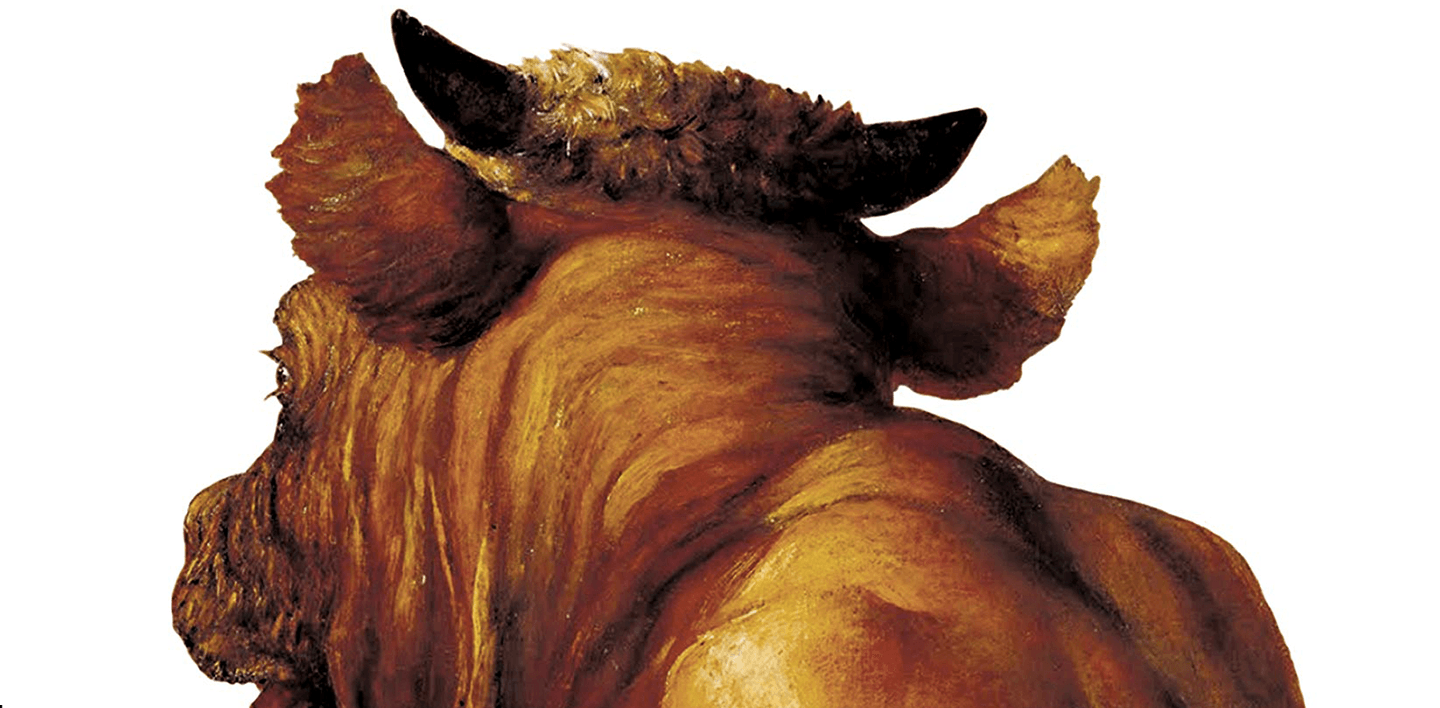
P rima di vincere l’ultimo Goncourt con il suo L’ordine del giorno (E/O, trad. Alberto Bracci Testasecca) lo scrittore Éric Vuillard si è speso in simili e apprezzati esercizi di storia romanzata: ha raccontato il colonialismo, la rivoluzione francese e adesso il nazismo, per la precisione uno dei momenti cruciali dell’affermazione politica e militare della Germania nazista: l’annessione dell’Austria al Terzo Reich avvenuta ufficialmente il 12 marzo 1938. Con la smaliziata commistione di realtà e finzione a cui siamo ormai abituati, Vuillard s’intromette nelle coscienze dei diplomatici e statisti che orchestrarono lo storico evento inventandosi i loro pensieri, le loro emozioni, la loro quotidianità e inserendo tutto ciò nel quadro di una fattualità ben documentata e in una leggera cornice narrativa. I personaggi sono tratteggiati con abilità, la trama del libro mette a fuoco alcuni retroscena di quanto accadde quel giorno, evoca la connivenza con l’impresa nazista dei capitani d’industria tedeschi dell’epoca, costruisce un oggetto artistico che soddisfa diversi bisogni: quello di conoscere intrattenendosi, quello di blandire le nostre fantasie di rivalsa e il nostro senso di giustizia, quello di renderci partecipi di una lingua alta e poetica, quello di metterci in guardia sul futuro.
Se l’attribuzione a questo romanzo del principale riconoscimento letterario francese conferma la passione del mondo letterario d’oltralpe per la storia, e in particolare quella nazista (basta scorrere la lista dei premiati degli ultimi dieci-quindici anni: Littel, Ferrari, Énard), L’ordine del giorno convince solo in parte e sorge spontanea la domanda: perché proprio lui? La prima risposta che viene in mente, un po’ maligna, è che la storia, come la racconta Vuillard, ha successo perché è una storia ammansita, edificante, facile da capire: una storia in versione poche. L’attualità editoriale italiana ci offre esempi di narratori francesi ugualmente e ossessivamente votati al confronto con il passato ma ben altrimenti orientati. Un primo esempio è Pierre Michon che con Gli undici (Adelphi, nella bella traduzione di Giuseppe Girimonti Greco), attraverso il dipinto (inesistente) degli undici membri del Comitato di Salute Pubblica, l’organo di governo dittatoriale istituito durante la rivoluzione francese nel 1793, ha intessuto una fitta rete di microstorie e genealogie, mostrando ancora una volta un’erudizione straordinaria, una voce inconfondibile e un’immaginazione storica dai tratti tutt’altro che confortanti (“perché la Storia è terrore allo stato puro. E questo terrore ci attira come un magnete”): nulla qui della compiacenza o degli accomodamenti al senso comune che sentiamo agire nella scrittura di Vuillard.
O ancora la nuova edizione Einaudi di W o il ricordo d’infanzia di Georges Perec, tradotta da Maurizia Balmelli, piccolo capolavoro doppio e scisso: racconto autobiografico di un giovane ebreo rimasto orfano di entrambi i genitori durante la seconda guerra mondiale, e romanzo distopico in chiave psicanalitica. Al contrario della sicurezza stilistica, morale ed epistemologica di Vuillard qua si fa strada il vuoto, il bianco, l’impossibilità di ricordare, elaborare, spiegare, giudicare. La storia è un buco nero nel quale la memoria personale del narratore sprofonda lasciandosi alle spalle, come un residuo inerte, la scia brillante di un’allegoria fantapolitica. W è probabilmente uno dei più interessanti tentativi della letteratura francese di fare i conti con la violenza della storia del Novecento, un libro densissimo e tremendamente sofferto, capace di influenzare numerosi autori che in seguito si sono cimentati in simili imprese (anni fa mi misi a segnare tutte i riferimenti a questo romanzo presenti in Austerlitz di Sebald, e ne trovai moltissimi).
Il libro che vorrei eleggere ad anti-Vuillard è però un altro romanzo (o anti-romanzo) da poco uscito in Italia da Quodlibet: La fine del mondo sembra non sia arrivata dello scrittore ceco-francese Patrik Ourednik (la traduzione è di Andrea Libero Carbone che fu il primo con la sua :duepunti edizioni a portare in Italia questo insolito scrittore). Già autore di un enigmatico volumetto intitolato Europeana, sorta di inventario di luoghi comuni sulla storia, tra Benjamin e Flaubert, opera originalissima e dotata di un’inesorabile e opaca perfezione, Ourednik continua sulla stessa strada con questo nuovo libro, meno bello ma non privo di genio, in cui unisce una trama minimalista (un presunto nipote di Hitler alla ricerca di conferme sulle proprie origini) a divagazioni errabonde e parodie di ricerca storiografica. Come Vuillard (e Michon e Perec) Ourednik è uno scrittore con il pallino della storia, non può fare a meno d’interrogarla di continuo, e più vi si immerge più ne esce con una visione nichilista e una concezione del corso degli eventi intesi come prodotto della demenza irredenta e irridemibile dell’animale umano.
Ourednik racconta la storia come un pantagruelico guazzabuglio d’ignoranza crassa e brutale, e noi lettori siamo apertamente invitati a consideraci parte dello stesso banchetto.
Ogni grande capitolo del tempo pregresso si autodenuncia, nelle pagine di questo autore, con la sua violenza e/o truce insensatezza. L’uomo è malvagio e se non è malvagio è stupido e inetto, non impara un tubo dagli errori e procede ottusamente verso la propria autodistruzione: questa morale è esposta tramite exempla e aneddoti di varia natura ricavati da diverse epoche storiche. Spesso i riferimenti attingono agli stessi momenti e personaggi di cui parla Vuillard e potrebbero essere proficuamente messi a confronto (Hitler, Chamberlain alla conferenza di Monaco, eccetera) per apprezzare la radicale opposizione che intercorre tra scrittori così diversi. Anche stilisticamente Ourednik si colloca agli antipodi dello stile tornito ed efficace di Vuillard: scrive come si potrebbe parlare a un bambino di dieci anni, con un dettato ipersemplificato e un tono ironico-sconsolato che ricorda al lettore italiano quello dei discepoli di Celati che si riunirono intorno a una rivista chiamata “il semplice” negli anni Novanta (non a caso il maggiore di essi, Ermanno Cavazzoni, dirige la collana che ospita entrambi i libri di Ourednik).
Da una parte dunque l’umanismo progressista, l’illuministica fiducia nella ragione, nella cultura, nell’arte e nelle superiori facoltà dell’essere umano di uno scrittore brillante come Vuillard; dall’altra uno sfrontato sperimentalismo grottesco e infantile, l’umor nero e il sardonico disincanto di chi dallo studio della storia sembra ricavare solo deformità e vicoli ciechi. L’inciviltà programmatica di Ourednik e la coscienza civile con tutti i crismi (compresi quelli della bella prosa) di Vuillard. Quando quest’ultimo mette in scena la meschinità dei politici lo fa col sorrisetto sprezzante e un sussiego iperletterario, s’indigna del male e attraverso la connessione pedagogica tra passato e presente rassicura il lettore sul bene e l’utilità della scrittura artistica, e in qualche modo lo esime dal dubbio di sentirsi sporco e colpevole. Ourednik indossa al contrario una maschera da minorato per descrivere un’umanità minorata, la cultura come un’attività strumentale o fallimentare, la storia come un pantagruelico guazzabuglio d’ignoranza crassa e brutale, e noi lettori siamo apertamente invitati a consideraci parte dello stesso grottesco e inglorioso banchetto.
Queste opposte visioni riproducono un dilemma insolubile: nichilismo vs impegno, pessimismo cosmico vs sorti progressive. Non esisteranno mai argomenti definitivi per schierarsi da una parte o dall’altra e le due forze, come Ormuz e Arimane, continueranno a disputarsi eternamente gli animi di chi si pone il problema. Quello che viene da pensare confrontando i due libri è tuttavia che La fine del mondo abbia carte decisamente migliori da giocare non solo sul tavolo della letteratura ma anche su quello politico: se col romanzo di Vuillard un pubblico colto e raffinato potrà continuare a sognare un futuro migliore, il falsetto di Ourednik sembra uno strumento molto più utile a comprendere la demenza che dilaga nel nostro presente. D’altronde, come nota lui stesso: “l’abuso dell’intelligenza impedisce di capire la stupidità, quindi di resisterle”.