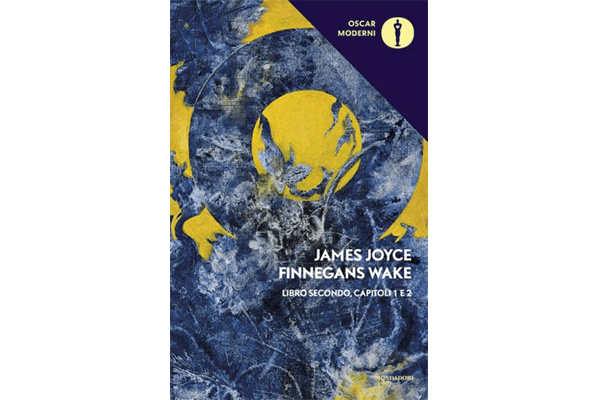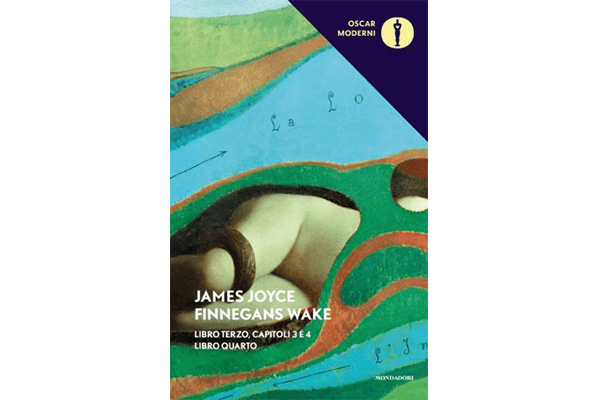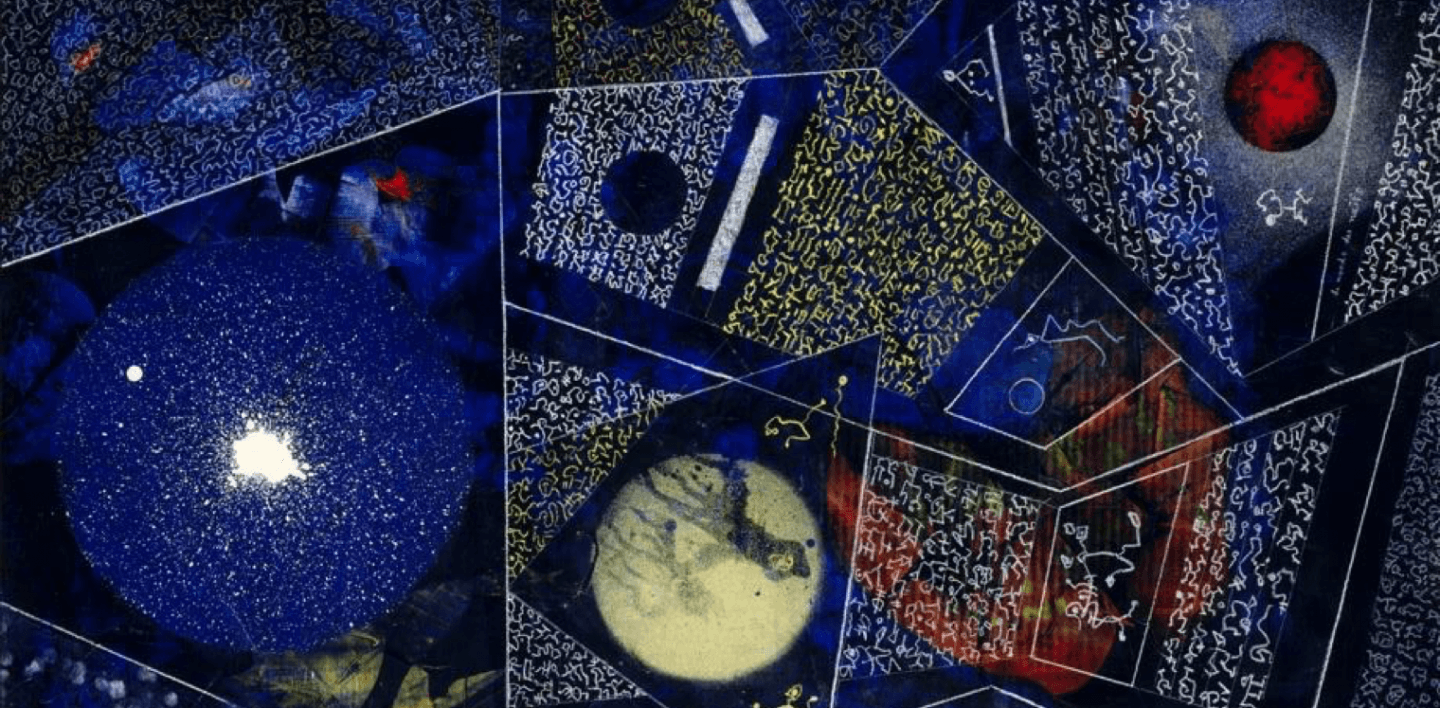
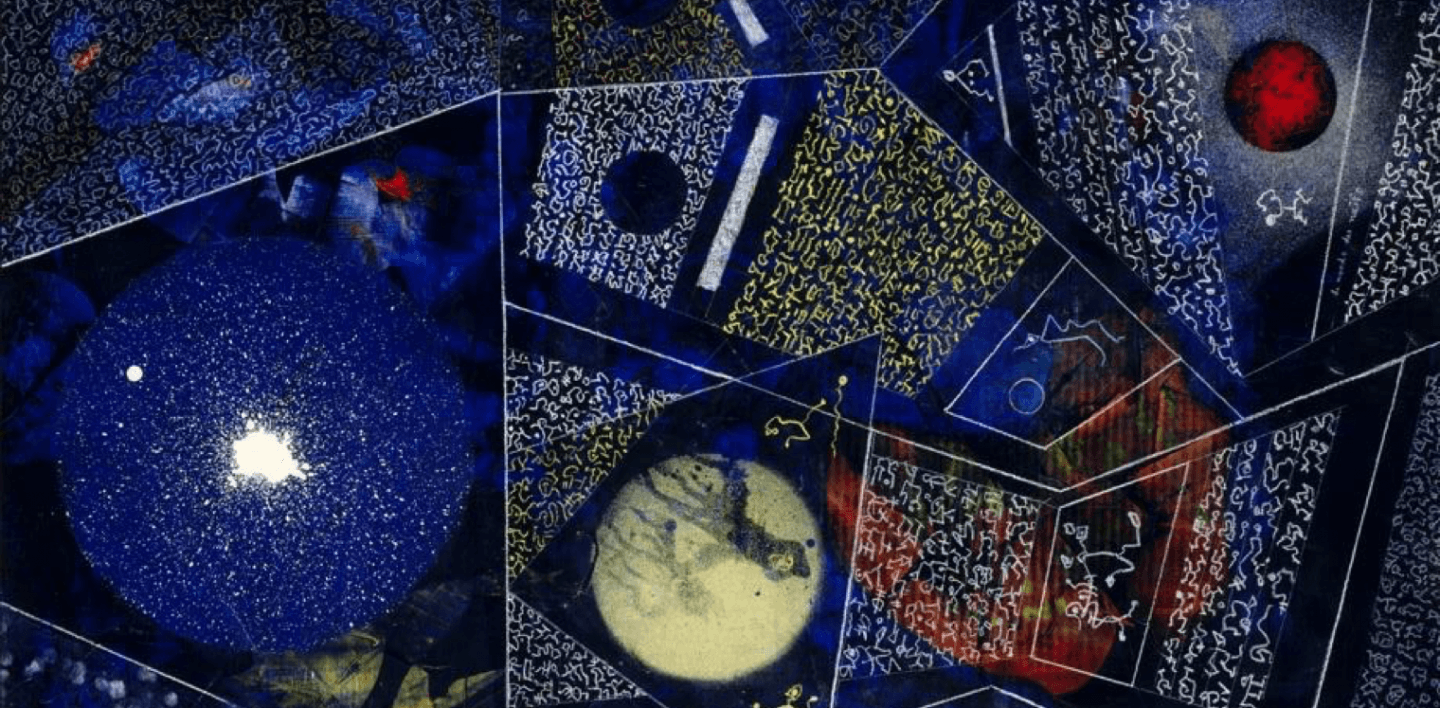
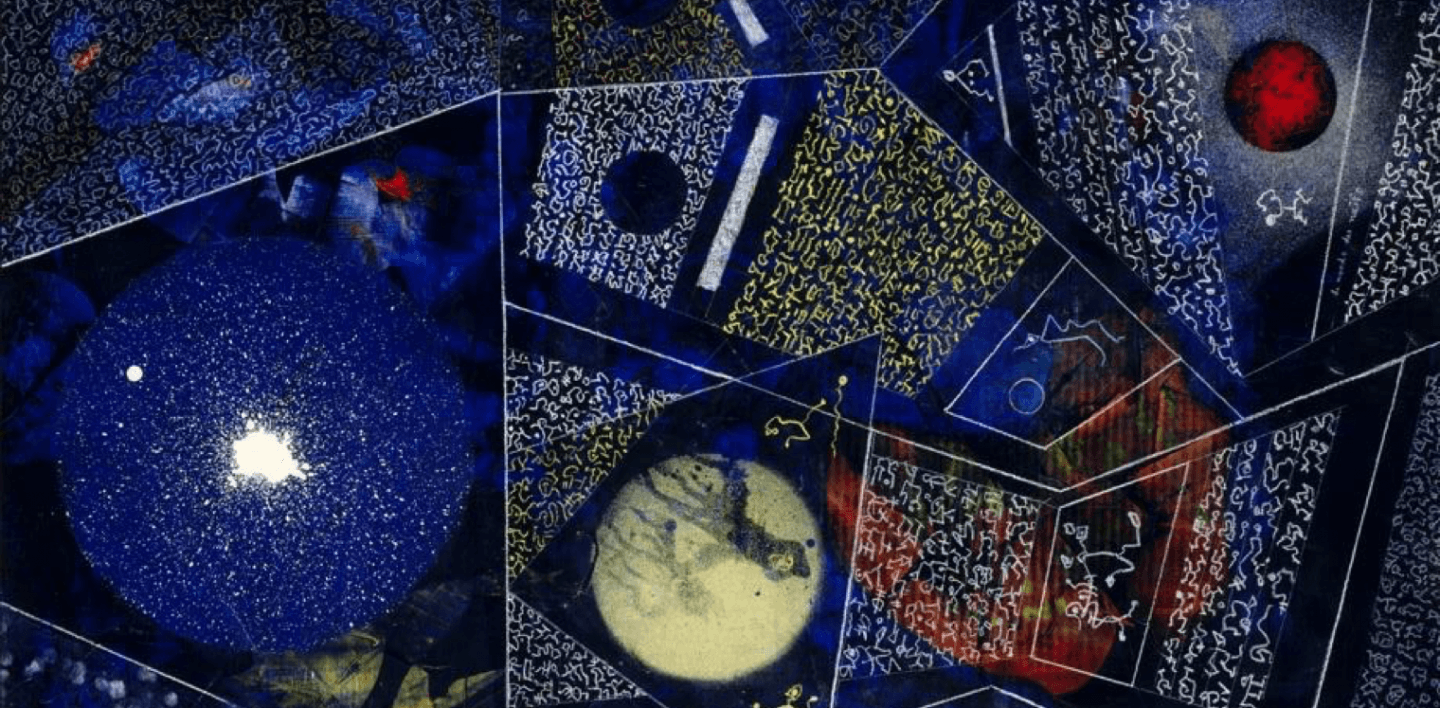
J ames Joyce impiegò sedici anni per scrivere il Finnegans Wake. Dato alle stampe l’Ulisse nel 1922, si avventurò nella stesura di uno dei libri più complessi della storia della letteratura, pubblicato il 4 maggio 1939. Il Finnegans Wake è un flusso di coscienza portato all’estremo, dove le parole si ibridano e corrompono, si rinnovano in suoni e immagini che abbracciano più significati al tempo stesso e aspirano a raccontare la storia dell’umanità intera.
Scritto ricorrendo a più di quaranta lingue, il Finnegans Wake ha fama d’essere un libro intraducibile. “Essendo quest’opera quasi interamente scritta con parole inventate, di tre, quattro, cinque e persino sei sensi, la sua traduzione in una qualunque lingua è assolutamente impossibile” commentava Rodolfo Wilcock negli anni Sessanta, cimentandosi in una versione condensata dell’opera in italiano.
L’impresa della sua traduzione fa storia a sé. Iniziata negli anni Ottanta da Luigi Schenoni per gli Oscar Mondadori, la traduzione italiana è stata completata da Fabio Pedone e Enrico Terrinoni nel 2019, a ottant’anni dalla pubblicazione dell’originale. Così è stato dato un inizio all’incipit, al “fluidofiume” di Schenoni [“riverrun, past Eve and Adam’s…”], che è il completamento della frase che chiude l’ultimo capitolo del libro “L’a via l’una al fin amata a lungo ‘l” [“A way a lone a last a loved a long the”].
Che cosa significa tradurre un libro intraducibile? Confrontarsi con un’opera celebre per la sua oscurità?
Per essere un libro così inafferrabile, al Finnegans sono state date definizioni molto lapidarie: “mostro”, “opera schizofrenica”, “sogno dell’umanità”…. Voi come lo definireste?
Fabio Pedone: Noi abbiamo spesso puntato sulla definizione di “libro-sogno”, il sogno di un libro. Oppure: “il sogno di una lingua che diventa lingua del sogno”. È molto ampia, fluida, non pesa come una lapide né su noi né sul fantasma di Joyce. Il sogno è indefinito, metamorfico, parla di possibilità non viste, quando poi si racconta è sempre impoverito nella realtà. Joyce usa una “alingua” in pezzi, usa gli smerigli, i frammenti di vetro di una e di molte lingue: è il sogno di qualcosa di nuovo, una uglossia, però creato con i pezzi di quello che c’era già, mandato in frantumi con una furia quasi infantile.
Enrico Terrinoni: Sì, lui ha l’idea di scrivere questo libro-sogno, libro-incubo, quando scrive l’ultimo capitolo dell’Ulisse, dove c’è un personaggio che si sta addormentando e inizia a storpiare le parole sul canovaccio del nome Sinbad, il marinaio. Però Joyce in questo Sinbad ci vede proprio sin e bad, cioè ci vede il peccato e il male. La parola nel sogno si inizia a scorporare, diventa qualche altra cosa. “Sinbad the Sailor and Tinbad the Tailor and Jinbad the Jailer and Whinbad the Whaler and Ninbad the Nailer” finché non arriva a: “Darkinbad”. Il peccato nel male diventa l’oscuro nel male. E si addormentano i personaggi. Da lì matura l’idea a cui allude Fabio, ovvero che l’unica cosa che non è ancora stata detta nel romanzo, nella finzione, è ciò che non si può dire. Il sogno te lo dimentichi al risveglio, sono pochissimi i sogni che ci ricordiamo. Ricordiamo qualcosa di sfumato, i contorni non ci sono più. Questo non è un libro-sogno nel senso positivo del termine, ma nel senso reale: noi gran parte della nostra vita non ce la ricordiamo o ce la ricordiamo in maniera sfumata.
In questi giorni sto leggendo la tesi di dottorato di uno studente di Liverpool che sta ricostruendo la storia irlandese per come la vede Joyce nel Finnegans. Cioè totalmente trasfigurata: non ci sono più differenze tra protestanti e cattolici, il cattolico è protestante e il protestante è cattolico, l’irlandese è inglese e l’inglese è irlandese – questo avviene solo nei sogni, perché nella realtà io sono io e Fabio è Fabio; ma nel sogno io sono Fabio e lui è me. Joyce si rende conto che c’è una parte vera della vita che noi non maneggiamo in maniera razionale e può solo essere raccontata in quel modo là.
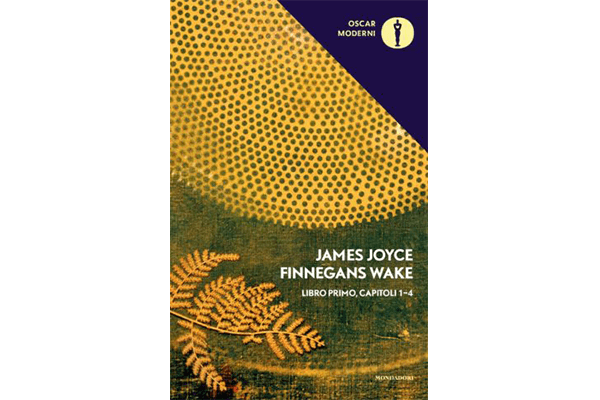
Nabokov, che era un grande estimatore dell’Ulisse e gli ha dedicato un capitolo molto bello nel suo Lezioni di letteratura, a un certo punto parlando del Finnegans dice che è “di un’inintelligibilità inutile” e che è “a uso esclusivo degli iniziati”. È davvero un libro per iniziati? Per esempio, io avevo pensato di fare questa conversazione con voi già due anni fa, quando ho iniziato a tradurre, ma l’aura del libro mi aveva un po’ scoraggiata.
FP: È per iniziare. Si è sempre all’inizio quando si legge il Finnegans. Con i libri ci si sente ogni volta invitati a partire dall’inizio, pur se nel caso del Finnegans questa operazione automatica potrebbe essere rischiosa. Anche noi che l’abbiamo tradotto, e ci siamo immersi in questa oscurità, continuiamo a ogni nuova apertura di pagina a trovare degli etimi nuovi, dei sensi nuovi: non hai mai finito di leggere, ricominci sempre, è una lettura sempre iniziale, iniziativa – e secondo me ne derivano due conseguenze. La prima, e su questo ha battuto molto spesso Enrico anche nei suoi saggi, in Oltre abita il silenzio e per esempio anche nell’articolo sul Tascabile, è che non c’è una luce definitiva. Non c’è veramente nessuno che può impugnare il Finnegans come un libro sacro e usarlo come un’arma di sapere, imporre la parola. Ci stiamo arrivando: una parola che si espone è una parola che circola, che muta continuamente e quindi non può essere imposta, non può imporsi. Persino chi l’ha tradotto, chi l’ha studiato per una vita, non solo è costretto, ma ha il piacere e la gioia di discuterlo con gli altri. E qui tornerei alla tua impressione iniziale, quando dicevi che due anni fa ti eri un po’ allontanata dall’idea di interpellarci. All’origine di ‘soggezione’ c’è subiectio, il subiectum, quindi soggetto, ma fa ricordare anche suddito. Qui non c’è nessun suddito. E quindi sarei propenso a pensare che questo continuo “iniziare” con il Finnegans ti permette di sentire una vertiginosa apertura al senso, ai sensi possibili. Tra l’altro, proprio Nabokov usava la metafora bellissima del tennis rispetto all’uso della lingua: “il mio inglese è semplicemente un servizio, quello di Joyce è una partita intera”. Sul Finnegans diceva anche che è “il dialetto del genio”, e in questa visione il dialetto del genio è qualcosa di singolare, di troppo personale, quasi un idioma unico. Ma se noi, per la natura stessa del libro, siamo felicemente costretti a parlarne, a esporci, a mettere in comune il suo attraversamento, questo nostro dialogo diventa un’esperienza di traduzione, anzi – come dicono alcuni critici, diventa parte del testo originale. È un corollario del testo originale, addirittura. Vediamo tanti satelliti-traduzioni che orbitano intorno al pianeta oscuro che è Finnegans Wake.
ET: Sì diventa un’escrescenza del testo originale. La critica filologica ci ha un po’ abituato all’idea che il testo sta da una parte, immutabile, mentre le letture sono provvisorie. In realtà il testo non esiste senza le letture; e quindi il testo sono le letture, sono le traduzioni. Con questo libro Joyce riesce a far sì che tu lettore sei autore del testo, traducendolo nella tua mente. Succede con pochissimi libri, succedeva in parte con l’Ulisse, ma con il Finnegans si rende conto di non essere più il padrone delle sue parole. È questa la grossa lezione democratica che ci dà. È banale da dire, ma ogni volta che leggiamo un libro o ascoltiamo una canzone quella diventa nostra, altrimenti non sarebbe importante per noi.
Finnegans fa questo, chiunque ci vede quello che ci vede. È scritto in così tante lingue che se tu non maneggi sette lingue, certe cose non le vedrai mai. Per esempio ci sono le annotazioni, ci si aiuta fra colleghi – ma quanta roba non è stata ancora vista? Quante lingue non sono ancora state viste? Se mancano gli studiosi cinesi, tutta una parte cinese non verrà registrata. È un libro unico nel senso che è unico per ognuno, ognuno ha un libro diverso. Forse questa è la cosa che da un po’ fastidio agli scrittori invece più normali – non che Nabokov fosse normale – ma significa scrivere un’opera che non è più tua. È l’estrema libertà.
Come vi siete avvicinati al Finnegans per la prima volta? A pezzi, leggendolo dall’inizio (se vogliamo chiamarlo inizio considerato che l’incipit è una frase che inizia a metà…)
ET: Le tante volte che l’ho letto non è mai stato dall’inizio alla fine. Tanti anni fa lo ascoltavo, perché quando stavo a Dublino c’erano i reading groups, gruppi di persone che leggevano ad alta voce. Ascoltandolo magari notavo che c’era un po’ di italiano. Poi ho visto un po’ di spettacoli e ho iniziato davvero a leggerlo pochi anni fa, però mai dall’inizio alla fine. Perché non è un libro che funziona così. Ogni inizio di capitolo è un inizio del Finnegans, ci sono tantissimi collegamenti tra le varie parti, ma non c’è una coerenza narrativa unica, ci sono tante coerenze, tanti personaggi che si fondono, un personaggio principale che si sviluppa in tanti suoi avatar… è sempre uguale e sempre diverso, non cambia niente quando sta nella preistoria e quando invece arriva ai giorni nostri.
FP: Io l’ho approcciato in traduzione. Nei primi anni novanta, negli Oscar Mondadori, ristamparono il primo volume della traduzione di Luigi Schenoni, che è stato il primo traduttore italiano ad aver iniziato questa impresa in modo esteso, con l’idea di tradurre tutto il libro nel corso di 20/30 anni. Chiaramente sono rimasto sconvolto. Poi sono andato in gita scolastica a Parigi e ho fatto il pellegrinaggio alla Shakespeare and Company – naturalmente non era più la sede originale, quella della libreria di Sylvia Beach (chiusa dai nazisti nel 1941, secondo alcuni, perché aveva rifiutato di dare l’ultima copia di Finnegans Wake a un ufficiale tedesco), ma quella nuova, vicino a Notre Dame. E là entrando c’era il banchetto con tutto Joyce della Penguin; stava lì, insomma mi ha chiamato.
Però non è che apri e leggi immaginando di capire tutto, né la metà di tutto, sarebbe una follia. Salti, saltelli e saltabecchi (per dirla con Zanzotto). È sempre per iniziare, per iniziare e per poi ritornare, perché ogni nuova lettura, ogni nuova visione è una revisione. Ti accorgi che qualcosa l’hai già visto, ma vedi anche qualcosa di nuovo. C’è una bellissima frase di Michel Butor, che negli anni Sessanta ha scritto uno dei saggi più partecipi, più appassionati sul Finnegans: dice che la pagina del Finnegans è come uno specchio che muta continuamente, a ogni lettura vedi un nuovo ritratto di te, della tua faccia in quel momento del tempo. Poi tradurlo, immaginare di tradurlo, è una nuova e più profonda lettura. Però ha sempre delle verifiche collettive. Sempre dei punti di domanda, degli uncini proiettati verso l’esterno, verso gli interlocutori che sono gli altri.
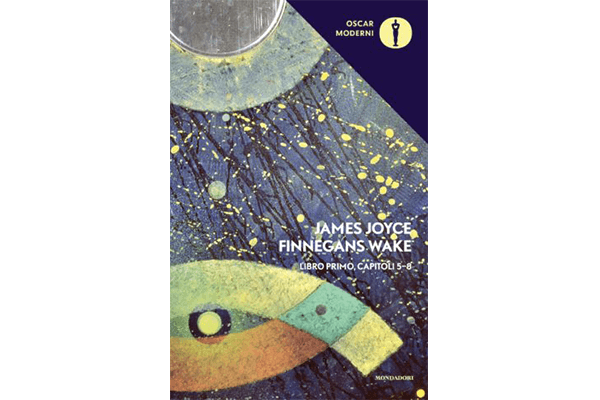
È come se la lettura del Finnegans fosse un esercizio di intelligenza collettiva…
ET: Sì, e poi è un libro che non finisce. In molti scherziamo sul fatto che Joyce fosse un po’ profetico, perché nel Finnegans c’è talmente tanta roba che sembra ci sia tutto. Dopo le elezioni americane, ho messo su Twitter una frase in cui Joyce chiaramente parla di Trump, scrive: “Trump adieu atout atous”. Gli ha dato l’addio. L’ho messa come scherzo, qualcuno l’ha presa e l’ha messa su Facebook ed è partito un thread lunghissimo di persone che leggevano la frase e la interpretavano. Per esempio atout, che sembrerebbe francese, se lo leggi in inglese diventa “a tout”, che significa anche imbonitore, tipo Berlusconi. Il Finnegans ci insegna che leggiamo sempre i libri del passato come se potessero cambiarci il futuro. Le scritture sacre si leggono così: non si legge il Vangelo per dire quanto è bello, ma perché insegna ad agire, cosa fare e cosa non fare. I comandamenti non servono a essere ammirati, ma a dare una direzione. Tanti libri funzionano così e Joyce ha creato questa possibilità in maniera divertente. Dentro il Finnegans c’è Salvini, Totti. È un libro che non può finire, perché non sai mai bene cosa ha detto nel senso che avendo detto tante cose all’unisono, assegnare una priorità diviene difficile. Se atout può essere alla francese oppure a tout all’inglese, capisci bene che…
FP: Attenzione, perché l’atout nel gioco del bridge è anche il seme che vince. Quindi l’interpretazione non finisce qui, tiro fuori anche questa carta. Tradurre può essere un ponte, una carta gettata sul tavolo, un gioco attento.
Parlando con voi questo aspetto giocoso emerge fortissimo. Anche nei saggi e nelle note di traduzione usate la metafora del telefono senza fili per spiegare il processo di metamorfosi usato da Joyce sulla parola, parlate di allegria della lingua. È una cosa che ha guidato la vostra traduzione o che avete scoperto traducendo?
FP: Il fatto è che le parole del Finnegans sono inventate. Chi inventa le parole? L’altro giorno alla trasmissione Maestri di Edoardo Camurri c’era Franco Lorenzoni: diceva che i bambini hanno un pensiero complesso, allora perché gli adulti non riescono a comprenderli? Perché gli adulti hanno paura di non dire la cosa giusta. Chi si inventa le parole sono i bambini. Non solo: gli studiosi, gli scienziati… i poeti. La sfida della conoscenza ci spinge verso l’ignoto – del resto Rimbaud, Baudelaire ci dicevano di andare verso il nuovo, la visione, che però è anche un inconnu. Qualcosa che non abbiamo mai conosciuto prima. E quindi inventarci le parole ci serve come il pane. Quello che disattende le attese fa ridere, è come un inciampo; ma fa anche digrignare i denti, è violento.
Questo per dire che serve uscire fuori da ciò che è già stato detto, dalla parola già imposta, quadrata. È la parola del potere, che ci vuole tristi; la boria di ciò che è dato, delle cose che sono così come sono. Chi ride in realtà cerca di sgusciare via da queste maglie. Probabilmente questa joyicity, una parola cardinale nel Finnegans, noi ce l’avevamo già, e l’abbiamo rimessa in gioco. È stata una traduzione fatta molto dal vivo perché questa lettera morta doveva diventare parola viva.
ET: Quando in Irlanda lo leggevamo nei reading groups si rideva spesso, proprio perché nell’errore c’è qualcosa di buffo. I critici parlavano della necessità di fare una battaglia per fare capire alla gente che Joyce fa ridere, poi però quando parlavano alle conferenze e ai convegni ti facevano due palle assurde e quindi distruggevano la risata. Mi ha sempre dato fastidio, perché davvero il Finnegans fa ridere, come anche l’Ulisse. È un riso amaro, è il riso dell’esorcismo, del cercare di allontanare un po’ la morte. Ma se il riso nasce dalle parole, le mette in connessione. È questo che fa Joyce, crea delle connessioni inaspettate. Il punto fondamentale è che le parole non sono messe lì per restare quello che erano, sono malleabili e sono corruttibili, perché le lingue nascono dalla corruzione non dalla perfezione. Noi nasciamo dall’errore, secondo i testi sacri della tradizione giudaico-cristiana l’umanità nasce dall’errore, dallo sbaglio. Joyce capisce che l’errore è produttivo; sì, ti ha condannato ma allora tanto vale ridere. Se siamo troppo seriosi uccidiamo la risata che fa resistere, la risata divina.
Quindi niente scene di disperazione, perdita della ragione? Ci si immagina l’impresa di tradurre un libro intraducibile come un’esperienza tragica.
ET: Sì, direi che noi ci siamo divertiti. Tranne quando Joyce fa delle tirate lunghissime, quando si fissa per dire sugli insetti e ne parla per dieci pagine. A tradurre dieci pagine ci metti un mese e mezzo. Quindi una parte d’incavolatura c’è, però ogni tanto è molto divertente. Per esempio noi ridevamo tanto quando trovavamo le soluzioni. Ci arrovellavamo per ore e ore, poi dopo uno di noi – di solito Fabio – se usciva con la soluzione che faceva un sacco ridere. Mi ricordo proprio risate irrefrenabili, perché tiravi fuori la parola buffa. La maggior parte sono sconce, oscene.
FP: Eh sì, l’osceno e il represso risalgono alla luce.
ET: Molti dei giochi sono sessuali. Per esempio c’è un detto irlandese che fa ridere ma non ti saprei spiegare perché. Se qualcuno dice “to have the painters in”, cioè avere i pittori in casa, significa che una donna ha le mestruazioni. Che ci fai in italiano? Se lo traduci così non viene bene. Noi dovevamo cercare una resa divertente e alla fine l’abbiamo trovata con una parola toscana, con una frase tipo “quando ti si pitta la potta”. Anche qui, maschilista, quello che vuoi, però fa ridere perché la lingua crea delle assonanze buffe. Ora è ovvio che se uno si sofferma criticamente sul perché Joyce ha messo queste frasi potrebbe tranquillamente scrivere un saggio sul fatto che è maschilista, misogino – cosa non vera perché in tantissime altre parti gli eroi di Joyce sono delle donne. Gli eroi uomini come Bloom sono uomini molto femminili. Tantissimi critici invece devono dimostrare delle tesi, dire che Joyce è una cosa oppure un’altra. Invece Joyce è più o meno tutto, una cosa e pure il suo contrario, al contempo. Questa è importante come lezione di vita: nel sogno emergono conflitti che però non sono fastidiosi. Nel sogno convivono, nella vita vegliante no.
FP: Sì, poi questo carnevale anche molto corporale ha un senso, perché quando si sciolgono le gerarchie – se è un sogno, se è liberatorio, queste parole escono dai loro righi, siamo sopra le righe, sotto le righe, in mezzo alle righe, è tutto un’effervescenza. È l’immagine dello champagne, delle parole come bollicine usata da Beckett nel primo saggio davvero importante sul Finnegans, scritto peraltro dieci anni prima della sua conclusione. Significa che tutto ha la stessa dignità, possiamo parlare di metafisica, di trascendentali, di teologia, andare a cantare una canzonaccia al pub o leggere le scritte sui muri nei bagni, ma tutto ha la stessa dignità, perché tutto è mondo. L’oscuro che la luce cancella e caccia nel fondo riemerge prepotente. A me fa pensare un po’ alla dodecafonia. La grande rivoluzione musicale del Novecento è stata dare la stessa dignità a tutte le note, provare a metterle tutte in circolo. Chiaramente l’effetto è una liberazione delle dissonanze: da lì in poi l’armonia classicistica, dell’ordine e della misura, va a farsi benedire perché in una ricerca espressiva come quella joyciana tutto è atonalità e disarmonia, è “mostruoso”: il centro non c’è. Noi possiamo provare a dare una sensazione di quello che succede, una breve ricreazione – non vorrei dire rispecchiamento perché gli specchi sono anche deformanti. Tornando all’esempio di Enrico, una critica “ordinata” potrebbe dire “qui Joyce ha usato una locuzione popolare standard, perché voi inventate?”. Perché dietro c’è il riso, siamo dentro un pub all’ora della chiusura in cui sono tutti ubriachi e ogni parola pronunciata è una piccola esplosione di risate. L’alcol rinfranca, il riso affranca. Se ci pensiamo, la traduzione è una parodia seria in un’altra lingua; un plagio in rispetto dell’autore.
ET: È lo statuto della scrittura che cambia. Mentre ci sono scrittori che si sentono scrittori, pensano di avere una sorta di missione e si prendono molto sul serio, Joyce era uno scrittore serissimo, lavorava come un matto – ci ha perso la salute, se guardi le sue foto di quando è morto a 59 anni, sembrava un novantenne – lui non si prendeva sul serio. Voleva svelare i trucchi, demistificare. Joyce prende la Bibbia e la riscrive, prende le parole e cambiando una consonante trasforma fratello, brother in bordello, brothel. Così facendo crea un mondo, poi quel mondo lo riempi tu.
FP: Mi hai fatto ricordare un’altra cosa che abbiamo tradotto, sempre su ‘fratello’. L’espressione standard era qualcosa tipo “brother of mine”, ma Joyce la trasformava in “other of mine”, l’altro da me, o il mio altro. Noi abbiamo tirato fuori “fratellaltro”.
Bello!
FP: È una provocazione. Il lettore di Joyce non è neutro, non sta mai comodo, è continuamente provocato a decidere. Si può anche dire che il libro mette in scena il dramma dell’interpretazione, proprio come nel gioco del telefono senza fili. “Come ha detto? Ha detto pacifico o specifico?” Ti ricordi, Enrico? Francesco Pacifico disse che il nostro era un tour de forse. Eh sì, perché fluttui nell’incerto. Sì, è sgradevole, ed è rischioso. Lì devi studiare, ma sei pur sempre tu che a partire da quello studio devi co-scrivere, “co-autorare”.
ET: Certe volte ti va bene, certe volte no. Bisogna accettarlo. Joyce parla sempre di fratelli, di incesto, e a un certo punto ci sono questi due fratelli e la parola “siamese” scritta “soamheis”, “così sono come lui è”. Mi sembra che noi abbiamo tradotto “fratello siamio” che funziona in due modi: “fratello sia-mio” che “fratello siam-io”. Ora, un lettore normale magari non se ne accorge, ma se lo legge come si legge l’originale può scomporre la parola e scoprire che funziona in tanti modi. Molto spesso abbiamo nascosto i significati nelle sillabe. La scrittura di Joyce funzionava così: prendeva tanti significati e li comprimeva, poi spostando una consonante, una vocale, cercava di produrre altro.
Non riesco a immaginarmi bene nemmeno come si costruisce il lavoro, in coppia, su un’opera del genere. Nella pratica, come vi siete organizzati per tradurlo, giorno per giorno?
ET: All’inizio facevamo quattro pagine ciascuno, molto annotate a margine, poi ce le scambiavamo. Non potevamo fare un capitolo io e un capitolo lui, altrimenti avremmo perso il filo, così lavoravamo su parti molto vicine e le annotavamo fittamente. Così, quando poi ce le passavamo, l’altro riusciva a ricostruire dai commenti le cose fatte. Perché comunque se metti a confronto originale e traduzione non è sempre facile capire cos’è avvenuto. Non è che una parola sta a una parola, certe volte il significato si scompone ed è disseminato in varie righe. Poi ci incontravamo de visu e facevamo sessioni molto lunghe, dalle dieci di mattina alle sette di sera, cose così.
FP: Sì perché l’aspetto della presenza, in questo tennis di parole, domanda e risposta, era importante. Come facciamo? Bisogna prima disfare e poi rifare. Allontanandosi, lasciando che le parole e i suoni giochino, si crea una nube di scelte potenziali: “fratellaltro, fratellastro”? In fratellastro c’è dentro la stella, “astro”, assuona con “fardello”, poi rimbalzi su “frastello”, ma non va, siamo troppo fuori dal cerchio, allora “fratellaltro”, oppure perché non “fraltrello”? Colpisce più bersagli, no? È una dinamica che partiva in un certo territorio, un po’ tra Bergonzoni e Fosco Maraini. Per evolversi dentro le possibilità di una lingua come l’italiano il cui padre è un supremo inventore e sperimentatore come Dante, e che nel Novecento ha visto gli azzardi furibondi di Amelia Rosselli, di Emilio Villa. Ci aggrappavamo a una serie di stimoli iniziali, però poi avevamo bisogno di staccarci altrimenti la pagina rimaneva fissa, inchiodata, e arrivava la disperazione. Non puoi pensare di stare otto ore su ogni riga.
ET: Sì senza questi confronti sarebbe stato noioso e anche infruttoso, perché nella stragrande maggioranza dei casi i testi sono cambiati tantissimo. Non mi ricordo bene neanche cosa ho tradotto io oppure lui, non saprei nemmeno distinguere.
E quanto ci avete messo?
FP: Sei anni e mezzo.
ET: Per duecento pagine eh, un libro normale lo fai in quattro mesi.
Sei anni e mezzo per duecento pagine è più di un lavoro normale. Avrà plasmato le vostre giornate intorno alla traduzione, forse cambiato il vostro modo di pensare. È stato un sollievo finirlo o ne sentite la mancanza?
FP: Be’, il sollievo c’è stato, inutile negarlo. C’era questa stanchezza dell’aver fatto, davanti al (forse) compiuto. Non era solo la stanchezza dell’artigiano che ha fatto la sua sedia, del suo lavoro che è (per il momento) finito – senza esser mai finito, anzi, direi… è sfinito. Nessuna idea di placamento, men che meno di trionfo, insomma: c’è anche la sensazione beffarda di aver solo sfiorato qualcosa di inesauribile. Un po’ come dice Bergonzoni: il Finnegans non lo tieni sul comodino, neanche sotto il comodino, ma rimane lì che fluttua a mezz’aria. Quanto a me… da quando abcdiamo infinito di estradurre il Sinneganf ho inniziato a parleare uma langua di barbarole oscule, inincertosennso… lee more touchy low row!
ET: A me un pochino manca, era un bel modo di passare le giornate. Poi i due libri del Finnegans che abbiamo tradotto noi non erano spiegati bene dalla critica, che si è concentrata più su altre parti. C’era e c’è tantissima roba ancora oscura. Prima dello sforzo traduttivo c’era quello di comprensione, interpretativo. Mi ricordo benissimo che certe notti stavo lì a cercare di capire un’espressione, poi alla fine ti arrivava l’illuminazione e il giorno dopo ci lavoravi. Con questo esercizio mentale, quando andavi al pub ti eri meritato le pinte.
Il modo di pensare l’ha cambiato, sì. Fa delle connessioni che non ti dico ti fanno diventare più intelligente, ma più veloce, ti fanno accettare le cose più distanti. Funziona quasi come internet. A me ha fatto cambiare modo di scrivere, i miei saggi, gli articoli sono tutti scritti in quest’ottica, la parola non dev’essere mai ferma, deve lasciare un alone.