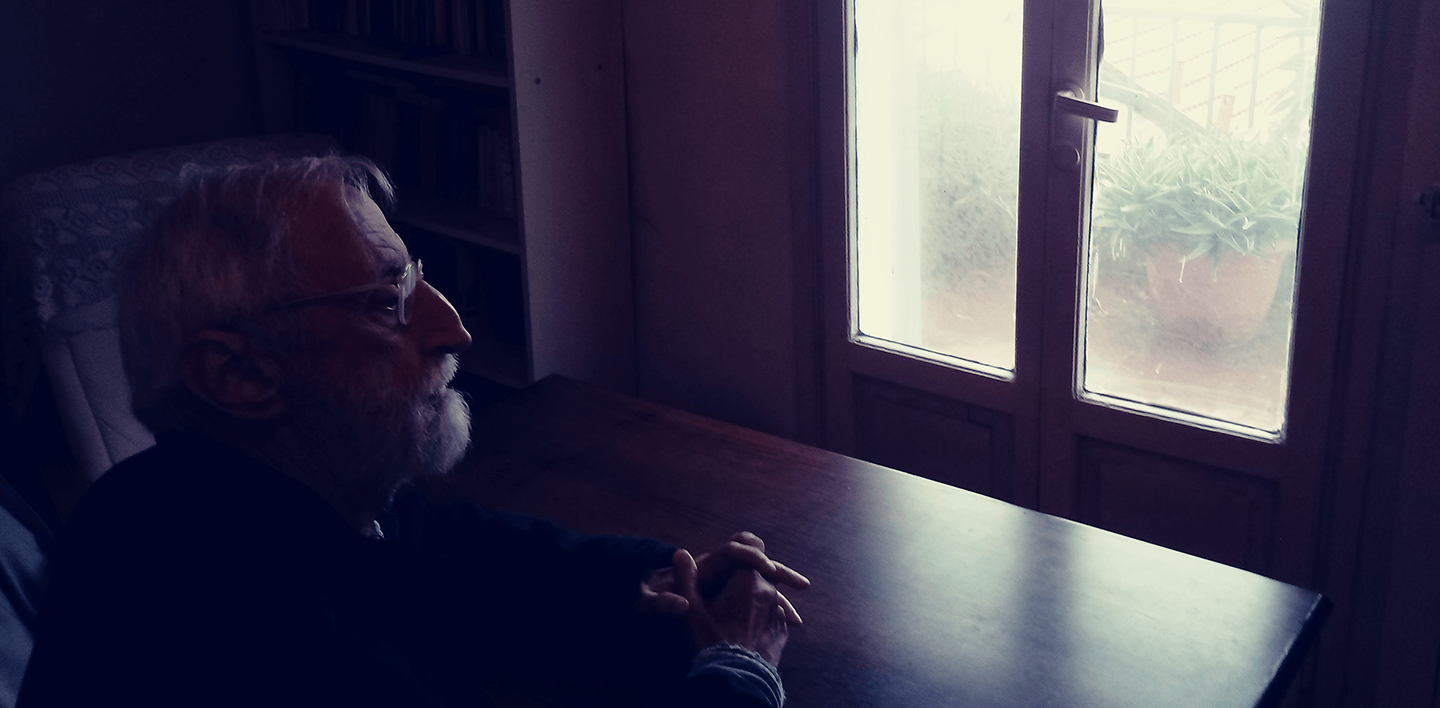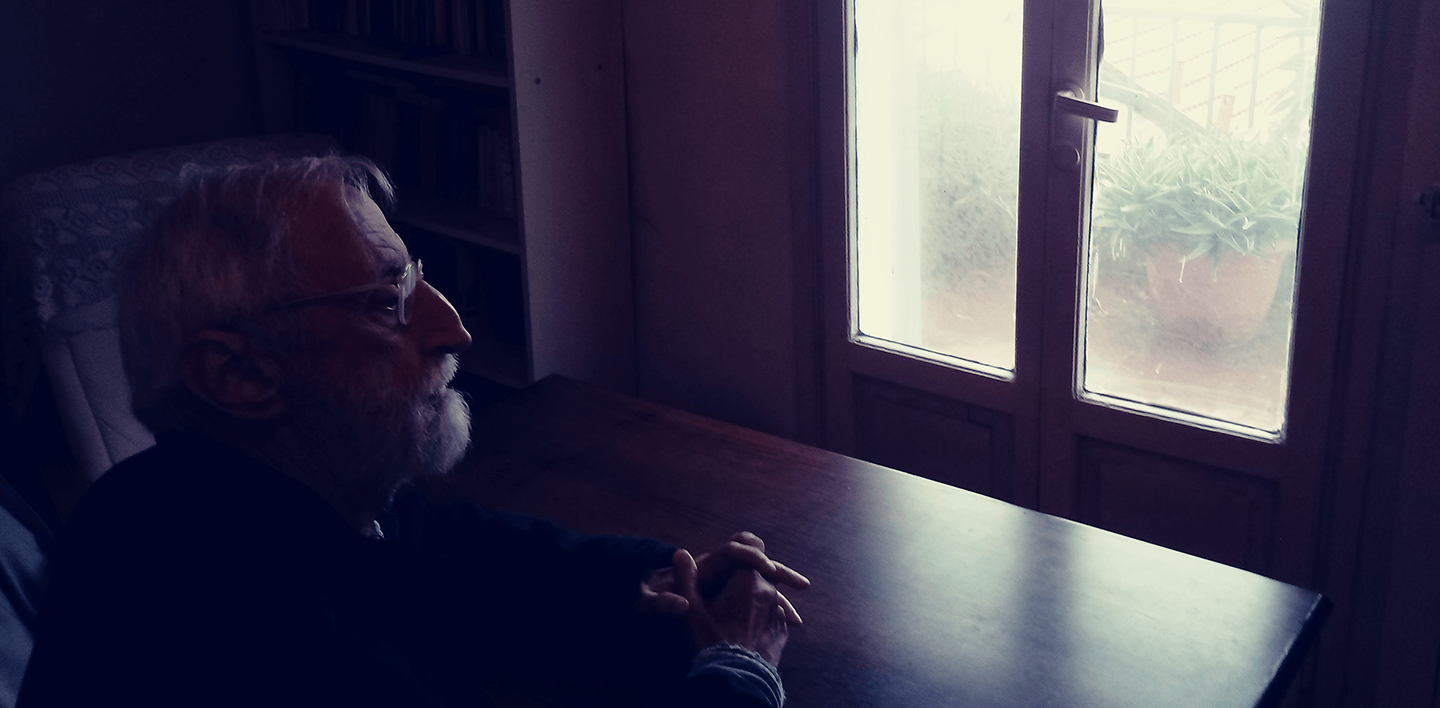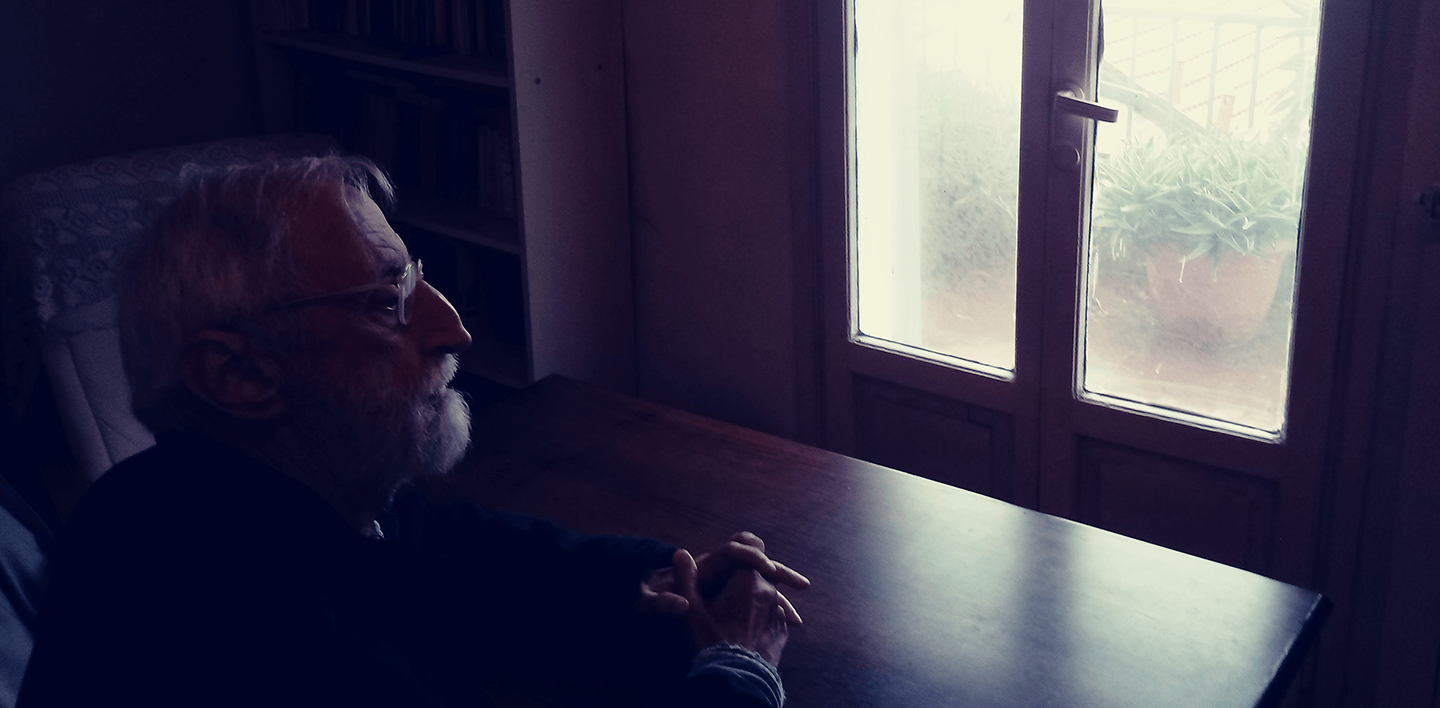D
opo L’addio, del 2016, considerato all’epoca un romanzo di congedo, Antonio Moresco si rimangia fortunatamente la parola e da quel romanzo riparte regalando ai suoi lettori un nuovo romanzo, un testo triplice e potente, Canti di D’Arco. Con Moresco abbiamo parlato della sua infanzia, dei libri letti e di quelli detestati, e di quel suo viaggio solitario nella scrittura che negli ultimi anni si è fatto un po’ meno clandestino.
Quando ha iniziato a scrivere? A sentirne l’urgenza e la necessità?
In realtà ho cominciato a scrivere prima dei vent’anni, quando stavo ancora a Mantova. Avevo cominciato a scrivere perché mi ero innamorato della letteratura, l’unica strada che avevo trovato a scuola in un momento di forte difficoltà di apprendimento. Così ho cominciato a scrivere e ho scritto anche parecchio: moltissime poesie, molte pagine di diario, racconti e anche qualche breve romanzo. Tutte cose che ho buttato via a vent’anni quando mi sono buttato dentro all’avventura – diciamo così – politica.
Perché ha rimosso quella parte di sé durante quel periodo?
In quel momento ho rinnegato questa parte di me che percepivo come la parte sensibile, la parte da uccidere, come fosse una debolezza che dovevo strappare. Poi chiaramente per tutti quegli anni c’era una costrizione che diventava anche auto-costrizione a leggere tutta la realtà che avevamo di fronte attraverso uno schema ideologico che allora ti dava l’idea – o meglio ancora, l’illusione – di spiegarti tutto. Ho spostato le mie letture dai poeti, dagli scrittori che amavo, verso tutti i libri politici e ideologici. Però evidentemente quella parte di me stesso per quanto conculcata e rinnegata restava da qualche parte dentro di me, irriducibile.
Sentiva montare dentro di sé una forma di disagio rispetto alla cultura politico-ideologica dell’epoca?
In quegli anni tutto veniva riportato a una spiegazione che aveva un carattere sostanzialmente orizzontale, economico e sociale che s’imponeva di spiegare tutto. Poi, a poco a poco, questa spiegazione mi si è rivelata essere solo la punta di un iceberg che aveva sotto di sé un corpo ben più grande. Sotto il livello dell’acqua c’era tutto il resto, una massa ben più grande che restava invisibile.
Un limite enorme di visione politica e culturale?
Non a caso da questa forma di cecità deriva probabilmente il fallimento delle rivoluzioni politiche del Novecento, perché si scambia una parte per il tutto e si pretende di dare delle spiegazioni esaustive a una realtà che è molto più complessa di questo. Una realtà che ritorna all’arcaico, a tutto ciò che è stato cancellato e forzatamente rimosso.
Era anche un’esperienza collettiva, di gruppo.
In quegli anni ho vissuto in gruppo sì, ma per me era una sorta di violenza: per il mio carattere che era portato a stare da solo… lo vivevo come una colpa. C’era in me anche questa forzatura. In un gruppo ci sono alcune persone che ricordi in modo positivo, e altre che – spesso sono la maggioranza – di cui non hai un buon ricordo. Probabilmente come in qualunque mestiere, capita così anche a chi lavora in banca o in qualche ufficio o redazione.
Come provava a risolvere questa forma di forzatura?
Il fatto di dover essere per forza intruppato a me costava e anche molto. E così ho iniziato a bere parecchio, che è poi una maniera per cancellare queste forme di rifiuti interni, questa difficoltà a sciogliersi dentro alla collettività che seppure interpretata in senso antagonistico resta fortemente una collettività normalizzante. Questa partecipazione collettiva è stata per me una fatica, ma del resto era tale la convinzione di essere dentro un qualcosa che ti dava una spiegazione del male e del dolore che c’è nel mondo che lo accettavo, come anche altri, come fosse un prezzo da pagare. Poi, quando ti rendi conto che quella visione non dà per nulla una spiegazione esaustiva, allora sì che quel prezzo diventa inaccettabile da pagare.
La sua sembra essere una forma di clandestinità che supera quella politica, una sorta di clandestinità arcaica, irriducibile?
Oltre a quel periodo di militanza politica, ho avuto anche un’infanzia molto particolare. Mia madre veniva da un paesino della bassa mantovana, da una famiglia miserrima. I suoi fratelli si sono sparpagliati subito giovanissimi in cerca del pane, di qualche lavoro. Io non ho nemmeno mai conosciuto mio nonno, so che faceva piccoli lavoretti in campagna, ma che era anche malato e che la nonna aveva continui attacchi epilettici. Così mia mamma è andata a bussare alla porta di una villa di nobili a San Prospero. Era la stessa villa dove poi Bertolucci ambientò Novecento. Mia madre venne così assunta come servetta dai nobili ed io crebbi in quella casa, ma in una posizione strana; non ero loro nipote, ma li consideravo come dei parenti. Si immagini poi il mio stupore al cinema quando rividi i luoghi della mia infanzia abitati da Gerard Depardieu e Robert De Niro, tirai un urlo in sala per lo stupore.
Quei luoghi tornano nei suoi libri?
Certamente, gli ambienti che si vedono nei miei libri, nel racconto La camera blu, così come nella prima parte de Gli esordi. Quelle che sembrano delle costruzioni fantastiche, case con stanze enormi sono in realtà le stanze nobiliari in cui ho vissuto seppure con il mio statuto strano che poi era appunto una forma già di clandestinità.
Ha sempre vissuto a Mantova da ragazzo?
No, successivamente ho avuto un lungo periodo di tre anni in cui sono stato mandato a Bergamo in seminario. Anche in questo caso ho vissuto un periodo di grande sradicamento dalla famiglia e pure di forte isolamento. Non sopportavo le pratiche collettive come le partite di pallone il conseguente obbligo forzato alla socialità che per me restava insopportabile. Mentre l’estate lo passavamo in campagna in un orfanotrofio della congregazione nel paese di Martinengo, tra l’altro anche nei luoghi qui dove Olmi girò L’albero degli zoccoli.
Dicevamo: il ritorno alla scrittura.
Sì, torno alla scrittura intorno ai trent’anni. E comincio a scrivere nel posticino dove mi trovavo allora, fuori Lambrate, un monolocale in affitto. Scrivevo di notte ed è lì che ho cominciato a scrivere su un quaderno quello che sarebbe diventato Clandestinità (Bollati Boringhieri, 1993). Clandestinità era formato da tre lunghi racconti, uno che dava il titolo alla raccolta, poi La camera blu e La Buca.
Collega subito alla sua scrittura l’idea di pubblicare?
Scrivevo senza pensare, non ci pensavo all’idea di pubblicare, anche perché non avevo conoscenze nel mondo letterario editoriale. Da ragazzino avevo avuto enormi difficoltà di apprendimento a scuola, e poi non avevo fatto l’università, in pratica non conoscevo proprio nessuno. Inoltre i dieci anni di militanza politica mi avevano messo in una posizione di sradicamento assoluto.
Come nasce Clandestinità?
Ho scritto Clandestinità perché era proprio la condizione personale in cui mi trovavo, farlo ha significato non perdere più quel filo che avevo abbandonato e che era l’ultimo a potermi tenere attaccato alla vita. I racconti di Clandestinità erano così dominati dalla dimensione della solitudine, dell’isolamento, dell’anelito di una luce, di una strada, di un passaggio per la vita. Esprimevano la situazione di buco nero in cui mi trovavo a quel punto della mia vita.
Lei era alla ricerca di una solitudine perduta?
In particolare il racconto di Clandestinità è la storia di un uomo che si sposta, che fugge anche se non viene detto da cosa. Io stesso quando sono uscito dalla militanza non volevo farmi più raggiungere. Non avevo telefono in casa e vivevo realmente in quella che si può definire una situazione di clandestinità. Così il protagonista del racconto si sposta da una città all’altra da una casa all’altra fino ad approdare in un appartamento che ho descritto esattamente come quello in cui mi trovavo: un appartamento che viene messo a disposizione del protagonista del racconto da un tizio che ha conosciuto in passato, salvo poi tentare di invaderlo. A questo punto tra i due avviene combattimento molto cruento. e io in quei giorni, in quei mesi avevo anche ricominciato a leggere, perché avevo bisogno di leggere tutto ero ancora fermo alle cose scolastiche.
Cosa leggeva in quei giorni?
L’Iliade, in particolare, uno di quei libri che mi ha sconvolto e incantato. In quei giorni e poi in quei mesi avevo bisogno di leggere di tutto, consideri che ero ancora fermo alle cose scolastiche dei vent’anni.
È ispirato dall’Iliade?
La scena del combattimento in Clandestinità è proprio non a caso una scena da guerrieri omerici. Così come la scena successiva, ancora più cruenta che segue il combattimento e che vede lo squartamento e il lancio dei pezzi dell’uomo nella finestra della donna con cui il protagonista scambia sguardi ha per me il significato di nascita come scrittore.
Trova così una sua lingua che non è più quella dei vent’anni, dei primi scritti.
Certamente, dovevo attuare una rottura per comunicare la situazione in cui mi trovavo, dovevo inventarmi una forma. Scrivevo su questo mio quaderno con grandissima difficoltà. Era come se muovessi i primi passi dentro ad un bosco di cui non sapevo nulla. Dovevo cercare il modo per comunicare questa diversità. E la lingua che stavo trovando era molto molto lontana da quella che mi ero lasciato alle spalle da ragazzo.
In quali letture si immerge in quel periodo?
Mi ricordo che siccome ero ignorante e dovevo imparare tutto usavo dei metodi anche molto semplici: non avevo maestri, non avevo insegnanti, non avevo nulla. Sui giornali uscivano queste rubriche o segnalazioni del tipo: I cento libri indispensabili, I libri che bisogna leggere, cose così. Io vedevo questi elenchi, li ritagliavo e mi leggevo tutti i libri indicati uno dopo l’altro. Alcuni erano davvero molto interessanti e mi incantavano, altri invece più che altro le fissazioni di coloro che di volta in volta avevan compilato questi elenchi, spesso dei titoli totalmente assurdi. Ma era comunque per me una continua scoperta.
Da cosa parte?
Parto da zero, da Omero, poi gli storici greci: Erodoto, Tucidide, Senofonte, gli storici latini. E poi ancora i tragici greci, i lirici. Di quei libri mi ricordo che mi hanno incantato l’
Iliade – mi sembrava davvero che raccontasse com’è il mondo, o almeno, come lo avevo conosciuto io – e poi mi hanno incantato
Le storie di Erodoto, moltissimo. E poi ho amato Leopardi, un autore per me fondamentale, non solo per la lirica ma anche tutto il resto, a partire dallo
Zibaldone.
Mi erano piaciuti molto ovviamente anche i grandi romanzieri, alcuni in particolare mi rimasero molto impressi. Ricordo I viaggi di Guliver, la scrittura di Swift… Poi i francesi: Stendhal, Balzac, e gli amatissimi Dostoevskij e Kafka.
Tra la letteratura italiana?
Degli italiani mi piaceva molto Dante, non solo la Divina Commedia ma anche la Vita nova – che è un libro meraviglioso e rivoluzionario che inserisce prosa, poesia e la propria esperienza personale trasfigurata. Già solo il titolo Vita nova è un titolo pazzesco. Poi sempre di Dante le Rime e il saggio De Monàrchia, un testo che una volta che viene decodificato dal suo contesto si mostra attualissimo e fondamentale. E poi in quel periodo mi piacevano molto anche i libri che stavano su un crinale oltre la letteratura canonizzata come La vita di Benvenuto Cellini. Come anche in un certo senso Le lettere di Vincent Van Gogh, che per me fu un libro fondamentale, un mio libro di vera resistenza interiore e spirituale. Poi leggevo molto anche le mistiche, in particolare Teresa D’Avila.
Autori del Novecento?
Sempre di italiani ho molto apprezzato Italo Svevo, Federico Tozzi… e sicuramente Primo Levi.
Manteneva una sorta di distanza rispetto ai suoi contemporanei?
Sì, un po’ si. Di quello che usciva in quegli anni non ho letto praticamente niente, aiutato anche dal fatto che dovevo “recuperare il tempo perduto”. Nella mia solitudine mi sono così confrontato con persone che scrivevano duemila anni fa come se fossero i miei contemporanei e questo probabilmente ha creato uno scarto forte rispetto al mio tempo. Forse anche per questo quando ho cominciato a proporre agli editori i miei scritti per quindici anni mi hanno detto di no, come se fossero libri non aggiornati, avulsi rispetto al dibattito.
Quindi i contemporanei restavano sullo sfondo rispetto alla sua formazione?
Sì. Certo da ragazzo avevo letto gli scrittori di cui si parlava, che erano Moravia, Pavese, Bassani e lo stesso Primo Levi. Però per me restavano sullo sfondo.
Lei esordisce con Clandestinità nel 1993, il mondo editoriale, quello degli anni Settanta, Ottanta sta lentamente declinando, come lo ha vissuto?
È stata una cosa particolare, perché per l’appunto io ho vissuto come miei contemporanei scrittori di 2000 anni prima di 500 o 200 anni prima, per cui quando ho messo un pochettino la testa fuori e ho visto quale era l’aria e l’andazzo ho preso una botta fortissima. Quelli erano gli anni dell’idea mistica della letteratura e così mi sono trovato subito a confliggere con quel mondo. Da una parte scrivevo, ma d’altra dovevo combattere, ho cercato di esprimere questa duplice situazione nei testi raccolti in L’adorazione e la lotta (Mondadori, 2018): se da una parte adoravo la grande letteratura, dall’altra ero costretto a lottare per poter continuare ad adorarla.
Un conflitto obbligatorio?
Entrare in relazione anche conflittuale con lo spirito del tempo mi sembrava una questione di vita o di morte. Avevo scritto anche un pamphlet, Il paese della merda e del galateo (1998), con cui me la prendevo non tanto con Calvino, ma con il calvinismo, con Le lezioni americane e con queste regole stabilite su se stesso e che tagliano fuori il 99% della grande letteratura di tutti i tempi. A me sembrava davvero una questione di vita o di morte poter dire queste cose. Ovviamente mi è stata fatta pagare perché se tu vai a toccare la maniera del tuo tempo è terribile. Magari dopo le cose si leggono e si vedono in modo diverso, ma quando ci sei dentro e vedi che tutto il mondo culturale è tarato su quella maniera e solo quella ha successo e spazio perché risponde alle aspettative o alle non aspettative dell’epoca che vi si rispecchia, se tu non non condividi quella maniera c’è poco da fare, ti ritrovi nel mirino.
Corpo contro istituzione?
Non mi sono reso conto che non si potessero dire certe cose, argomentandole naturalmente. Non pensavo che non venisse tollerato in un momento in cui per altro si diceva che c’era spazio per tutte le idee, ma non evidentemente per dire quella singola cosa.
Andavo anche contro alcuni miti culturali che sono proprio degli autoritratti di un’epoca, come ad esempio il mito del labirinto quale unica dimensione della vita, ma che però non era il labirinto greco, tragico, che supponeva la presenza del minotauro. Un mito quindi fortemente drammatico e veritiero da cui si può uscire solo con un gesto impensato. Lì non c’era il Minotauro e non c’erano le ali. Il labirinto veniva normalizzato, chiuso in una sorta di prigione dentro alla quale il mondo culturale si era andato a mettere. Un luogo che da una parte era malinconico, ma che in realtà era rassicurante. Si lasciava la cultura in una zona franca e chi vi stava dentro si trovava al sicuro rispetto al caos del mondo.
Ancora più emblematico risulta essere oggi il suo libro Lettere a nessuno (Bollati Boringhieri 1997; Einaudi 2008; Mondadori 2019), perché se al suo esordio quel nessuno aveva il senso di chi non risponde o non si assume le responsabilità del proprio ruolo, oggi sembra aver assunto il valore dell’assenza, nessuno risponde perché non c’è più nessuno in grado di farlo.
Con quel libro ho colto forse l’ultimo lembo di un mondo che poi si è sgretolato però del resto quello che avevo di fronte a me era un momento di assoluto isolamento e solitudine; per certi versi quindi quelle diventano anche lettere di meditazione che si sviluppano attraverso immaginari interlocutori che si sottraevano, ma quelle lettere hanno avuto anche il senso di animare un processo di coscienza interiore, dare spazio a un dramma interiore.
Come vede oggi la situazione del mondo culturale?
Adesso la situazione si è totalmente capovolta, ma non è certo migliorata. Quando ero ragazzo ricordo che gli editori pubblicavano la ventesima parte di quello che pubblicano oggi, esisteva allora una forma di selezione che aiutava a capire cosa valeva la pena leggere e cosa meno. I libri potevano essere focalizzati e scelti, poi c’erano i librai che leggevano, davano consigli mentre oggi siamo alla prateria selvaggia, una vera e propria occupazione militare degli spazi da parte delle case editrici che pubblicano molto, troppo al solo scopo di occupare militarmente i banchi delle librerie. Una logica puramente darwiniana e violenta. Allo stesso tempo i giornali fanno quello che possono e a volte meno di quello che potrebbero, barcamenandosi nel maremagnum del dare e avere; non fanno capire cosa vale e cosa no, tanto più per un giovane o una persona inesperta.
Meglio prima allora?
Prima c’erano piccole cerchie di potere culturale che decidevano e che cooptavano delle quali io non ho nessuna nostalgia, anche perché io quelle cerchie ce le ho avute contro, così come non ho nostalgia degli scrittori critici cardinali che decidevano chi fare papa e chi no. Adesso però siamo all’opposto, siamo nella dittatura del mercato e per quanto mi riguarda dovevo combattere prima e combattere adesso.
Lei è considerato uno degli scrittori più importanti in Italia oggi, ma ancora combatte?
Sì, perché da una parte ho un percorso editoriale particolare, sono passato attraverso tantissimi editori, ma non perché io sia capriccioso o avido economicamente, niente di tutto questo, ma perché mi mettevano fuori. Cambiava il direttore editoriale e mi mettevano fuori. Adesso sono passato per una questione di rapporti personali, stima e amicizia da un grosso editore come Mondadori ad uno più piccolo come SEM. Ho messo sempre al primo posto i rapporti personali, fare libri per me implica un rapporto intenso di stima, passione e di avventura da condividere. Se stai con un editore più grosso sei più esposto in libreria, pazienza, io resto sul terreno dei rapporti personali.
Però a differenza di ieri oggi il suo lavoro di scrittore è riconosciuto.
Sì, un po’ sta succedendo, ma è strano, non sono ancora poi così tanto sopportato. Forse perché per cominciare come autore non dovevo proprio nascere. Per quindici anni gli editori mi hanno detto di no e oggi quei consulenti che lavoravano in quelle case editrici oggi occupano spazi e hanno ruoli nel mondo culturale. Il fatto che io mi sia rivelato uno scrittore da buttare via di certo a molti non sta bene.
E poi il mio modo di vivere la letteratura in maniera intransigente, assoluta non va bene in questa epoca. E così dicono “ma quello chi si crede di essere”. Ma tu vai a dire ad un filo d’erba chi si crede di essere? Che cazzo, sono un filo d’erba, cosa vuoi. In generale vengo messo in una situazione difficile, spesso anche solo per sentito dire, senza che io venga magari letto per davvero da chi mi critica.
È una sorta di forma di protezione da parte di un sistema?
Sì è proprio un sistema, il bon ton di un sistema. Molti scrittori ad esempio insegnano o lavorano nel mondo accademico e quindi esiste per loro un riconoscimento reciproco; io non avevo alcun contatto con l’università, non avevo rapporti di amicizia o fratellanza diciamo professionale, ma non è che uno scrittore debba essere per forza un professore d’università. Io nemmeno l’ho fatta l’università, e così ero considerato una specie di alieno.
Diciamo che oggi un po’ di riconoscimento dal mondo universitario lo sento rispetto a prima, anche grazie al successo che viene dall’estero. In Francia ho avuto un grande riconoscimento, la Sorbona ha addirittura organizzato un convegno su di me e tutto questo in qualche modo è tornato, nel mondo chiuso italiano ha funzionato. Qualche sacca incattivita poi c’è ancora, ma diciamo che non mi lamento, per dirla con una battuta in fondo anche questo è il loro modo di riconoscermi.
Come lavora? quanto tempo scrive al giorno?
È molto strano quello che mi succede adesso: per gran parte dell’anno faccio tutt’altro che scrivere. Per mesi e mesi non scrivo perché sono impegnato nella
Repubblica Nomade. Un gruppo di persone con cui cammino, anche per più di mille chilometri. Poi in queste settimane ho concluso
L’uomo che cammina che comprendeva una performance di circa cinque ore di camminata. Tutte queste cose che sono anche fisicamente pesanti mi distraggono molto dalla scrittura, ma la cosa strana è che pur lavorando così per periodi molto brevi riesco a produrre comunque molto, e non so come ci riesca.
Come affronta la pagina bianca?
Penso molto prima di scrivere, rimugino molto nella mia testa, che ne sia cosciente o no. Quando mi vengono alcune idee mi si generano magari tutta una serie di riflessioni tre o quattro mesi dopo senza che me ne sia nemmeno accorto. Però quando scrivo ho una disciplina militare. E quando comincio a scrivere questo avviene perché l’urgenza è tale che è maturato così tanto che non posso più aspettare. Allora mi isolo e lavoro e basta.
Perché ha iniziato a camminare, intendo così tanto, al punto da trasformare questo gesto in una performance?
Ho sempre avuto questa pratica solitaria di camminare. È da quando ho 30 anni che dopo cena cammino un po’ perché allora stavo male a livello nervoso, non dormivo, non digerivo e questa camera d’aria di solitudine fatta dal camminare di notte mi aiutava a resettarmi la testa e a farmi dormire.
Poi intorno ai sessantuno anni ho lanciato questa idea ad alcuni amici: fare un cammino da Milano fino a Napoli, Scampia. Si vede che ho bisogno di fare cose esagerate, di superare i miei limiti: cosa che fa anche parte del mio modo di essere scrittore. Da allora questo gruppo di amici è cresciuto e continua a crescere.
È la prima volta che si ritrova a suo agio in una comunità, in un gruppo?
Sì, ci sono molte persone per cui ho affetto, e anche amici. Certo qualsiasi gruppo, anche il migliore di questo mondo, ha sempre un elemento di costrizione e quando questo diventa preponderante per quanto mi riguarda si può solo scappare via.
E infatti pensavo, Che stupido che sono! Come scrittore ho bisogno di solitudine e poi mi vado a mettere in una cosa che mi porta via un sacco di tempo e mi scaraventa pure in mezzo ad un gruppo di persone. Ho sempre chiaramente un po’ di difficoltà a stare in un collettivo però ho anche capito che non era una cosa in contraddizione con il mio lavoro, perché così come avevo bisogno di superare i miei limiti come scrittore avevo e ho anche il bisogno di superare i miei limiti come persona, come corpo e essere umano.
Per dire, sono andato fino a Strasburgo a piedi, ho attraversato le Alpi, io che sono tutto scassato, che ho la sciatalgia e l’ernia del disco, uno scemo. Eppure ce l’ho fatta e anche così si arriva a capire che si è in realtà più forti di quel che che noi stessi crediamo. E tutto questo non può che far bene anche allo scrittore.
Chi conosce o frequenta tra gli scrittori contemporanei?
Ho qualche rapporto e con qualcuno siamo diventati amici, anche se poi ci si vede pochissimo. Walter Siti lo conosco, ogni tanto ci vediamo, ci scambiamo i nostri libri. Anche Michele Mari lo conosco, con lui ci vediamo meno, ma ci leggiamo e apprezziamo reciprocamente.
Tu sanguinosa infanzia di Mari è molto bello,
Leggenda privata poi è incantevole. Con Tiziano Scarpa invece ci conosciamo da tanto, lavoriamo insieme alla rivista
Il primo amore. Tra i più giovani leggo e apprezzo molto Emanuele Tonon e Enrico Macioci. Però in generale tendo ad andare avanti per la mia strada.
Lei tende a riscrivere i suoi libri? In questi giorni è uscito Canto di D’Arco (SEM, 2019) in cui è presente una riscrittura, uno sviluppo del precedente L’addio (Giunti, 2016).
In verità non riscrivo mai, quando inizio a scrivere la cosa è talmente maturata dentro di me che non ho bisogno di andare avanti a tentoni. Poi certo rileggo e correggo, ma non ho mai riscritto una cosa due volte, non esistono due versioni di una mia cosa.
Cosa è avvenuto invece con Canto di D’Arco?
Con
Canto di D’Arco e prima ancora con
I canti del caos è stata una cosa diversa. Ho pubblicato una prima parte de
I canti del caos che credevo grossomodo che fosse finita, e invece non lo era, e così è nata una seconda parte e poi addirittura una terza. Tutte e tre poi sono state pubblicate da Mondadori. Adesso una cosa simile è successa con
Canto di D’Arco. Quando ho pubblicato
L’addio pensavo che fosse finito, anzi pensavo proprio di chiudere così con i miei libri. Invece sono stato strappato, chiamato dal bisogno di questi personaggi che mi chiedevano vita e così è nata una seconda e anche una terza parte che tutte insieme compongono appunto
Canto di D’Arco.
Però ecco tutto questo è ben diverso dal riscrivere. Quello che faccio è una cosa che facevano anche gli scrittori del passato. Ad esempio pensiamo ai romanzi meravigliosi di Balzac, Le illusioni perdute o Splendori e miserie delle cortigiane, sono tutti formati da tanti piccoli romanzi che uscivano di volta in volta con una traccia così forte e chiara che poteva procedere anche per anni. Oppure anche gli scrittori che pubblicavano sulle riviste, i cosiddetti feuilleton che cominciavano un racconto e poi andavano avanti fino a costituire un libro di dimensioni sempre maggiori. Oggi invece si tende a pensare un libro che sia un prodotto finito, tendenzialmente breve e che soprattutto si concluda in se.
Ma L’addio non doveva essere il suo ultimo libro?
Che posso dire, ho scritto L’addio e mi sono sputtanato di fronte ai lettori che ora possono contestarmi di aver detto una cosa non vera. Mi dispiace, che posso dire d’altro? Se mi si apprezza come scrittore si può essere contenti che io sia andato oltre. Certo scrivendo nero su bianco che non ce la facevo più a sostenere la scrittura – ovvero questo scambio dall’interno all’esterno – mi sono un po’ sputtanato. Ma se ho proseguito vuol dire che c’è qualcosa di radicalmente vero in questo modo di vivere e in quello che faccio. Persino Collodi aveva chiuso con Pinocchio che veniva impiccato – poi invece è andato avanti.
Come valuta il dibattito attorno ai generi letterari? Canto di D’Arco per certi versi è un vero e proprio noir, anche con molta azione.
Non è la prima volta che affronto il genere o lo inserisco in qualche mio libro, è capitato con
Gli incendiati (Mondadori, 2010) che è un romanzo d’amore e di combattimento, poi anche ne
I canti del caos ci sono zone in cui l’avventura e l’azione sono fortemente presenti. Forse perché da bambino avevo grossi problemi a leggere, nemmeno con
Topolino ci riuscivo. Ho cominciato a leggere veramente solo in Seminario quando clandestinamente sono riuscito a recuperare un libro di Salgari. Quello è stato il primo autore che mi ha sbloccato. Quindi io venendo dal basso non ho alcuna schizzinosità rispetto al genere, e credo che della letteratura non si butta via mai niente.
Gli stessi musicisti del passato, da Beethoven a Brahms inserivano delle canzoncine o anche delle musiche zigane nelle loro sinfonie. Quella del genere è un’idea tutta tardo novecentesca che separa le cose e isola la letteratura lasciandola in un posto isolato e quindi ininfluente, al punto che la letteratura stessa viene trasformata in un genere: il genere letterario. La verità è però che gli scrittori hanno sempre osato, Victor Hugo o Dostoevskij non si ponevano certo il problema Oddio, rasento il genere! Se ne fregavano, andavano oltre e offrivano pensiero e avventura insieme. Oggi ci sono degli scrittori cosiddetti di genere che sono molto superiore di altri che si credono migliori solo perché espongono il loro marchietto di “pura lana vergine”.
Altri però hanno interpretato il genere, penso a Umberto Eco e a Il nome della rosa in particolare…
In quel caso però il postmodernismo abbassa tutto, trasforma la letteratura in un gioco. Il mio percorso va in una direzione opposta. Se uno scrittore non ha la capacità di saper inventare una storia non è che deve trasformare questo suo limite in una virtù. Si deve saper fare tutto insieme: Melville dava al lettore un’avventura avvincente e al tempo stesso offriva un pensiero. La letteratura deve portare qualcosa nel mondo, non deve starsene nella sua torretta d’avorio trasformando i propri limiti in virtù guardando con disprezzo il genere.
E fuori dalla letteratura quali sono i suoi riferimenti?
Sono ignorantissimo di quello che succede ad esempio nel campo dell’arte, ma alle volte tra le persone si verificano delle alchimie fortuite. Nel mio studio ho due quadretti, uno è di Nicola Samorì che secondo me è un grande pittore, un quarantenne con cui ho fatto il libro Le fiabe da Antonio Moresco (SEM, 2017) che lui ha illustrato. Samorì è un pittore importante e l’ho conosciuto tramite Jonny Costantino, il regista de La lucina tratto dal mio libro, con cui in futuro dovremmo fare il Don Chisciotte. L’altro quadro presente nel mio studio è di Giuseppe Bartolini, un artista pisano che mi fu presentato da un’amica comune, Carla Benedetti. Bartolini ha questo piglio da pittore antico, in cui la pietra scartata dal costruttore – per usare una famosa espressione evangelica – diventa testata d’angolo. Bartolini è capace di rappresentare la nostra epoca con tutta la forza e la potenza del ritratto antico.
Dopo l’11 settembre del 2001 lei insieme ad altri scrittori dava vita ad una sorta di Fronte, da cui nacque Scrivere sul fronte occidentale (Feltrinelli, 2002). Oggi a fronte di una crisi climatica incombente, del riattivarsi di tensioni e guerre tra America del Sud e Medio Oriente, potrebbe avere ancora spazio una proposta simile?
Quando abbiamo dato forma a Scrivere sul fronte occidentale volevamo dire che l’11 settembre palesava l’inconsistenza di quanto detto dal mondo culturale, ovvero che non c’era più esperienza, storia, dramma e che non c’era più nemmeno l’autore. L’11 settembre dimostrava che non era così. E lo dimostrano oggi ancora di più le migrazioni. E più semplicemente lo dimostra anche la persona singola che vive la morte, il dolore e gli abbandoni. Quindi quello che il mondo culturale aveva spacciato era tutta una menzogna culturale utile solo per cercare di difendersi dal caos e dal dolore del mondo. Quella proposta era una descrizione del mondo menzognera perché il mondo evidentemente sta andando in direzione totalmente opposta, non era altro che un’ideologia.
Sono state totalmente sbagliate le previsioni e le visioni?
Il mondo che abbiamo di fronte è completamente diverso rispetto a quello che abbiamo immaginato, anche i pensatori più sensibili e accorti come i filosofi della scuola di Francoforte o anche lo stesso Pasolini che avevano immaginato un mondo che si sarebbe livellato nelle classi in una sorta di piccola borghesia ottusa e fascistizzata, una classe media egemone. Ora invece sta avvenendo esattamente l’opposto, assistiamo a una spaccatura violentissima tra i primi e gli ultimi, quello che succede in America Latina da decenni sta succedendo anche da noi.
Pasolini rimpiangeva la fine del mondo delle borgate e dei contadini mentre ora vediamo arrivare valanghe di miserabili ottocenteschi. Era tutta una visione sbagliata.
Quindi la cultura si è disarmata?
Completamente disarmata e per non sconfessarsi si è preferito fare finta di niente. Il problema è che ora bisogna ricreare tutto, bisogna contemporaneamente ricostruire il muscolo e il midollo perché è venuto meno tutto. La forza che potrebbe avere l’invenzione di prefigurazione della letteratura, della parola scritta è stata smantellata.
Quale spazio possibile ancora per la letteratura?
La letteratura si è andata a collocare in un ruolo ancillare sia nelle forme ludiche tipo Oulipo sia in questa lettura della realtà da giornalismo d’autore eletto come unica forma morale ed etica, ma non è che Kafka quando scriveva
La metamorfosi o
Il processo fosse meno etico di quello che racconta quello sta succedendo della realtà, anzi proponeva una visione verticale. Infatti viene poi definita la letteratura come fiction, finzione. Tra tutte le parole che si potevano scegliere come invenzione, prefigurazione, profezia, hanno scelto una parole che la negativizza, ma se io leggo Moby Dick è come se leggessi quasi un profeta dell’antico testamento. Melville mi sta
dicendo delle realtà radicali su dove stiamo andando, dove sta andando il suo paese e il mondo. E ora lo facciamo diventare finzione?
La fiction come il labirinto è il mito culturale di un fine Novecento che è stato preso in contropiede da tutto ciò che è avvenuto dopo. Un grande scrittore deve mettere in gioco se stesso e anche la sua autobiografia, che però non è mai più vera del raccontare di Pinocchio o di Moby Dick.
Parteciperebbe ancora al Premio Strega?
No. È stata una stupidaggine.