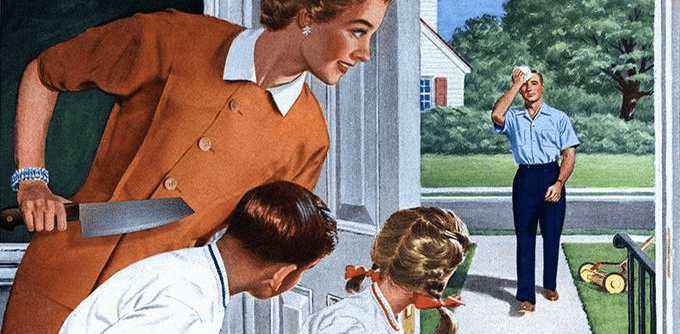
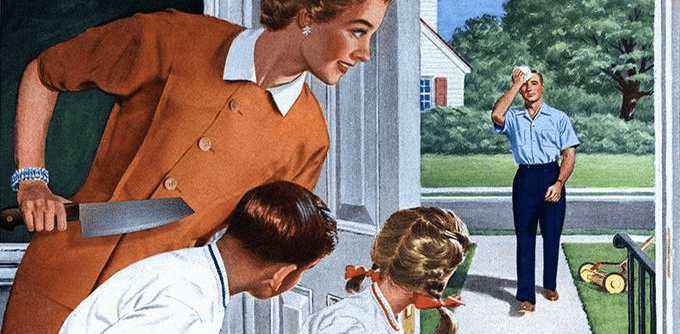
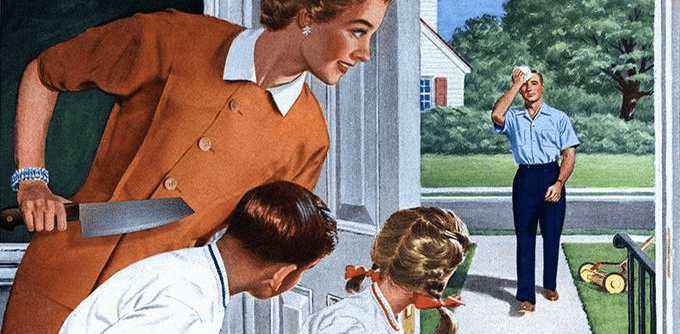
S pesso le vite dei padri vengono riscritte solo dopo la morte. Una volta scomparsi, senza diritto di replica e confronto, i padri vengono rimaneggiati dai figli, prendono corpo nel territorio della finzione letteraria, si espandono come macchie di vernice. Storie che partono da frammenti insufficienti per ricostruire la vita intera di una persona: storie generate dalle velleità artistiche di figli e figlie della letteratura che offrono esperimenti di narrazione, omuncoli di persone che non hanno mai davvero conosciuto in vita, divisi da un silenzio individuale e culturale che ha lasciato in mano alla prole così poco della vita dei propri padri.
“Progetto di restaurarlo sulle rovine della mia memoria, analizzando i minimi frammenti per cercare di riedificarlo senza tutti quei vizi di costruzione che gli hanno impedito di essere lui. Non si può avercela con qualcuno perché non è esistito. Alfred non esisteva molto, esisteva appena”. Papà, ultimo romanzo dello scrittore francese Régis Jauffret (Edizioni Clichy, nella traduzione di Tommaso Gurrieri) fin dalle prime pagine rivela l’intento dello scrittore: il desiderio di ricostruire un padre, restaurarlo, migliorando il ricordo fatiscente che ha lasciato al figlio durante la vita e con la morte. La prima descrizione del padre, “il povero Alfred”, è minuscola, triste: “santo sordo, martire bipolare, volgare animale ridotto a respirare il proprio fiato chiuso dentro il proprio carapace”. Il ritratto che ne esce è uno scarto, un contorno impreciso fatto degli avanzi della memoria del figlio.
Attraverso il pretesto narrativo di un frammento ritrovato di vita sconosciuta — il video di un arresto — il figlio ricerca il padre, raccoglie i pochi ricordi nitidi rimasti e dichiara di voler scoprire cosa si cela dietro quella porta mai aperta che forse racchiude risposte a domande mai fatte. Lo stesso espediente narrativo utilizzato in Città Sommersa (Bompiani) di Marta Barone, dove la scoperta di una porzione di vita celata spinge la figlia alla riscrittura del padre, rigenerandolo nell’unico modo che una figlia ha di ricostruire un genitore: scrivendone. La riscrittura in questo caso è famelica: “Mi era intollerabile pensare a quanto era andato perduto: volevo tutta la vita, nella sua interezza concreta, volevo salvare tutto pur sapendo che non era possibile”. Se Barone perlustra archivi e ricerca indizi per costruire a tutti gli effetti una memoria fedele — seppur dentro lo spazio della finzione e del desiderio di figlia — Jauffret rivela fin da subito il desiderio di finzione a supporto della lacuna lasciata dalla realtà.
Il rapporto con i padri è — canonicamente e statisticamente — difficile: nel vissuto personale così come nella rappresentazione culturale e artistica il padre è un personaggio figlio di una società che lo richiede genitore assente, oscuro. Una relazione silente che viene trascinata negli anni senza alcun cedimento del muro che viene eretto. Le informazioni che filtrano tra il padre e il figlio sono ridotte spesso agli scarti laterali di conversazioni e convenevoli e di rado arrivano a uno stadio più vulnerabile e intimo. Mancando più nei padri che nelle madri un’educazione sentimentale che li faccia confrontare con se stessi e con la prole, il rapporto che si solidifica è scarno, come un monolite muto: “Eppure, volenti o nolenti” commenta Katherine Angel in Bella di papà (Blackie Edizioni, tradotto da Alice Spano e Veronica Raimo),
i padri detengono un potere inquietante, sia che rivendichino sia che rinneghino il ruolo patriarcale che si ritrovano assegnato dalla storia.
In molte occasioni la riscrittura è partita dal bisogno di colmare quel vuoto e sciogliere quel monolite. Per Jauffret il ritrovamento di un frammento del padre accende contemporaneamente due motori. Da una parte la speranza di trovare qualcosa meritevole d’amore, qualcosa da ricordare con orgoglio, al punto da confessare: “…mi sarebbe piaciuto che facesse lo sforzo di morire da eroe”. Dall’altra parte scrivere del padre significa esprimere la potenzialità dell’immaginazione, per lui parte integrante della descrizione di un individuo e “il solo strumento capace di restituire la totalità di un istante passato”, più potente persino di una fotografia, “imbecille che non cambia mai opinione”. Jauffret è consapevole dell’impossibilità di raccontare nella loro interezza i propri genitori se non inventandoli, riscrivendoli sotto nuove forme, altre persone ibride tra chi sono state, chi avremmo desiderato fossero e ciò che ci hanno nascosto.
“Per me, mia madre era esistita sempre e non avevo mai pensato che l’avrei veduta scomparire un giorno, un giorno assai prossimo”. Con queste parole Simone de Beauvoir ne Una morte dolcissima (Einaudi, nella traduzione di Clara Lusignoli) inizia il libro dedicato alla madre e ai suoi ultimi giorni in vita. Questo romanzo breve, che ho riletto fra le tante storie di padri e di madri casualmente raccolte in questi ultimi mesi, ha rimarcato il contrasto tra la riscrittura di una madre e quella di un padre. La narrazione di Beauvoir nei confronti della madre morente è una riscrittura carica di espiazione, un momento creativo nel quale la morte è occasione di risarcimento affettivo tramite il ricordo della figura materna. Se la storia della madre è fatta di una scrittura piena, ricca di dettagli minuti raccolti in silenzio e semplicemente mai apprezzati alla luce del sole, la riscrittura dei padri a confronto appare come un’operazione che parte consapevolmente dall’assenza; assenza ancora più assordante una volta sopraggiunta la morte.
Ne L’invenzione della solitudine (Einaudi, nella traduzione di Massimo Bocchiola) anche Paul Auster si scontra con la morte improvvisa del padre e con l’imminente consapevolezza che il padre non ha lasciato tracce, nella sua vita individuale e nella sua relazione con il figlio. La comprensione delle lacune lasciate fa ribollire nello scrittore un bisogno urgente di trascrivere quanto possibile: “se non faccio in fretta”, ora che la memoria, pur scarna, è ancora calda, “tutta la sua vita scomparirà con lui”. Di cosa sentiamo l’urgenza di scrivere? Forse di quello che sappiamo non aver raccolto a tempo debito, o che temiamo scivoli via; come di un sogno che non lascia traccia, che ci porta a svegliarci e voler annotare subito quel dettaglio ordinario prima che scompaia. Per capirlo dopo, o dimenticarlo del tutto.
Auster inizia la ricostruzione del padre partendo dalla casa in lutto, spulciando negli oggetti lasciati, tra utensili e vecchie foto. Se per Jauffret o Barone l’indizio nascosto, motore della ricerca, era stato provvidenziale, Auster lo ricerca intenzionalmente:
Al mio ritorno mi soffermai su quelle foto, in una trance quasi maniacale. Le trovavo irresistibili, pari a reliquie. Sembravano dovermi dire cose che non avevo mai saputo, rivelarmi verità nascoste, e le esaminai febbrilmente una per una assimilandone i minimi dettagli, le ombre più insignificanti, finché tutte le immagini divennero parte di me. Volevo che nulla andasse perduto.
Per lo scrittore statunitense la riscrittura del padre appena morto è un compito, un progetto che sa fin da subito essere fallimentare. Se Jauffret rivendica il potere e la veridicità dell’immaginazione, Auster ne svela la fatica, non nasconde la difficoltà di voler raccontare un uomo così vicino eppure così invisibile. Spulcia tra i ricordi del padre, tenta di ricomporre una figura evanescente e nonostante inizi a collezionare nuovo materiale tra la polvere dei ricordi questo non gli assicura di riuscire nel suo obiettivo: “…se anche riesco a compiere qualche passo avanti, non sono affatto convinto che mi porterà dove penso di andare. Il fatto di vagare nel deserto non significa che ci sia una terra promessa”.
Nonostante la fatica i padri assenti devono essere riscritti, lo sanno tutti i figli qui riuniti. Perché è un lavoro di messa a fuoco, di delineamento dei contorni, che ci permette di individuare ciò che vogliamo odiare, rimpiangere, e poi lasciar andare. Angel scrive: “Attraverso la scrittura creo un genitore, un’alterità, il cui volto rimane imperturbabile e che non ha bisogno del mio falso sé. Attraverso la scrittura creo l’oggetto, il lettore — il padre — che posso distruggere e che sopravviverà alla distruzione”. Una messa a fuoco per odiarli meglio, distruggerli; una distruzione innocua, post mortem, essenziale per il figlio per superare le proprie radici.
Questo lavoro di riscrittura non ha una sola risposta, dunque, ma molteplici funzioni che si intersecano tra di loro. Si spera che trascrivendo da capo la vita di un uomo si riescano a trovare frammenti meritevoli capaci di giustificare l’affetto — recondito, latente — che forse un figlio sente sempre di provare per lui. Si crea una nuova vita per il gusto di poterlo fare, lasciare libere le potenzialità della finzione letteraria al funerale del proprio genitore. O si riscrive per distruggere, per dissezionare il corpo emotivo di chi non ci ha cresciuti, la distruzione per la rinascita. Serve a ribadirci quanto sia facile prendere un consanguineo e trasformarlo in qualcosa di nuovo, lasciando libere le potenzialità della finzione; o quanto sia difficile farlo, scavare e confrontarsi con l’altro anche quando non c’è più.