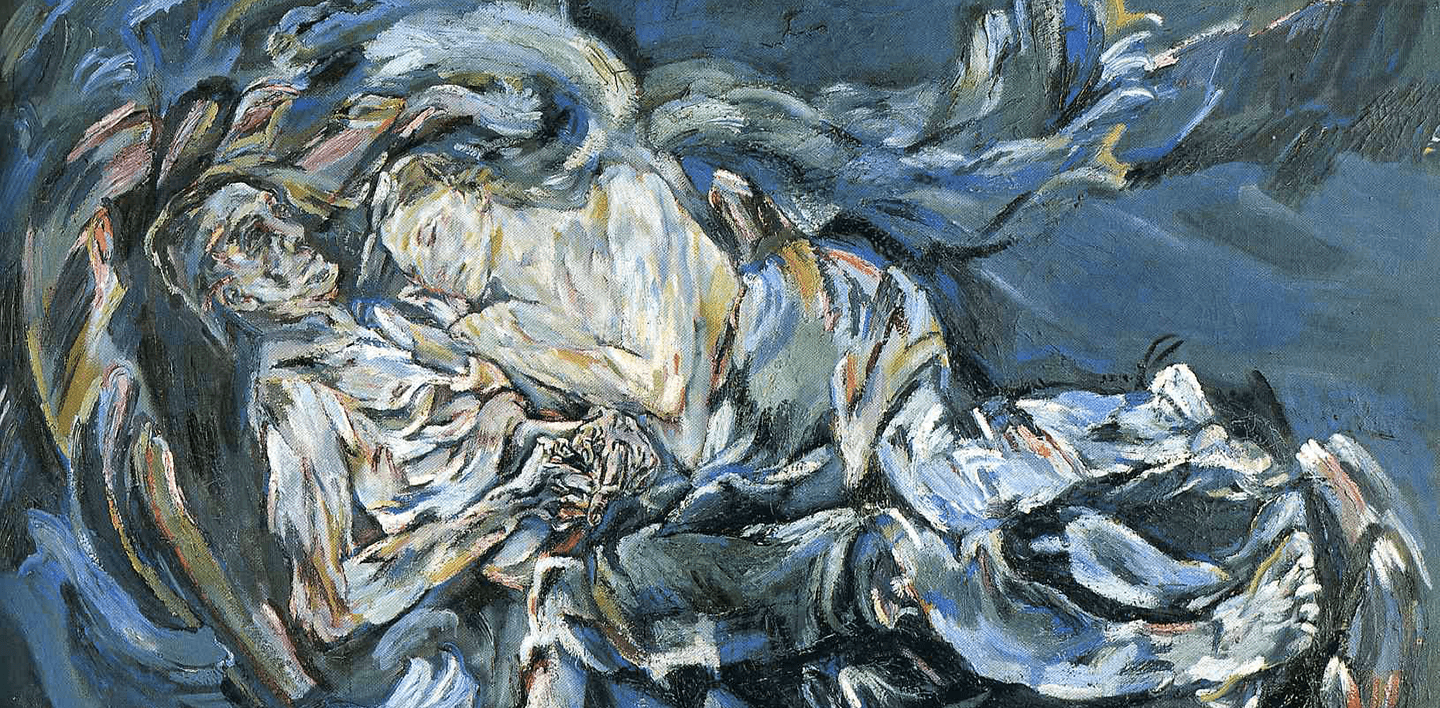
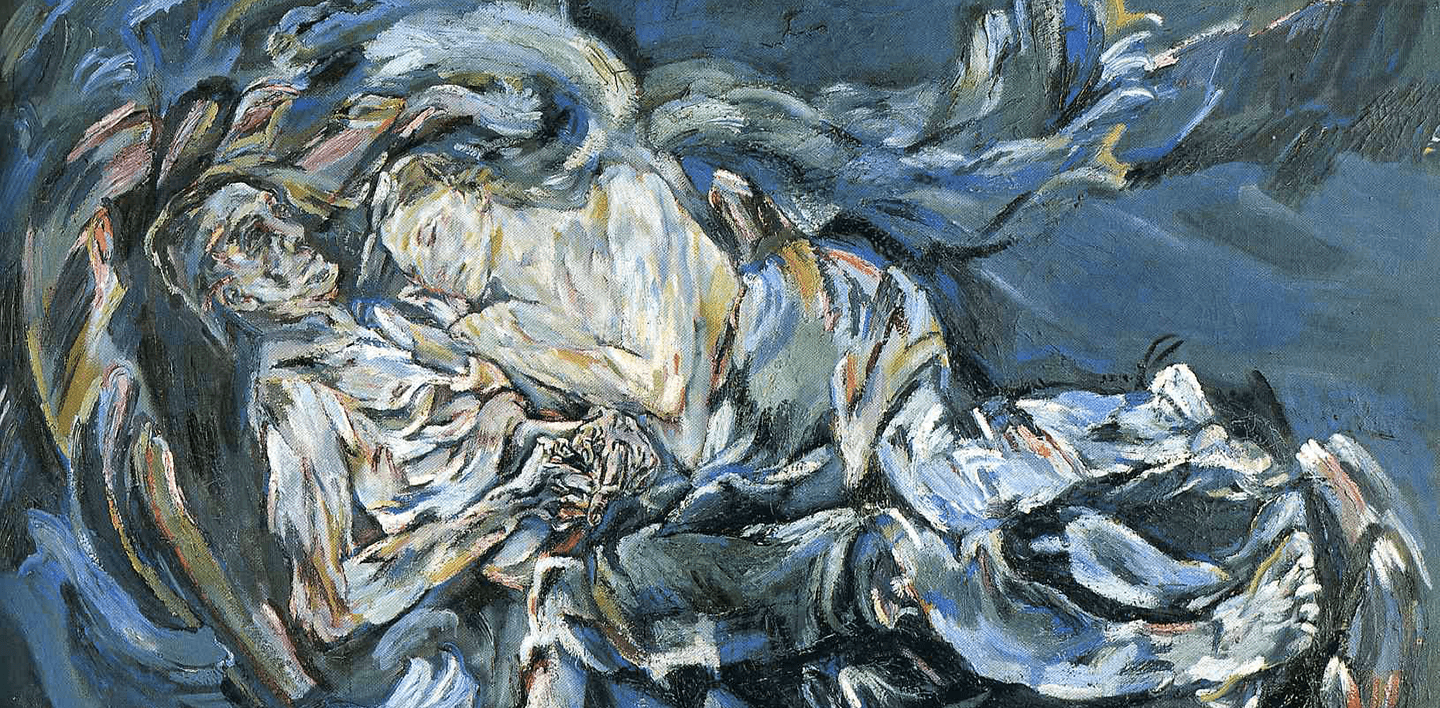
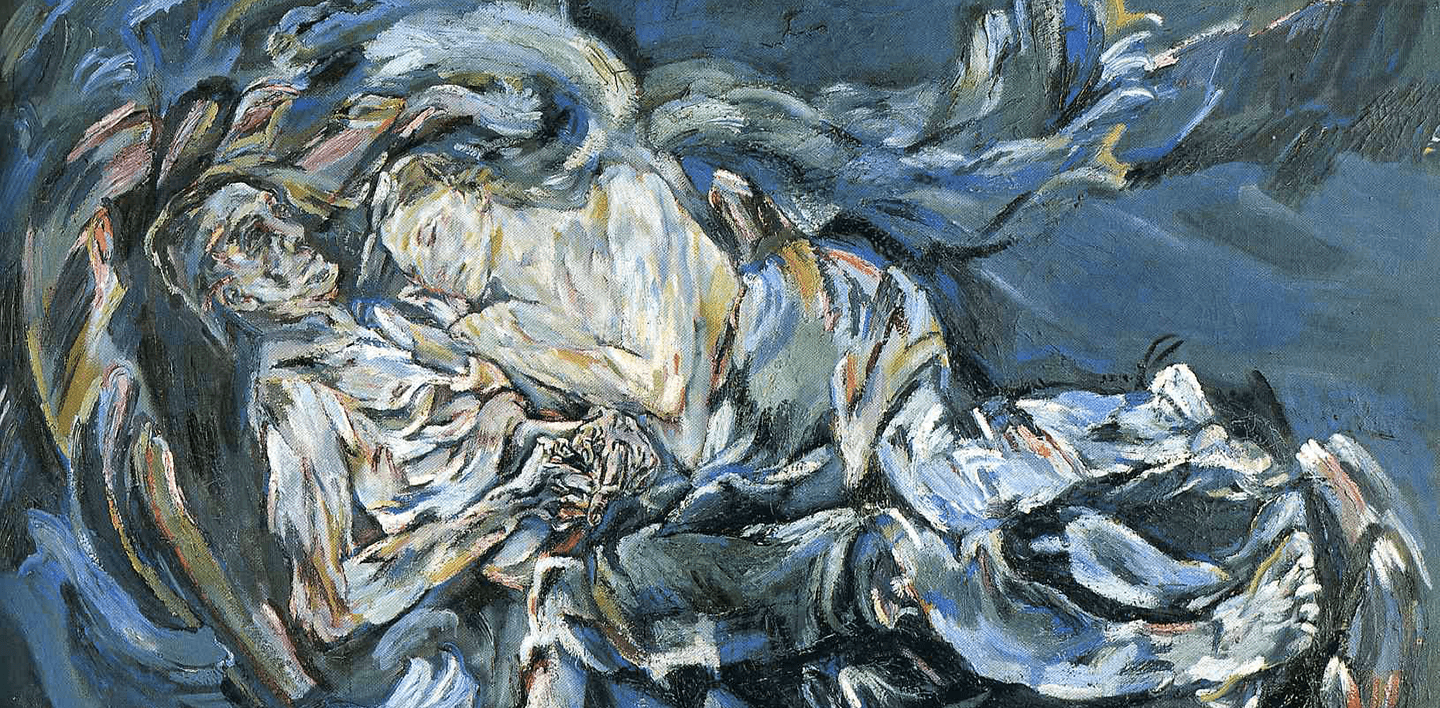
E così l’odio è diventato mainstream. A sinistra, la formula descrittiva è sempre la stessa: “I populisti e i razzisti hanno saputo intercettare il disagio e le paure del ceto medio impoverito”. Nella sua laconicità, sembra quasi offrire il fianco al nemico. Che ci sia stata una crisi nel continente è ovvio; ma che non sia paragonabile in nessun modo a quella da cui fuggono gli oggetti di questo odio radicale, lo è altrettanto.
Eppure, la situazione dieci anni fa era tanto diversa? No: nonostante le differenze economiche e sociali, e il quadro politico europeo assai più stabile, le radici di questa ferocia erano già palesi. Nel 2008 la rivista il Primo Amore intitolò il suo quarto numero La fabbrica della cattiveria. L’editoriale di Antonio Moresco sottolineava quanto l’esasperazione e il risentimento stessero dilagando nel Paese — con i toni un po’ apocalittici che le erano consueti — e precisava:
Perché in questo numero della rivista parliamo di cattiveria? Perché usiamo questa definizione un po’ infantile di «cattiveria» e non utilizziamo invece altre parole che hanno un più affermato pedigree culturale: crudeltà, violenza, ecc…?Lo facciamo perché ci sembra più proporzionale e più giusto che molti dei fenomeni di questi anni siano privati della nobilitazione rovesciata che queste altre parole si sono conquistate nel discorso della modernità, per riportare le cose alla dimensione infantile e priva di trascendenze culturali della cattiveria.
Oggi è difficile contestare a Moresco la sua scelta lessicale. Basta leggere una manciata di commenti ai post di Salvini per rendersi conto del grado di infantilismo e vittimizzazione che si respira: la colpa è sempre altrove, e anzi ben collocata: “noi” siamo vessati, tartassati, massacrati, esasperati: ma finalmente è l’ora della riscossa; finalmente ci faremo rispettare. Questo il grado del discorso comune: e così l’odio verso il più debole è diventato mainstream, è stato non solo legittimato ma preso a fondamento di un intero modello politico. Nel discorso comune, la violenza sui più deboli viene piano piano considerata un’ovvietà. Quali sono le cause di questo fallimento morale, e quali le possibili soluzioni?
Il problema è estremamente complesso e merita grande cautela. Qualsiasi semplificazione giornalistica è una concessione al nemico, e di questi tempi chi scrive deve mirare al massimo della cautela e dell’attenzione: i tanti editoriali indignatissimi e vaghi non spostano di una virgola il problema. Occorre invece procedere pezzo per pezzo, concretamente, ognuno aggiungendo una suggestione per comprendere meglio il punto in cui siamo. In questo articolo mi limiterò ad attirare l’attenzione su un dettaglio: la mancanza di immaginazione come base per l’empatia, e la parziale efficacia delle storie per porvi rimedio.
Tutti provano empatia: ci commuoviamo quando una persona prova dolore; ci sentiamo istintivamente male quando un amico è angosciato; siamo felici se qualcuno che amiamo è felice. Ovviamente il sentimento è più scontato quando riguarda individui a noi vicini — ma non è limitato a loro. Anzi, è un sentimento con solide radici biologiche. Lo psicologo Martin Hoffman, ad esempio, ha sviluppato un’intera teoria dell’empatia come base per il comportamento altruistico. E una corrente di pensiero che risale a David Hume e Adam Smith ha considerato tale caratteristica come centrale per comprendere e fornire qualsiasi deliberazione morale. Ciò peraltro non implica il rifiuto della ragione come principio fondante della nostra etica. In un paper dal titolo Empathy and Imagination, la filosofa Nancy Sherman scrive:
Non sto suggerendo che i modi di immaginare le situazioni altrui svolgano lo stesso ruolo di un’ipotesi sulla capacità universalizzante della ragione. Il punto di quest’ultima è quello di escludere privilegi di sé stessi e del proprio gruppo, cioè forme di parzialità, incompatibili con i diritti e il benessere degli altri. […] Il mio punto è semplice: la funzione dell’empatia è assai più proteiforme e profondamente radicata nella nostra esistenza sociale.
Naturalmente le cose non sono così lineari, e determinati stati d’animo potrebbero essere inaccessibili. Ramsay McNabb sottolinea che “presumere di sapere come si sente un’altra persona è quello di privare quella persona della sua separazione e unicità. È particolarmente offensivo per le persone che sono state vittime di una forma o di un’altra di oppressione quando i membri di un gruppo privilegiato pretendono di sapere come si sentono”. Ciò nonostante, l’immaginazione empatica è qualcosa di reale. Non sono un immigrato, ma vedo la discriminazione quotidiana verso di essi e questo mi fa arrabbiare: non solo perché questo ferisce la mia idea di società civile, ma perché a un livello più istintivo e radicale mi figuro il loro dolore.
Ma allora perché l’odio è mainstream? Perché così tante persone chiedono una risposta violenta, cieca, cattiva? Ci sono molte cause, come ho accennato. Una è la carenza di figure politiche e intellettuali all’altezza. Un’altra è la solidarietà negativa, ovvero una condizione sociale e ideologica in cui tutti sono posti contro tutti, e invece di battersi per estendere o riconquistare diritti che appartengono ad altri, ci si limita a invidiarli o a prenderli come oggetto di odio indiscriminato. Ma c’è anche una causa più elusiva: appunto la progressiva mortificazione dell’immaginazione sociale ad ampio raggio, la sua limitazione ad alcuni gruppi: gli italiani, o i bianchi, o i ricchi, o i nostri figli e non quelli degli altri — “da ministro e da papà”, dice Salvini. È una strategia politica tutta fondata sull’emotività e ben poco sulla ragione, del resto piuttosto chiara e condotta con pervicacia, e i cui frutti sono ormai visibili. L’attacco al “buonismo” ne è uno dei segnali linguistici più evidenti: e anche in questo caso, se ne parla da almeno dal 2008. Dieci anni dopo, il fatto è assodato.
Purtroppo far fronte a tutto ciò richiede un lavoro molto lungo, che passa innanzitutto per una dimensione pedagogica. Secondo il ricercatore della UCL Adrian Skilbeck, “la sfida per l’educazione morale è di facilitare e incoraggiare una varietà di forme di espressione etica in cui le forme stesse sono costitutive di una certa realtà morale”. E aggiunge che l’argomentazione razionale di tipo classico è solo uno dei modi per convincere gli altri della validità o dell’importanza di una questione morale. Ce ne sono altri, “di tipo letterario”, che non si limitano a essere asserzioni infondate “alla mercé dei sentimenti personali”, ma che hanno un’efficacia sostanziale tanto quanto i ragionamenti filosofici. Skilbeck invita dunque a discutere la natura di queste esperienze in termini non privati ma pubblici: certo, si può sostenere che tutto ciò non è necessariamente la premessa di azione, impegno e cambiamento. È verissimo, e Dio solo sa quanta indignazione a vuoto abbiamo visto negli anni. Ma è quantomeno un punto di partenza — parziale finché si vuole — contro l’indifferenza e la cattiveria. Come dunque rivitalizzare un’immaginazione empatica che abbia effetti concreti sul tessuto sociale?
Ancora una volta, la risposta sembra già pronta: con le storie. L’ho ripetuta io stesso per anni, con cieca fiducia. Le storie ci impediscono di ridurre tutto a numeri e dati; incarnano gli effetti degli eventi globali negli eventi drammatici di una singola esistenza; colmano il divario tra noi e gli altri. Non sono così ingenuo da credere che le storie ci rendano sempre automaticamente migliori; tuttavia, sono sempre stato convinto che possano aiutare. Ma ecco il punto: per anni lo storytelling è stato imposto come mezzo politico, giornalistico e pubblicitario; tutti si sono riempiti la bocca del valore delle storie e della loro forza (reazionaria o sovversiva); eppure pochi hanno pensato a valutarne il significato e la diversità, o anche solo a porle nel giusto contesto.
Anni di “narrazione”, e questo non ha impedito la diffusione di una progressiva cecità morale. Per un doloroso paradosso, ha forse contribuito ad alimentarla: perché da un certo punto in avanti è stata condotta in maniera acritica, anche fra le migliori parti della società. E così siamo arrivati qui: poiché sono propagati su una scala di massa, questi elementi narrativi sembrano piuttosto un ulteriore alibi per l’indifferenza quotidiana. Non abbiamo mai avuto così tante storie e immagini di persone in situazioni estremamente difficili, eppure quanto aiutano o quanto aiuteranno ancora? Quanta azione concreta sposteranno? È una domanda che dovrebbe porsi chiunque si appresti, in ottima fede, a condividere l’ennesima fotografia di un bambino sofferente: si tratti del social media manager di una Ong, o del cittadino democratico sconvolto.
Preciso: tutto questo non accade perché le storie sono inutili, ma perché il contesto culturale in cui esse agivano si va dissolvendo. Per quanto criticabile, per quanto a volte parassitario, il lessico emotivo poteva un tempo spingere all’azione; ora temo cominci a girare a vuoto. La sua funzione sembra più che altro consolatoria: tu condividi questa vicenda terribile, io la ribatto, e ci riconosciamo come parte di un’umanità che ancora non ha ceduto al cinismo — in sostanza, come ipotizza Massimo Mantellini, sono commenti che servono a descrivere noi stessi. Tutto bene: il problema è che nel frattempo chi è in pericolo di vita continua a rimanerci. Elias Canetti supponeva che raccontando potessimo sconfiggere la morte. Sono il primo a infiammarmi quando sento parole simili; ma fuori dal cerchio di questa splendida metafora, fuori dal regno incantato della letteratura, la realtà ci dice ben altro.
È un brutto cortocircuito, e non è facile uscirne: fra le tante sfide cui sono chiamati oggi i professionisti della parola, questa mi sembra particolarmente urgente. Posto che la resa o il quietismo non sono opzioni praticabili, per sciogliere il dilemma non resta che raccontare meglio — e senza dare per scontata l’efficacia della rappresentazione del dolore. Oggi più che mai serve misura e non paternalismo spiccio, razionalità e non enfasi a buon mercato, critica autentica e non caciara. Ma è sufficiente?
Sarebbe bello offrire una risposta eroica e convinta a mo’ di conclusione, e dire che non cederemo di un passo da questa linea di resistenza. Non lo faremo, certamente, io non lo farò: ma è sufficiente? Non ne ho la più pallida idea.