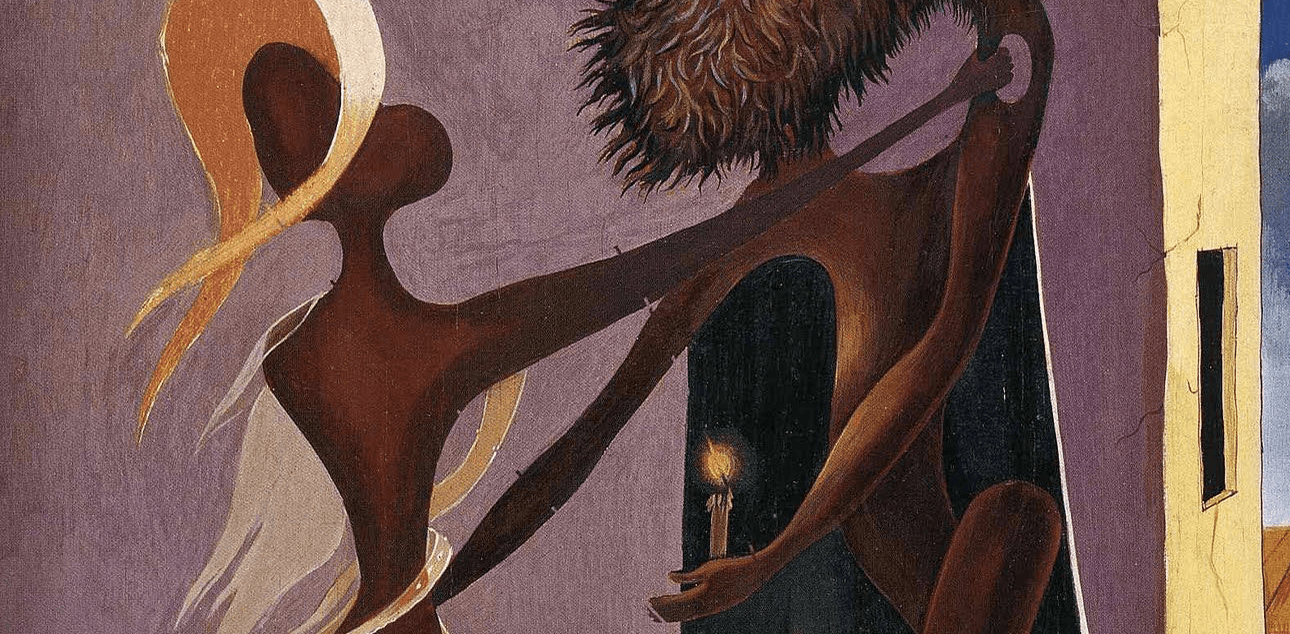
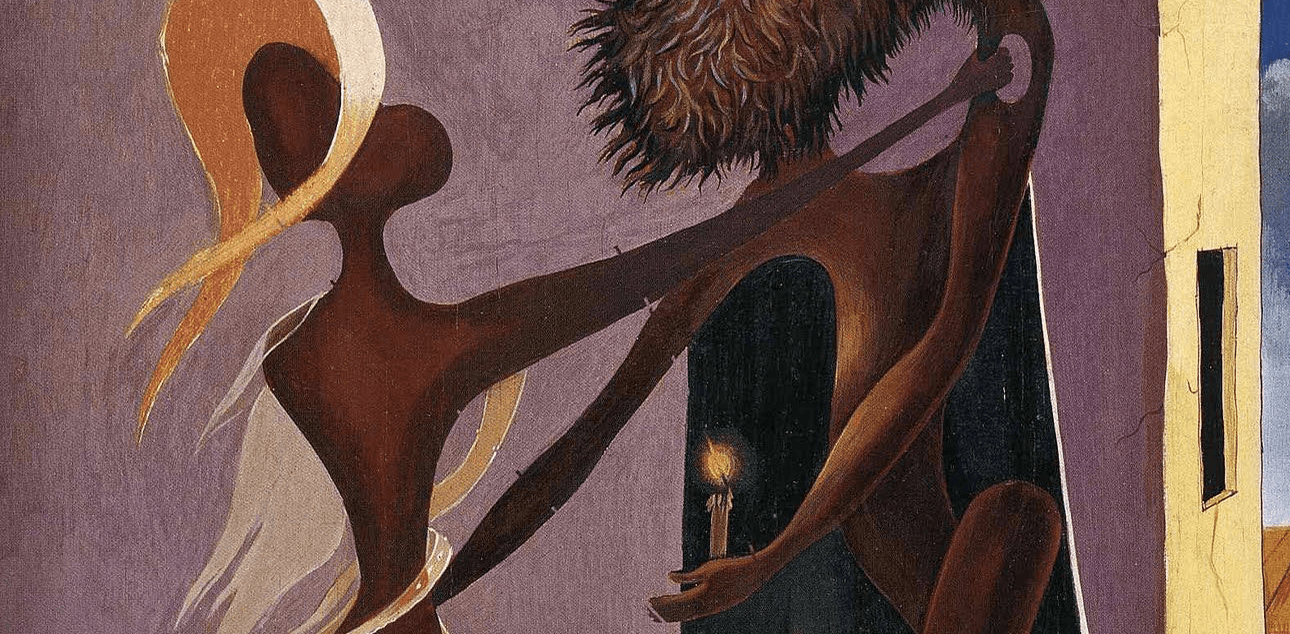
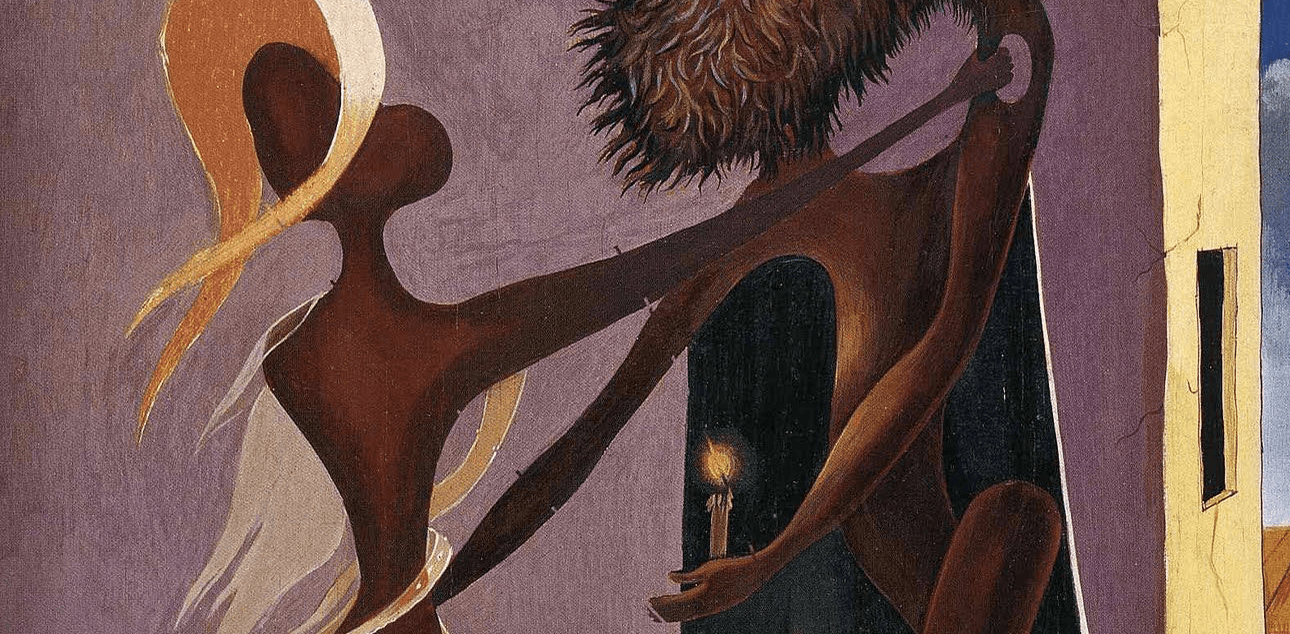
L e quattro del mattino. L’ora in cui, secondo Shakespeare, ci si prepara a uccidere un tiranno (Riccardo III, atto V) o a giustiziare un innocente (Misura per misura, atto IV). In cui Charlotte Brontë fa svegliare di soprassalto Jane Eyre, per sventare un incendio. L’ora esatta in cui anche Gregor Samsa dovrebbe alzarsi, ma non lo fa, perché è diventato un insetto. Alle quattro del mattino, ne La casa degli spiriti, si imbalsamano cadaveri. E sempre alle quattro, Napoleone, secondo Tolstoj, fissa l’orologio perché non riesce a dormire.
Orario non facile, le quattro del mattino. Tempo di pericoli e affanni. Piega sdrucita tra la notte e il giorno, dove ‘mai’ e ‘per sempre’ si toccano. Ci confondono.
Lo sapeva bene la poeta polacca Wisława Szymborska, premio Nobel per la letteratura nel 1996, quando scriveva: “Ora del chissà-se-resterà-qualcosa-di-noi. / Ora vuota. / Sorda, vana. / Fondo di ogni altra ora. / Nessuno sta bene alle quattro del mattino. / Se le formiche stanno bene alle quattro del mattino / – le nostre congratulazioni. E che arrivino le cinque, / se dobbiamo vivere ancora”.
“Se dobbiamo vivere ancora”: parole che tutti, almeno una volta, avremo pronunciato alle quattro del mattino, misurando il respiro, e per ciò stesso perdendolo (succede così col respiro: pensarlo, il più delle volte, lo complica).
Le quattro del mattino: ora della logica debole, delle visioni e delle associazioni, delle strade traverse. Intercapedine tra buio e luce, tasca infinitamente bucata, pronta a inghiottirci. E però anche spazio potenziale, di travasi fra possibile e impossibile, luogo di tremori – sì – ma anche di fuochi, e improvvise chiarezze. Per questo, le quattro del mattino, sono spesso anche l’ora di chi crea.
In Massachusetts, alle quattro del mattino, Emily Dickinson non dorme. È il 1863, ha poco più di trent’anni, ma da tempo preferisce scrivere di notte, nella sua stanza tutta per sé. Grata per la solitudine, libera dagli schemi diurni, a lume di lampada, con i capelli sciolti, la poeta risponde alle molte lettere di amici e parenti e lavora ai versi annotati brevemente durante il giorno.
È sul finire di una di queste lunghe notti, nell’ora incerta che precede l’aurora, che Emily Dickinson porge l’orecchio al risveglio del mondo:
Gli Uccelli cominciarono alle Quattro – / Il loro orario per l’Alba/ Una Musica variata come lo spazio – / Ma vicina come il Mezzogiorno.
Fuori dalla finestra una melodia crescente, articolata, anticipa e prepara la vita, mentre la vita dei più giace incosciente: si tratta di un’inaugurazione “senza testimoni”. Solo la poeta, che ha attraversato il buio ad occhi aperti, può godere della solitudine grande di assistere all’alba prima dell’alba.
Alle quattro del mattino, fuori dalla camera da letto della poeta americana Elizabeth Bishop – è il 1956, ha appena vinto il Premio Pulitzer, è in Brasile, a casa dell’amante Lota de Macedo Soares – gli uccelli non cantano (o almeno, non ancora). Ad abitare lo spazio tra la notte e l’alba ci sono, piuttosto, lunghe catene di immagini, concrezioni di ricordi, traffici fra vero e non-vero.
È quanto accade nella poesia Sunday 4 a.m., in cui la semplice osservazione del paesaggio della stanza, che si dispone attorno al corpo steso della poeta, diviene sequenza di figure, spettacolo combinatorio che allucina l’oggetto quotidiano e lo trasforma in visione composita, ricca.
Così, l’icona di una Madonna si confonde col ricordo di una certa zia Mary; i quadrati della finestra si trasformano in caselle di gioco; voci lontane, che parlano di cavalli da ferrare, sembrano suoni d’organo o di armonio; un gatto appare saltando con una falena in bocca; un “ruscello cerca a tentoni la via delle scale”: visioni alterate, sacro e infanzia, natura che preme per entrare. Fino a quando “un uccello / sistema due note ad angolo retto”: la fantasmagoria è finita. L’alba è giunta per mettere ordine, e a confermarlo è proprio il canto di un uccello, preciso e proporzionato elemento di realtà. Ma la lanterna magica delle quattro del mattino ha avuto tempo per fare il suo lavoro. E una poesia è nata.
Il sonnifero che Sylvia Plath prende ogni sera prima di andare a letto smette di agire puntualmente alle quattro del mattino. È l’ottobre del 1962, la rottura con suo marito Ted Hughes si è appena consumata, tra furore, angoscia e senso di liberazione. Plath sta mettendo insieme le poesie per “Ariel”, la sua raccolta-capolavoro. Vive da sola con i figli, prima in campagna, poi a Londra, e tutte le mattine, mentre loro dormono, si alza alla stessa ora. Lo racconta in un appunto scritto per una trasmissione della BBC:
Le mie nuove composizioni hanno in comune una cosa, sono state tutte scritte verso le quattro del mattino: quell’ora ancora azzurra, immobile, silenziosa, quasi eterna, prima del canto del gallo e del pianto del bambino, della musica tintinnante del lattaio che depone le bottiglie.
È in questa finestra di tempo senza tempo che nascono testi straordinari come “Lady Lazarus”, “Daddy”, “Ariel”. In una lettera del 21 ottobre del 1962 alla sua psichiatra americana, Sylvia Plath ribadisce: “mi alzo ogni giorno alle quattro, quando l’effetto del sonnifero si esaurisce, e scrivo come una furia fino alle otto”. Quattro le ore in cui la penna corre feroce, quattro i mesi che la separano dal suicidio. Poco più di cento giorni in cui Sylvia Plath, “come una furia”, alle quattro del mattino, scrive più di cinquanta poesie: sono tra i suoi versi più potenti.
In un piccolo appartamento di Buenos Aires, la poeta argentina Alejandra Pizarnik – amica di Julio Cortázar, intensa corrispondente di Cristina Campo, riscoperta dalla critica internazionale solo in questi ultimi anni – trascorre notti intere alla ricerca dei versi giusti. Ha l’abitudine di scriverli su una lavagna: li fissa, li sposta, li cancella, come se si trattasse di un dipinto, di una scultura da ridurre al minimo. Cerca la sottrazione, la poesia nuda, la “poesía pura”.
“Tutta la notte faccio la notte. / Tutta la notte scrivo. / Parola dopo parola scrivo la notte”, dice la poeta, dall’esilio permanente della sua insonnia, non-luogo di tormento e insieme di “lucidez exasperada” – lucidità esasperata, quella di cui ha bisogno per creare. In un appunto di diario del 29 giugno 1964, Pizarnik annota:
Ieri notte, alle 4 del mattino, grande crisi di paura del futuro. […] Chi non riesce a vivere non vuole morire, chi non riesce a vivere spera di vivere, sente che la vita gli è dovuta. […] Impossibilità di un luogo per riposare. Terminare con felicità questa ricerca è morire. Rinunciare a qualcosa di favoloso.
La rinuncia avverrà tra la notte del 24 e l’alba del 25 settembre del 1972. Sulla lavagna i suoi ultimi versi, perfetti: “No quiero ir / nada más / que hasta el fondo”.
In un seminterrato di Londra, nel febbraio del 1999, Sarah Kane – drammaturga potente, sensibile, disturbante – sta finendo di scrivere la sua ultima opera teatrale. Sono le 4 e 48 del mattino: “after 4.48 I shall not speak again”, avverte. Le 4 e 48: “l’ora in cui la depressione viene in visita” e “l’ora in cui la sanità viene in visita”. Per Kane, le due ospiti arrivano insieme e sono irriducibili. Nell’ora segreta in cui notte e giorno si toccano, pazzia e lucidità avanzano palmo a palmo, gemelle inseparabili, pronte a far saltare qualsiasi confine. Si tratta di una detonazione potente, di una babele dolorosa e insieme di una riduzione della lingua all’essenziale: “the capture / the rapture / the rupture / of a soul”.
Alle 4 e 48 l’anima si rompe per troppa chiarezza, perché l’inizio e la fine delle cose si sono mostrate insieme: visione agglutinata, deposito assoluto del mondo, un tutto-intero che non lascia respiro. Non ho nessuna voglia di morire / nessun suicida ne ha mai avuta / guardatemi scompaio / guardatemi / scompaio / guardatemi / guardatemi / guardate” – scrive Kane. Poi un lungo spazio bianco. Poi le ultime parole: “Per favore aprite le tende.”.
A percorrere le esistenze e i versi di queste artiste straordinarie, tutte diverse fra loro, ma tutte accomunate dal fatto di essere sveglie, e di scrivere, alle quattro del mattino, viene proprio da dar ragione a Szymborska. “Nessuno sta bene alle quattro del mattino”. C’è però chi, attraversando ad occhi aperti questo territorio pericoloso, ci ha dato parole per nominarlo. Dickinson, Bishop, Plath, Pizarnik, Kane, Szymborska: forse potremmo immaginarle tutte insieme, abitanti del continente impossibile delle quattro del mattino.
Ciascuna sola, nella sua stanza, in un determinato tempo, in un determinato spazio, eppure tutte dentro lo stesso campo lungo. Mentre scrivono e pensano e sopportano il mondo anche per noi, che dormiamo protetti, che non vediamo la smagliatura terribile e miracolosa delle quattro, quando il sorgere del sole è così vicino, eppure non abbastanza per non avere paura che non sorga.
Da domani in poi, se ci capiterà di fissare l’orologio prima dell’alba, e di perderci nel fondo sfondato delle quattro del mattino, di sentirci i più soli al mondo – soli anche accanto a un corpo amato, dal cui sonno siamo irrimediabilmente esclusi – se ci capiterà di dover attraversare svegli quella curva a gomito, quel binario di scambio, di sentire su di noi tutti i dolori del parto del Giorno, come se dovessimo farlo nascere noi, il Giorno, ricordiamoci delle poete delle quattro del mattino.
Sempre vive, a quell’ora, in un continente segreto, sveglie per darci parole. Pensiamo a quelle parole. Chiudiamo gli occhi un momento.
“E che arrivino le cinque, / se dobbiamo vivere ancora”.