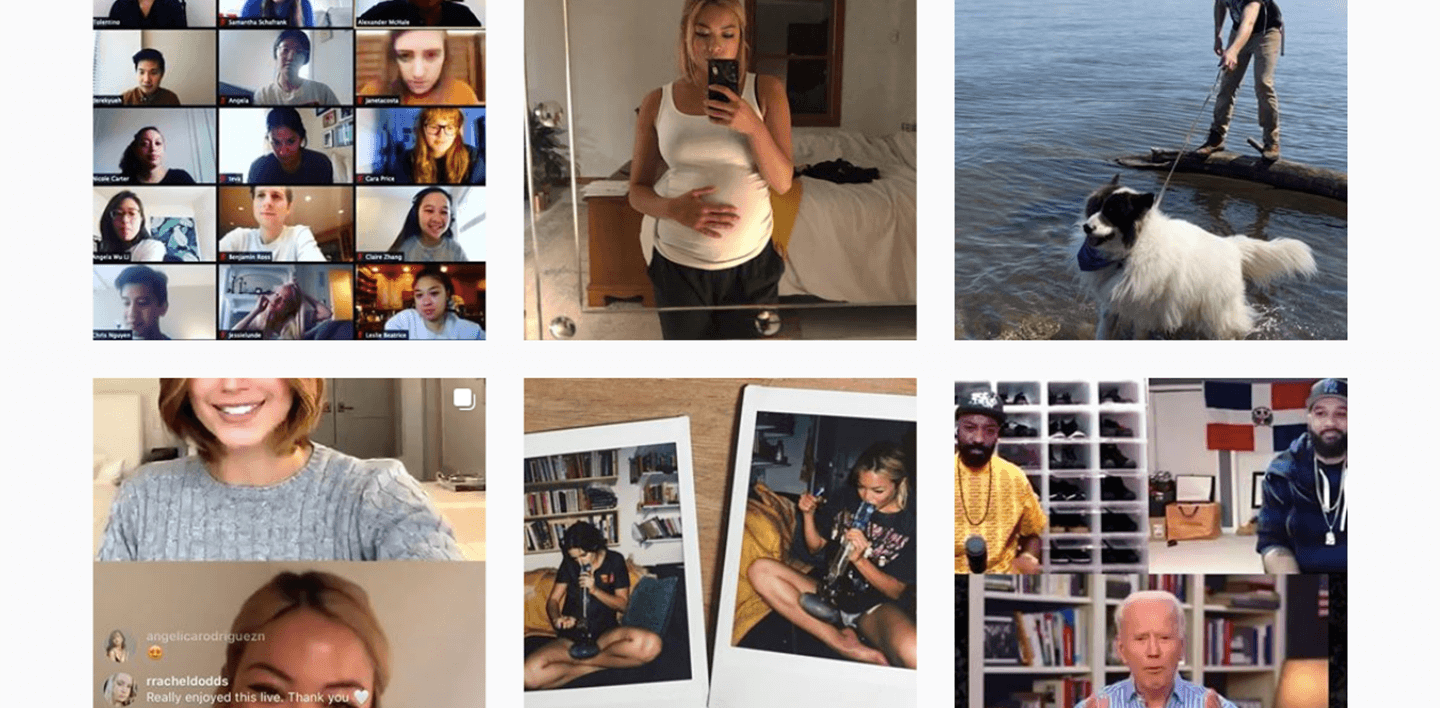
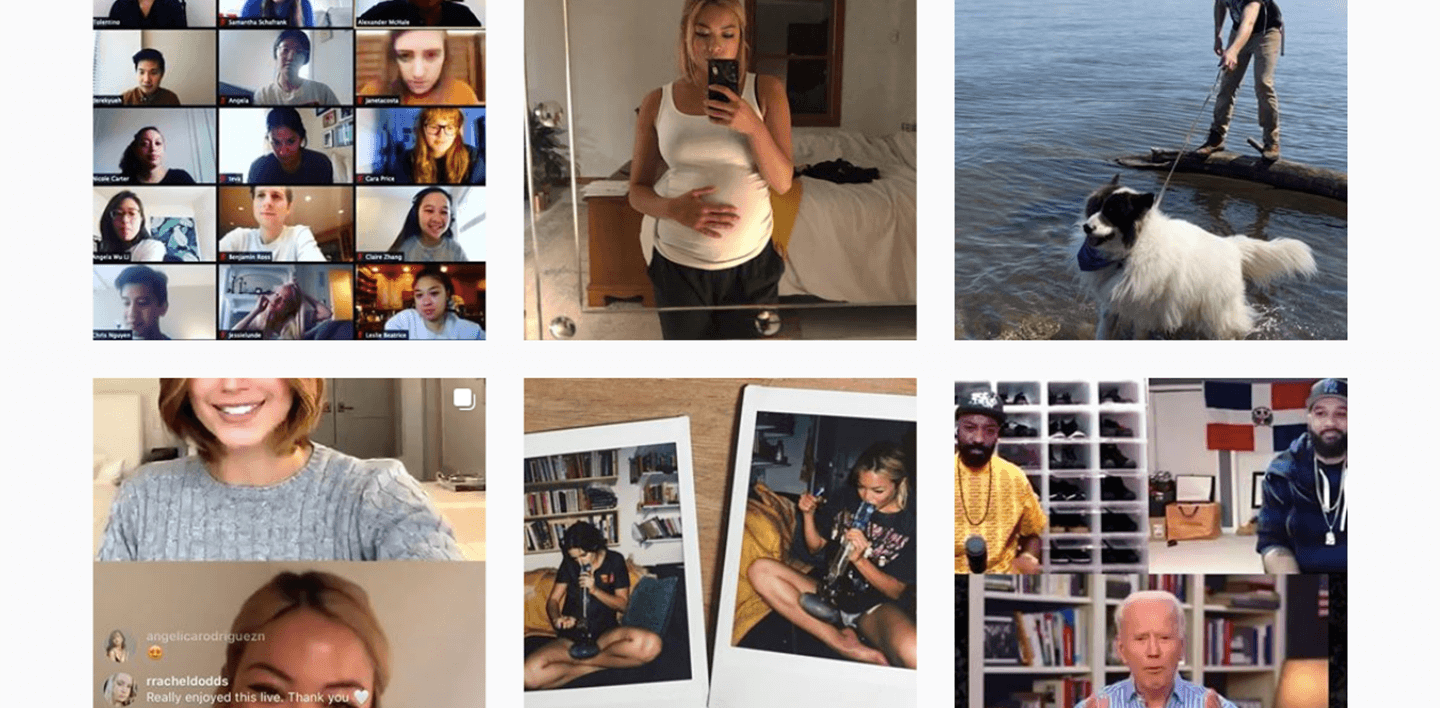
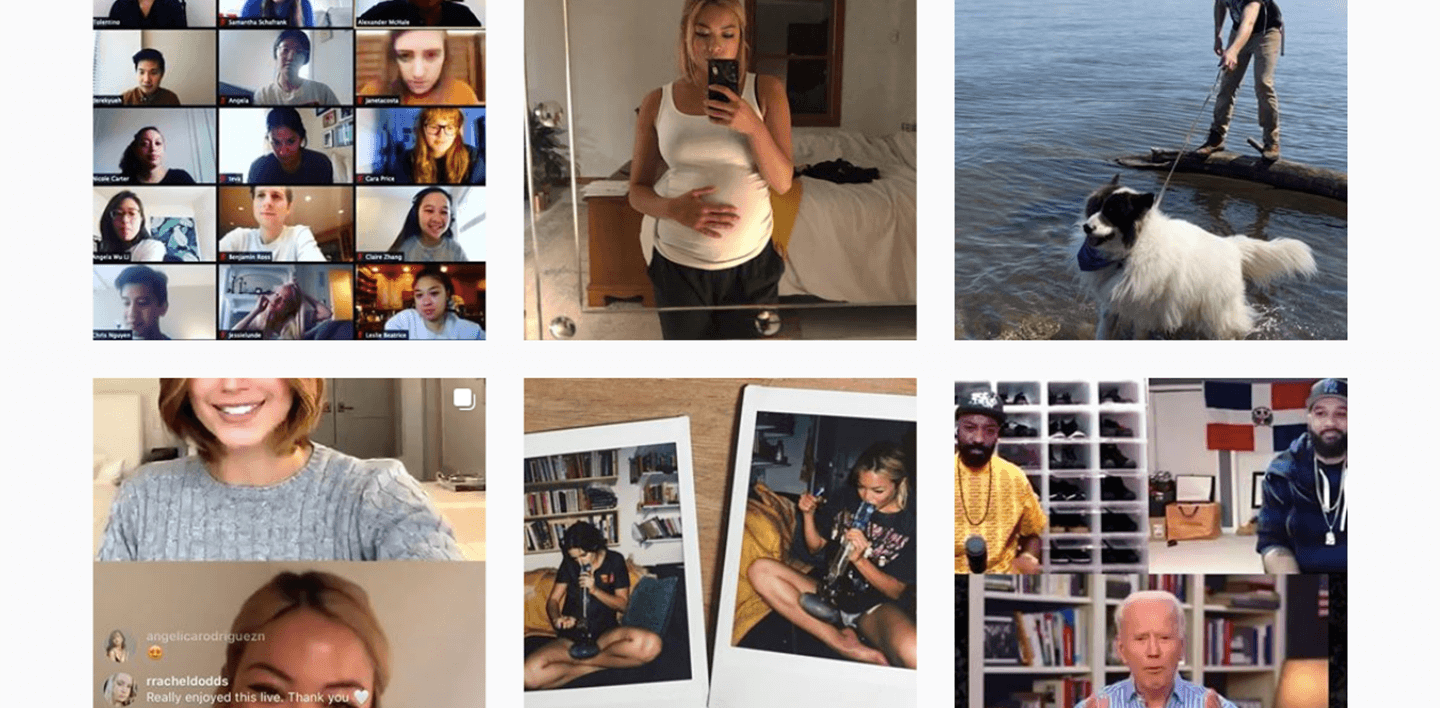
C on la sua raccolta d’esordio Trick Mirror (NR Edizioni, tradotto da Simona Siri), Jia Tolentino si frammenta in nove saggi per venire a capo della composizione di arbitrarietà, casualità, decisioni e desideri che la rendono la persona che è. Mentre si dissesta e ricompone, però, Tolentino cerca anche di raccontare qualcosa sul tempo che stiamo tutti vivendo. Il vero specchio deformante inizia qui, nel tentativo di raggiungere il generale partendo dal microscopico e personale.
In “La i di io in internet”, Tolentino cresce con e su Internet, scrivendo in pubblico per blog e social network, e assistendo contemporaneamente alla corrosione commerciale degli spazi virtuali. In “Io nella reality TV” Tolentino adolescente partecipa a un programma di reality TV ambientato su una spiaggia portoricana, in cui si prevede che gareggi e amoreggi con altri concorrenti coetanei. Con “Ottimizzarsi sempre” riflette sui canoni di bellezza e prestanza femminile mascherati come “cura di sé” e sull’idea che il proprio corpo sia una risorsa da far fruttare per essere più produttive. “Eroine pure” è una carrellata di protagoniste letterarie accomunate da una traiettoria simile: all’inizio bambina energica, poi ragazza triste e infine donna disillusa e ignorata. “E(c)stasi” ripercorre la storia della perdita della fede di Tolentino, l’estasi religiosa della preghiera sostituita dalla scoperta delle droghe ricreative. “Storia di una generazione in sette truffe” accomuna storie di coetanei di Tolentino che hanno cercato il successo economico attraverso metodi poco ortodossi, a volte criminosi. In “Noi veniamo dalla vecchia Virginia” Tolentino indaga su come le università americane – la sua alma mater inclusa – non riescano, o non vogliano, garantire la sicurezza delle studentesse dagli abusi sessuali perpetrati dai compagni di corso. In “Il culto della donna difficile” decostruisce la tendenza a imporre una narrazione “femminista” alle biografie (illustri o meno) delle celebrità pubbliche. Infine, in “Io temo te”, Tolentino argomenta il perché non intenda sposarsi nonostante sia impegnata in una relazione eterosessuale e monogama.
Il talento cruciale di Tolentino è la sua capacità di semplificare e rendere facilmente comprensibili concetti complessi, filtrare una molteplicità di temi (e relative implicazioni) in un concentrato chiaro e veloce da metabolizzare. Leggere una pagina di Tolentino dà l’effetto di acquisire conoscenza senza la fatica della comprensione, o la noia della ricerca. Tolentino fa il lavoro sporco per noi, distilla i punti focali delle preoccupazioni dibattute dalla classe media americana negli ultimi dieci anni. Mette tutto in ordine cronologico, a mo’ di riepilogo delle puntate precedenti (perfetto per boomer rinsaviti dal loro privilegio o zoomer troppo piccoli per ricordare la vita prima di internet) senza, però, districare la matassa. Lei è la prima a ridimensionare l’innovazione del suo metodo, rivendicando il valore dell’esattezza e della sintesi per diffondere un’idea quanto più possibile comprensibile, rispetto al dovere di produrre argomentazioni originali, o vagliare prospettive inedite. Fa sua una riflessione della scrittrice Deborah Eisenberg, “scrivere per allentare una serie di elementi dati”, a sostegno della sua capacità di illustrare informazioni complesse con economia di spazio e concisione di linguaggio. Spesso, tuttavia, l’erudizione viene sostituita con la sua esperienza personale: l’obiettivo sembra essere quello di creare un senso di intimità, accorciare le distanze con la lettrice imbastendo un repertorio di ricordi e referenti che si presuppongono comuni, incoraggiare riflessioni filosofiche facendo leva sulla sua biografia invece che sulla teoria. Non ha pazienza per distrazioni o divagazioni, Tolentino scrive per centrare il punto.
Ci fu un momento in cui la scrittura di Tolentino mi insegnò molto su cosa è meritevole di attenzione. Quando inciampai su “Notes on 21st-Century Mystic Carly Rae Jepsen” in una giornata autunnale del 2015, ci fu una piccola detonazione nel mio cervello. All’epoca – un periodo formativo in cui affinavo il mio gusto e i miei interessi – già sapevo che era possibile pensare alla cultura bassa e alle arti marginali con dignità e rigore, che interessarsi a ciò che esisteva fuori da un canone di gusto era rilevante, anzi, politico: quella, però, era la prima volta che la cultura pop in esame era mia, qualcosa di cui avevo goduto in prima persona, avendo passato l’estate del 2012 canticchiando Call Me Maybe. Leggendo la riflessione di Tolentino sui testi sdolcinati di Carly Rae Jepsen, qui paragonati alle illuminazioni di Simone Weil, le mie sinapsi collegarono tutto: austero e sciocco potevano convivere, e lo sguardo analitico poteva essere attento e contemporaneamente divertito. Ero incantata dalla semplicità dello stile e dall’originalità delle idee, colpita dalla gioia della scrittura, esaltata dall’ammirazione trasparente che Tolentino provava per entrambi i soggetti del suo pezzo, l’icona pop e la pensatrice. Finito di leggere l’articolo ero estatica, mi sentivo più intelligente, più conscia delle sottigliezze che tengono insieme persone, opere e tempi.
Quel pezzo fu il primo sballo con una nuova droga: ho continuato a seguire, con oscillante devozione, la carriera sfolgorante di Tolentino, ma niente di quello che ho letto da allora è più stato in grado di ripetere l’esaltazione della prima volta. Ero perfettamente conscia dell’impossibilità di vedere in lei un modello cui aspirare: l’infrastruttura in cui si muove Tolentino non esiste in Italia, la stessa lingua italiana fatica ad adattarsi agli spazi aperti dell’internet come sa fare l’inglese. In pochi anni Tolentino è riuscita a fare il salto dai blog a tematica femminile/femminista, The Hairpin e Jezebel – forme di media indipendenti o sussidiarie (Jezebel era parte del network Gawker Media) il cui business model era imperniato sulle entrate provenienti dalle inserzioni pubblicitarie – allo storico gruppo editoriale Condé Nast, nella redazione di un New Yorker ansioso di svecchiarsi. Scrivere in pubblico, in italiano, di donne e per le donne, fondarci sopra una carriera è inconcepibile in un paese che è riuscito ad assorbire l’urto #metoo annientando qualunque tentativo di affrontare una presa di coscienza nazionale, i cui editorialisti hanno scoperto – con orrore – booktuber e bookstagrammer l’altro ieri, in cui il disinteresse per necessità e desideri delle donne è inscalfibile. Ho continuato a leggere Tolentino da lontano, come una fantasia d’evasione: la sua ascesa a diva delle lettere, d’altronde, sembra la trama di una qualunque commedia rosa americana. La sua fama crescente, insieme all’editing ingombrante tipico del New Yorker, tuttavia, mi davano l’impressione che la sua scrittura avesse iniziato a smussarsi: per ogni articolo che metteva nero su bianco tendenze impalpabili come l’ubiquità della “Instagram face” leggevo un vanitoso reportage sul suo shopping, per ogni recensione brillante ne leggevo una da cui faticavo a trovare appigli oltre al riassunto della trama. E, soprattutto, non potevo più negare che la sua costante presenza nei suoi articoli – in prima persona, più personaggio che voce – avesse iniziato ad urtarmi.
Il saggio, per Tolentino, è un frammento di presente fissato su una pagina di diario, un lungo blogpost che registra sentimenti immanenti, urgenti.
Accolsi la prima uscita di Trick Mirror, ad agosto 2019, vorrei credere più assuefatta allo stile Tolentino che dipendente dalle sue osservazioni: iniziai a leggerlo subito, ancora suscettibile al gesto rituale attorno a nuovo materiale tolentiniano, il ricordo della sensazione di comprensione limpida ancora ben chiaro in corpo. Il libro era stato accolto con plauso critico e successo di vendite: ero sicura che l’avrei amato. Riconobbi le tematiche care a Tolentino – la dipendenza da social network, la costruzione della femminilità normativa, il disincanto per le mitologie americane di successo e ricchezza, il valore dei libri per l’identità, la sfrontatezza nel parlare di pasticche e fumo – e il libro mi apparve subito come la cristallizzazione dei primi dieci anni di carriera di Tolentino, un compendio su carta di quanto aveva visto e pensato online. Durante la lettura, però, scoprii che Trick Mirror porta all’estremo la tendenza di Tolentino a centrare sé stessa nella sua scrittura: sia come fulcro dell’esperienza, che filtro delle sue implicazioni. Tolentino si sdoppia, triplica, camuffa l’azione selettiva in atto e distrae la lettrice con un fantoccio di sé stessa piazzato al centro della scena. Se Tolentino protagonista cattura tutti gli sguardi – come personaggio, Tolentino è immancabilmente divertente, lucida, curiosa, buona con sé stessa e con gli altri, adorabile soprattutto quando combina guai – Tolentino scrittrice manovra il gioco di specchi a suo favore, resta al sicuro nell’ombra. Trick Mirror non è stato commercializzato come un memoir, ma la mole di aneddotica personale che contiene è impressionante.
Da una parte Tolentino usa la propria storia come prova dei meccanismi sociali ed economici che descrive: anche lei ha rischiato di essere violentata dopo aver ingerito Rohypnol (una “droga da stupro”) con il suo drink, anche lei ragiona sull’illusione del voto matrimoniale, ma convive in coppia monogama con il compagno di lunga data. Anche lei sente la pressione di dover apparire magra e in forma, e si massacra ogni settimana di ginnastica Barre, ma detesta la fisiologia del corpo abbastanza da sbeffeggiare i flati vaginali della compagna di yoga che affonda in virabhadrasana II. Tra le ultime frasi della raccolta, Tolentino ammette – sembra quasi di sentirla sospirare – “Mi sono sempre adattata a tutto quello contro cui avrei voluto oppormi”. Dall’altra, Tolentino tratta la sua biografia come miniera di storie eccezionali: concorrente sedicenne al reality show Girls v. Boys: Puerto Rico; cristiana devota in una megachurch di Houston, Texas, che perde la fede nel divino e la ritrova nelle pasticche di ecstasy; volontaria dei Peace Corps in Kirghizistan evacuata a una settimana dall’arrivo perché il governo del paese è stato ribaltato da un colpo di stato. Trick Mirror opera secondo una logica magnetica: non argomenta per persuadere, ma descrive e si racconta per evocare una sorta di prossimità con chi legge. Intimità e condivisione sostituiscono l’andamento ipotetico di un saggio a tesi: Tolentino non ha bisogno di convincere, quando può intrattenere. Il saggio, per Tolentino, è un frammento di presente fissato su una pagina di diario, un lungo blogpost che registra, qui e ora, sentimenti immanenti, urgenti, atmosferici. Non è certo un programma, un ordine del giorno che spinga o immagini, qui e ora, l’organizzazione di futuri possibili. E durante le presentazioni del libro, Tolentino lo mette in chiaro: “There are no takeaways here”, nessuna morale, nessuna proposta qui dentro.
La critica e docente Lauren Berlant ha prodotto, nell’arco di un trentennio, una serie di studi dedicati al “sentimentalismo nazionale” statunitense: l’obiettivo del progetto è mappare i referenti ibridi che secoli di osmosi tra sfera civica, senso di appartenenza personale, infrastrutture del riconoscimento politico hanno creato. In sostanza, come la cultura americana ha creato i propri ideali di “buona vita”, cittadinanza, rappresentazione politica sulla base dell’attaccamento affettivo condiviso tra singoli. Berlant è esponente di spicco della affect theory, una corrente dell’accademia umanista anglofona che segue le iterazioni cognitive, materiali e corporali – emozioni, sentimenti, stati d’animo – attraverso la loro espressione e tipizzazione in produzioni artistiche e culturali. Applicando questo quadro metodologico, Berlant analizza un vasto repertorio americano di romanzi, poesie, film, adattamenti per il teatro, pamphlet, scritture spurie ancillari alla promozione di prodotti d’intrattenimento. I sistemi teorici che Berlant ne ricava – seguendo le trame dei sentimenti e i sottotesti emotivi emanati dalla popolarità del singolo lavoro – raccontano i lati scomodi della fantasia americana del benessere e della meritocrazia.
È nella voglia di essere convenzionali, accontentarsi della fantasia di un mondo in cui si può fiorire, non solo sopravvivere, che Berlant situa il nucleo di un discorso culturale cui Tolentino è erede.
In The Female Complaint: The Unfinished Business of Sentimentality in American Culture (2008, inedito in Italia), Berlant individua i tratti comuni della “cultura femminile” (“women’s culture”) statunitense del ventesimo secolo: all’intersezione tra un’estetica sentimentale raffinata e una coscienza orientata alla solidarietà progressista nascono romanzi e film (alle volte creati da donne, più spesso destinati a un pubblico di donne) che illustrano le difficoltà della vita intima delle donne. È una forma di lamento che, sebbene indichi le cause materiali d’intralcio alla realizzazione individuale, non fomenta l’insoddisfazione. Al contrario, procura piacere, e un senso di comunità: le “female complainers”, le “lamentatrici” di Berlant hanno in comune “storie in cui imparano ad adattarsi, un addestramento alla gestione della delusione che riesce a fornire una critica senza trafficare con i grandi rifiuti politici”. La lamentela si sublima in una “fantasia di genericità attraverso la somiglianza emotiva entro la sfera del dolore”.
La tradizione descritta da Berlant funziona in forza dell’idea che, per le donne, l’esperienza di vita non sia individuale, ma sia capita, se non condivisa, da tutte le altre donne. Una posa ideologica forse, ma comunque corroborata dalla popolare nozione che, in questa società, la vita emotiva e cognitiva delle donne sia ignorata, una risorsa sprecata perché soffocata da imposizioni trivializzanti. Ci si riconosce, insomma, tra pari subalterne, tese nello sforzo di migliorare le proprie condizioni nella speranza di vivere meglio, e contemporaneamente affondate da affetti appiccicosi e semplici: il desiderio di appartenere a un gruppo sociale, il sogno di vivere senza ansia, l’utopia di un’unione tra etica individuale e moralità delle istituzioni.
L’ambivalenza è essenziale in questa categoria di discorsi culturali: da una parte c’è la necessità di limare gli attriti sistemici della vita quotidiana, dall’altra persiste la devozione alla normalità delle cose, il progetto utopico ridotto alla soddisfazione del riposo e del riconoscimento. Tattiche gestionali che massimizzano il piacere e circoscrivono le pressioni sono dappertutto nella cultura popolare americana, specialmente femminile: “in una visione del mondo sentimentale, l’‘interesse’ della gente è meno legato alla volontà di cambiare il mondo quanto al non volerne essere schiacciato, trovando, nel frattempo, la soddisfazione di piaceri minori e fantasie più grandi” scrive Berlant. L’invenzione, la negoziazione, l’adattamento, la protezione sono i meccanismi del “tirare avanti”, insieme al rifiuto di ottenere “legittimità attraverso il potere” restando sotto il radar della politica. È nella voglia di essere convenzionali, aspirare a una felicità generica – che non solo si “sente”, ma è riconosciuta e raccontata come tale dalla comunità – accontentarsi della fantasia di un mondo in cui si può fiorire, non solo sopravvivere, che Berlant situa il nucleo di un discorso culturale cui Tolentino è erede. “Nella vita reale, le donne sono molto più obbedienti. Le nostre ribellioni sono così triviali e piccole” scrive Tolentino in “Ottimizzarsi sempre”.
Essere generica è fondamentale per Tolentino, sia come personaggio che come autrice. D’altronde, Tolentino mercanteggia per archetipi: la donna ideale, i sette scammer della generazione millennial, le eroine delle favole. Berlant intende “generalizzazione” come un processo per cui “ciò che è singolare viene delaminato dalla sua posizione nella storia di una persona o dall’irriducibile storia locale di un luogo e messo in circolazione come prova di qualcosa di condiviso”. Lo fa in un libro più recente, Cruel Optimism (2011, inedito in Italia), in cui passa in rassegna non tanto le forme di esistenza organizzate dal sistema capitalista, quanto la disorganizzazione del quotidiano operata dalle forze economiche e politiche contemporanee. L’“ottimismo crudele” del titolo si verifica quando
…qualcosa che desideri è in realtà un ostacolo alla tua prosperità. Può riguardare cibo, un tipo di amore, può essere una fantasia della buona vita, o un progetto politico. Può anche appoggiarsi a qualcosa di più semplice, come una nuova abitudine che ti promette un modo d’essere migliorato. Si tratta di relazioni ottimiste che non sono indecentemente crudeli. Diventano crudeli quando l’oggetto del tuo attaccamento impedisce attivamente l’obiettivo che ti eri prefissato all’inizio.
Berlant si chiede perché le persone restino attratte e fedeli a ideali fantasiosi come l’amore romantico, la solidità delle famiglie, la scalata sociale, l’interesse civico delle istituzioni, il valore esistenziale delle professioni, quando i segni del loro cedimento e obsolescenza sono bene visibili ovunque. Tolentino, invece, non se lo chiede, si limita a descrivere ridicolaggine e falsità delle pratiche che ci ostiniamo a ripetere sperando di migliorarci, vivere bene o meglio. Sapere di essere parte del problema, però, non le impedisce di continuare a esistere in un sistema che, lo ricorda per prima con estrema frequenza, l’ha premiata.
Tolentino incarna le mitologie americane meglio radicate: è la good immigrant, la brava figlia di immigrati che si dà da fare, she pulled herself up by her bootstraps, si è fatta strada da sola grazie alle sue capacità, riconosciuta senza agganci o favori, è una self-made woman, il suo successo è solo suo, frutto di ore di lavoro sodo. Figlia di immigrati filippini, cresciuta in Texas, Tolentino ha frequentato due corsi universitari con borse di studio (risparmiandosi anni di debito studentesco, a differenza di gran parte dei suoi coetanei), è entrata nell’industria editoriale statunitense a forza di blogpost e editing online: tutto ciò è diligentemente annotato nei nove saggi di Trick Mirror, e corroborato da una martellante campagna di autopromozione in corrispondenza dell’uscita del libro negli Stati Uniti. Tolentino ha parlato pubblicamente della sua dieta settimanale tipo, del suo cane, dei suoi recenti acquisti, delle sue vacanze, della sua skincare, della sua marca di reggiseni preferita, del suo consumo regolare di marijuana. Tolentino riesce a dare l’illusione di essere generica nonostante la marcata eccezionalità della sua biografia: è l’unica milliennial che ce l’ha fatta, ma è adorata perché ostenta incredulità davanti alla sua stessa buona sorte, si posiziona come una qualunque ragazza basic, esperta di scemenze irrilevanti come tutte noi, sebbene sia capace di trattarle con rigore e serietà. E se non ispira ammirazione o il desiderio di esserle amica, Tolentino genera un’invidia potentissima.
Una delle poche recensioni negative di Trick Mirror risulta estremamente pesante da leggere perché l’autrice, l’ottima critica letteraria Lauren Oyler, rosica troppo. Il disprezzo per Tolentino come persona, prima ancora che per il suo libro, è così trasparente da dare i brividi: la recensione Ha ha! Ha ha!, pubblicata dalla rivista inglese London Review of Books, puntualizza con acume le debolezze del progetto e alcune inesattezze nei contenuti, ma le frecciate rivolte alla persona tratteggiata nei riferimenti autobiografici riescono a minare la professionalità dell’intero pezzo, trasformandolo in un’elaborata sequela di gossip contro la cheerleader più popolare della scuola. L’ubiquità del personal brand Tolentino può nauseare, considerando anche quanto innecessario può risultare l’esporre così tanto della propria vita e personalità quando un contratto con la rivista New Yorker garantisce in automatico stabilità e autorevolezza.
Il logorante lavoro di autopromozione di Tolentino è il soggetto di The Writer as Influencer, articolo di Allegra Hobbs comparso su Patreon e poi rilanciato dal Guardian inglese. Hobbs mescola identità e scritture di una serie di firme femminili newyorkesi, senza distinguere tra influencer e intellettuali. Il risultato è una deprimente disamina della componente monetizzabile del sé che deve accompagnare i testi prodotti dall’Autrice Ambiziosa: una miscela calibrata di assaggi del proprio quotidiano su Instagram, argute opinioni personali su Twitter che, rifratte dall’internet, producano il giusto equilibrio tra identificazione e riverenza, e quindi attenzione e fedeltà dal pubblico. Hobbs riporta una conversazione privata con Tolentino:
Ho chiesto via mail a Tolentino di parlarmi di esposizione mediatica, della curatela di un’immagine pubblica online, e fino a che punto lei lo faccia con consapevolezza. [Tolentino] ha risposto che era una questione a cui pensava spesso, dato che era stata ‘incastrata (con sua grande fortuna) nel demoralizzante
ingranaggio della promozione editoriale’. L’imperativo di mercificare sé stessa per vendere il suo lavoro la angoscia, ma è qualcosa che riconosce come inesorabile. ‘Una buona parte del mio libro parla di come capitalismo, internet, il sé mercificato distruggano la nostra capacità di funzionare come veri umani; eppure, meglio esprimo quelle idee, più io stessa divento un oggetto facile da smerciare’, spiega Tolentino. “Ho trascorso molto tempo, durante la promozione di Trick Mirror, chiedendomi se il lavoro che porta più significato alla mia vita (scrivere) finirà sempre per trascinarmi più a fondo tra le grinfie delle cose che odio (il capitalismo, e un modo d’essere per cui gli incentivi esterni sembrano più importanti di quelli interni)’.
Eppure, Trick Mirror è ricco di consigli ragionevoli, quasi facili da mettere in pratica. In “La i di io in internet”, Tolentino propone la strategia che ha elaborato per rendere la partecipazione imperativa ai social network meno corrosiva per mente e anima: una sorta di principio di piacere che regola lo scorrimento infinito dei post, per cui ci si costringe a disconnettersi quando lettura e coinvolgimento smettono di essere divertenti. Quando si è già instaurato un rapporto di dipendenza da social, tuttavia, non è certo semplice controbilanciare le esche che stuzzicano e distraggono sforzandosi di auto-controllarsi, oppure centellinare la propria attenzione, e la proposta di Tolentino infatti indica la torsione di base che permette ai gestori delle piattaforme di capitalizzare sul bisogno di essere visti di ogni utente. Per salvaguardare tempo, umore e reputazione – la nostra umanità in breve – bisogna spostarsi verso un modello d’identità che valorizzi “responsabilità, contraddizione e irrilevanza”, suggerisce Tolentino. “Ottimizzarsi sempre” e “Il culto della donna difficile” mettono in guardia contro gli stessi tentativi di monetizzare quello che sta a cuore alle persone: diffidare sempre di qualunque strategia di marketing che appiccichi parole dubbie come “empowerment” o “self-care” a un prodotto per venderlo, allontanarsi dalle narrazioni in cui l’aggettivo “femminista” accompagna i termini “eroina”, “modello”, “riferimento”.
Tutto ciò, cioè, che celebra il dovere e la fatica del singolo per ammorbidire il mondo in cui vuole sopravvivere, senza mai mettere in discussione l’inospitalità del sistema stesso. “Veniamo dalla vecchia Virginia”, dietro l’apparenza di un saggio d’accusa alla cultura dello stupro, nasconde anche una riflessione sulle convenzioni cui le storie ufficiali e i resoconti personali che mirano a rendersi intelligibili, credibili, condivisibili devono adottare: “comprendo l’esperienza di essere ingannati da quello in cui si vuole credere. Le buone intenzioni spesso creano punti ciechi”, scrive Tolentino. Specialmente nelle denunce di abusi sessuali, esiste la spinta a creare un racconto dell’aggressione subita che confermi i fattori considerati meritevoli di interesse: un binarismo netto tra colpevole e vittima, tracce di violenza inconfondibile, un rapporto di conflitto inequivocabile, ben al di là della contrattazione sul consenso. Non si tratta di una falsificazione, Tolentino sottintende, ma di un tentativo, anche inconscio, di far combaciare la propria storia agli unici casi che una corte – pubblica, virtuale, o di tribunale – riconosce come prove incontrovertibili per spartire la responsabilità e amministrare giustizia. Un’altra istanza, in pratica, in cui il sé si flette e posiziona cercando di riconoscersi nel riflesso che l’altro vuole vedere.
Quando ragiona per assiomi, Tolentino trascrive con limpidezza le intuizioni più riconoscibili, malleabili abbastanza da poter essere distinguibili ovunque la vita sia imbrigliata in logiche di mercato. Quando scende nei particolari e negli esempi, imprescindibili per sostenere le sue tesi, il progetto di Tolentino rivela però le sue parti più ermetiche, perlomeno a seconda della localizzazione di chi legge: avendo eliminato ogni glossa per mantenersi testo maneggevole, e lavorando su una base di affinità e condivisione di memorie e saperi, oltreconfine l’americanità intrinseca di Trick Mirror diventa un bagaglio poco maneggevole. I casi studio di Tolentino difficilmente evocheranno, fuori dall’egida anglofona, la stessa sensazione di confortevolezza, di ritorno a casa, di riconoscimento cui punta lo stile amicale della raccolta. Molte delle eroine descritte nel saggio “Eroine pure” vivono dentro libri per l’infanzia che perlopiù non esistono in traduzione, o comunque non fanno parte del canone proposto a bambine e bambini italofoni. L’isolazionismo dei campus universitari e i meccanismi di fraternities e sororities sono, per fortuna, alieni al nostro modo di intendere l’università e l’aggregazione tra studenti. La legislazione in materia di abuso sessuale è, ovviamente, diversa. Disastri come il Fyre Fest di Billy McFarland, l’impero #GIRLBOSS di Sophia Amoruso, i falsi crowdfunding per Juicero e Theranos arrivano come echi all’altra parte dell’oceano, dove la generazione millennial può indicare (o forse no?) esempi di truffe autoctone molto più influenti.
L’inclusione della tetralogia L’amica geniale e I giorni dell’abbandono di Elena Ferrante nel canone delle eroine femminili – unico esempio di letteratura contemporanea non angloamericana – è oltremodo riduttiva. “Eroine pure” sostiene una proposta speculativa che immagina la vita “tipo” di un personaggio femminile seguendo le trame letterarie più classiche e popolari. Il ricorso a Ferrante, in coda al saggio, offre una gradita deviazione della modalità narrativa “standard”, per cui la successione da infanzia innocente, adolescenza triste a maturità amara viene, finalmente, raccontata in termini esplicitamente femministi. Tolentino, tuttavia, sceglie di focalizzarsi sulle fonti di ispirazione di cui Ferrante discute nelle interviste – Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione (1997) di Adriana Cavarero e Non credere di avere dei diritti (1987) a cura della Libreria delle donne di Milano – piuttosto che illustrare i riferimenti autentici affrontati nei suoi libri.
Il radicalismo del Manifesto di Rivolta sarebbe senz’altro in sintonia con il rigetto del femminismo pop che Tolentino elabora nel suo libro.
Tolentino non registra l’influenza o l’assenza di un panorama culturale specifico sulle protagoniste dei romanzi quando riassume il cuore della tetralogia – “Lila e Lenù si definiscono l’una contro l’altra, ognuna come un libro che l’altra sta leggendo, ognuna rappresentando una storia alternativa di ciò che potrebbe essere la vita” – preferendo circoscrivere il contesto teorico del femminismo italiano all’interpretazione dell’opera di Ferrante. È indubbio che L’amica geniale, nella sua totalità, possa essere considerata un esercizio di “affidamento”, la pratica creata nei laboratori italiani di autocoscienza femminista cui Cavarero fa menzione nel saggio citato: la comprensione della propria vita attraverso l’ordine narrativo creato da un’altra donna amica. La premessa della saga è, infatti, che Lenù, ormai anziana, si metta a scrivere la sua storia per raccontare la vita dell’amica Lila, seguendo la stessa pratica di identificazione attraverso il racconto dell’altra che Cavarero descrive. Ma il racconto di Lenù nasce da un sentimento di rabbia, un desiderio di rivalsa: “Vediamo chi la spunta questa volta, mi sono detta. Ho acceso il computer e ho cominciato a scrivere ogni dettaglio della nostra storia, tutto ciò che mi è rimasto in mente”, conclude il prologo del primo volume, L’amica geniale. Nessuna delle protagoniste partecipa mai a un gruppo di autocoscienza, e il coinvolgimento nel movimento italiano di seconda ondata è marginale, nel caso di Lenù, e del tutto assente per Lila: anzi, è cruciale per l’economia dell’opera che una delle protagoniste riesca a interpretarsi, seppure solo teoricamente, in una cornice femminista, mentre l’altra prosegua e rivendichi una vita di adesione alle convenzioni di genere ereditate.
L’inquadratura critica d’insieme che Tolentino predilige – e all’interno di un saggio incentrato sulle pagine delle storie, non le loro interpretazioni – è un posizionamento a posteriori, rarefatto dal passaggio di anni tra il momento della pratica e il racconto della riflessione che ne è scaturita, elaborato da una filosofa che, con una veloce ricerca Google, rivelerà al pubblico americano la sua lunga collaborazione con Judith Butler, risultando forse più approcciabile di altri nomi esotici mai sentiti prima. Tolentino conclude il suo saggio scandendo il suo desiderio di intendere le sue eroine letterarie come madri, alla maniera dei collettivi della Libreria delle donne di Milano, ovvero come figure da cui, insieme, dipendere e opporsi per diventare qualcos’altro, qualcosa di più. L’ideale materno di Tolentino si sarebbe armonizzato bene con le considerazioni di Luisa Muraro – tra le fondatrici, nel 1975, della Libreria delle donne di Milano – autrice di studi sulla costruzione della figura materna (L’ordine simbolico della madre, 1991, tradotto in inglese nel 2018) che costituiscono l’ossatura teorica della tetralogia di Ferrante, i cui personaggi tendono a muoversi secondo percorsi di emulazione e disconoscimento materno-filiale piuttosto che assecondando vicinanze d’affinità meramente amicali o sororali. Il discorso è già ben avviato, “Il vapore erotico del corpo materno” è il titolo dell’intervista tra Ferrante, Muraro, e Marina Terragni, raccolta nella miscellanea La frantumaglia (2016), la stessa raccolta in cui Ferrante la cita come un nome imprescindibile: “Dovrò pagare un obolo all’urgenza femminile di imparare ad amare la madre? Racconterò di come mia madre mi stringeva la mano per strada quand’ero piccola, partirò di là […] e poi troverò una strada per svolgere il mio compitino fino a citare ad arte Luce Irigaray e Luisa Muraro.”
La scrittura a palinsesto di Tolentino e, in eco, la mia, rischiano di ignorare i momenti in cui Ferrante è più attenta a puntualizzare la sua visione femminista, per esempio nominando nel terzo tomo della tetralogia, Storia di chi fugge e di chi resta (2013), l’intellettuale femminista italiana Carla Lonzi, le cui pagine sono una lettura fondamentale per la maturazione femminista della co-protagonista Lenù. Tolentino oblitera l’effetto esplosivo, che Ferrante descrive esplicitamente nella sua prosa narrativa, dei testi che Lonzi pubblica nel corso degli anni ’70, partendo dal Manifesto di Rivolta Femminile (co-redatto insieme a Elvira Banotti e Carla Accardi, 1970) e poi sviluppando pratica e pensiero tra gruppi di autocoscienza e attività editoriale indipendente. “Com’è possibile, mi dissi, che una donna sappia pensare così? Ho faticato tanto sui libri, ma li ho subìti, non li ho mai veramente usati, non li ho mai rovesciati contro se stessi. Ecco come si pensa. Ecco come si pensa contro. Io – dopo tanta fatica – non so pensare. Nemmeno Mariarosa sa: ha letto pagine e pagine e le ricombina con estro, dando spettacolo. Tutto qui. Lila invece sa. È la sua natura. Se avesse studiato, avrebbe saputo pensare a questo modo”, pensa Lenù. E Ferrante prosegue nominando il titolo del libretto verde La donna vaginale e la donna clitoridea (1971), che fa ridere Lila; cita la nozione cardine “soggetto imprevisto”, fondamento e punto d’arrivo del percorso di svuotamento e ricreazione autonoma a partire dal riconoscimento dell’identità femminile differenziata; lascia sottinteso che il saggio sulla storia dell’identità femminile nei racconti biblici a cui lavora Lenù risenta della lettura di Sputiamo su Hegel (1970).
Eppure il radicalismo del Manifesto di Rivolta sarebbe senz’altro in sintonia con il rigetto del femminismo pop che Tolentino elabora in “Ottimizzarsi sempre” e “Il culto della donna difficile”, vista l’enfasi posta sui concetti di riconoscimento e sostegno alla cura e al lavoro domestico cui Tolentino implicitamente ascrive quando dice “Il vero femminismo riguarda il benessere collettivo”, qualcosa che non ha nulla a che fare con il successo della singola donna più ricca, più bella, più produttiva. “Detestiamo i meccanismi della competitività e il ricatto che viene esercitato nel mondo dalla egemonia dell’efficienza” scrivono Lonzi, Banotti e Accardi; “Per quanto riguarda la bellezza, abbiamo implementato la tecnologia non solo per soddisfare le esigenze del sistema, ma per espandere effettivamente queste esigenze. […] Non abbiamo ‘ottimizzato’ i nostri salari, il nostro sistema di assistenza all’infanzia, la nostra rappresentanza politica”, scrive Tolentino. “Riesaminiamo gli apporti creativi della donna alla comunità e sfatiamo il mito della sua laboriosità sussidiaria” scrivono Lonzi, Banotti e Accardi; “La donna ideale è sempre stata sovraccaricata concettualmente, una cosa inorganica progettata per apparire naturale. Storicamente, è alla ricerca di tutte le cose che le donne sono addestrate a trovare divertenti e interessanti: la domesticità, il miglioramento fisico, l’approvazione maschile, il mantenimento della piacevolezza, le varie forme di lavoro non retribuito”, scrive Tolentino. Il sospetto è che Tolentino selezioni gli aspetti più fotogenici del femminismo italiano, come l’immagine evocata da Cavarero di due donne che, chiacchierando, rafforzano le rispettive identità: un’immagine immediata, facile da assimilare all’interpretazione americana de L’amica geniale come una storia di amicizia femminile. Tutto il potenziale radicale, generativo, combattivo del pensiero femminista italiano di seconda ondata resta taciuto, così come è rimandata una valutazione dell’opera di Ferrante sensibile al suo contesto italiano (o meglio, napoletano), o come esempio di scrittura femminile inserita in una tradizione filosofica localizzata e fortemente imperniata sulla riflessione sulla lingua.
Tra le mani di una persona che con Tolentino condivide poco più che identità di genere e coscienza della propria subalternità in una società patriarcale, Trick Mirror perde il suo lustro di testo iconico: la peculiare sfera di intimità pubblica che riesce a creare entro i confini nazionali (o nell’area di prossimità linguistica e culturale) crea, a distanza, un riflesso straniante. Usare Trick Mirror come ha fatto il pubblico americano, come uno specchio che riflette, a volte ingrandendo, a volte snellendo, l’io vivo dentro una cultura nazionale condivisa, è una postura che rischia di distorcere ancora di più l’immagine di sé se la si va cercando tra le pagine di un testo in traduzione, pensato dentro e per un panorama di referenti che altrove semplicemente non ci sono. Lo specchio di Tolentino, d’altronde, come avverte dal titolo in copertina, riflette per scherzo, le sue curve convesse e concave deformano, non permettono certo di vedere dietro gli angoli. E il personaggio Jia Tolentino che Tolentino scrive non è certo un individuo ben illuminato, o riflesso a tutto tondo.
È importante notare che Tolentino declina di trattare la sua identità razzializzata di cittadina americana brown, donna Asian American di origini filippine, se non in termini di mera rappresentazione (da piccola veniva costretta a giocare nel ruolo del Power Ranger giallo quando avrebbe voluto essere quello rosa, e non esistevano protagoniste asiatiche nei libri e film con cui è cresciuta, spiega in “Eroine pure”), e come fonte della sua attitudine al concepirsi contemporaneamente dentro ed esclusa dal gruppo (riabilitando il discorso dell’etnicità a una categoria generica, rilevante perché permette l’autoidentificazione). La sua sensibilità verso le tensioni sociali di matrice razziale sembra, piuttosto, una spinta carsica che riaffiora nei momenti più impensati della raccolta: Tolentino fa notare come gli addetti alla ristorazione impegnati ad assemblare insalate fast-food abbiano tutti la pelle più scura dei clienti dall’altro lato del bancone (“Ottimizzarsi sempre”); oppure puntualizza l’embricatura tra le istituzioni del potere bianco, “droga, chiesa, e denaro”, e la cultura black e brown su cui si appoggiano (“E(c)stasi” ). Quando riprende la prima persona, Tolentino tratta la sua discendenza ed apparenza asiatiche come contingenze: a volte il suprematismo bianco l’ha danneggiata, altre l’ha avvantaggiata per la sua prossimità fenotipica (“La i di io in internet”); è vero che i suoi tratti asiatici l’hanno messa in pericolo laddove il suo aspetto la confondeva tra le donne autoctone, neutralizzando l’immunità garantitale dal suo passaporto (“Noi veniamo dalla vecchia Virginia”).
L’abbaglio che Tolentino rischia di generare mettendo sé stessa al centro è la falsa convinzione, da parte dei lettori, che tutta la sua vita debba essere di pubblico dominio per arrogarsi il diritto di pensare ad alta voce.
Tolentino non tratta nello specifico il tema del sé americano all’estero, o l’identità razzializzata calata in un ambiente privo di una specifica tradizione di razzismo istituzionalizzato. Abbozza per sommi capi – all’interno di un saggio sul racconto delle molestie sessuali – il lungo periodo che ha trascorso fuori dal territorio statunitense nell’ambito di un progetto di volontariato con i Peace Corps, dal quale rientra con la TBC, ma anche scoprendo la coesistenza possibile tra il suo “osceno potere di cittadina americana” e la sua “oscena impotenza di donna”. Della traumatica esperienza come insegnante di inglese in un villaggio rurale del Kirghizistan – che descrive come una repubblica post-sovietica “ignota, bellissima, illogica” – è riportato lo scontro con il violento sessismo locale a scapito di qualunque altro ricordo (Tolentino spiega durante una presentazione pubblica che il motivo per cui ha scelto di tralasciare il periodo nei Peace Corps è perché non si fidava della sua memoria, e non aveva conservato diari dell’epoca che le permettessero di effettuare un fact-checking di se stessa). Che Tolentino si sia presa lo spazio per elaborare su carta il suo trauma è il picco della scrittura in prima persona in Trick Mirror, il fatto che scelga di non trattare il tema dell’identità razzializzata salta all’occhio – se da una parte Tolentino sacrifica uno degli elementi virtualmente più personali e identificativi, dall’altra però schiva i fattori più conflittuali e potenzialmente scomodi della sua storia, mantenendo intatta la genericità dell’intero progetto – ma resta una scelta legittima. La selezione è una componente cruciale di questo tipo di scrittura: escludere non significa occultare, tuttavia l’abbaglio che Tolentino rischia di generare mettendo sé stessa al centro è la falsa convinzione, da parte dei lettori, che tutta la sua vita sia già, o debba, essere di pubblico dominio per arrogarsi il diritto di pensare ad alta voce.
Non sorprende, purtroppo, che le gelosie generate, laddove incapaci di appigliarsi al valore della scrittura, abbiano trovato sfogo nel pettegolezzo riguardo la persona di Tolentino e la sua famiglia. Durante il confinamento profilattico alla diffusione del virus COVID-19 della primavera 2020, Tolentino ha scritto un blogpost, intitolato Listen, I wanted quar gossip too (“Ascolta, anch’io volevo un po’ di pettegolezzi da quarantena”) per difendersi dai sempre più numerosi attacchi sui social network – tentativi di “cancellare” Tolentino diffamandone la reputazione – che intimavano alle presunte passate attività da “trafficanti di esseri umani” dei suoi genitori. È vero che i Tolentino sono stati implicati nei primi anni 2000 in un lungo processo penale relativo alla liceità delle pratiche esercitate dalla loro agenzia di intermediazione (il cui operato consisteva nell’assistere l’iter burocratico e la ricerca di impiego di futuri immigranti negli Stati Uniti) nei confronti di infermiere e insegnanti filippine, che si è concluso con un plea bargaining (ammissione di colpevolezza in cambio di uno sconto di pena). Si tratta, però, di un procedimento che, concluso e archiviato, non ha in alcun modo coinvolto Tolentino stessa, all’epoca dei fatti adolescente.
Non entrerò nel merito della questione – sarebbe lecito solo un commento giuridico agli atti del processo – ma mi preme segnalare quanto gli attacchi a Tolentino facessero leva sulla sua presunta autorità morale. Il fatto che Tolentino abbia raccontato elementi intimi, potenzialmente scabrosi o imbarazzanti della sua vita – le droghe, la vita nella megachurch, la storia d’amore con l’attuale compagno, il reality girato in Portorico – ma abbia scelto di soprassedere sul processo dei genitori, è stato letto come l’indice pretestuoso che la sua tensione verso la vita etica sia una semplice posa. La questione del “bene”, come “essere buona”, che aspetto ha una vita “morale” sono tutte preoccupazioni esplicite nei testi e nella persona pubblica di Tolentino, ma le sue principali strategie – evocare genericità e fornire assiomi che concentrano e semplificano ragionamenti enormi (che sono soprattutto, facilmente estrapolabili e riproducibili altrove: io stessa ho usato una citazione-slogan, impareggiabile per immediatezza e chiarezza, in un mio vecchio saggio) – le permettono, tuttavia, di ignorare varie zone cieche delle situazioni di cui scrive. Il focus privilegiato sul singolo – sé stessa, autori e autrici che cita, i personaggi su cui indaga (dagli scammer agli altri boys e girls del reality show) – taglia la presenza di intermediari, infrastrutture, pubblico, folle e individui anonimi e invisibili.
Tolentino ripercorre, in “E(c)stasi”, la storia dell’invenzione e della diffusione dell’MDMA senza mai sbirciare oltre la legislazione federale statunitense in materia di classificazione e penalizzazione della sostanza e, ovviamente, la sua personalissima esperienza d’uso. “E(c)stasi” è un saggio incentrato sulla dicotomia tra vizio e virtù vissuta, non senza conflitto, da un solo individuo, e seppure Tolentino tracci una breve storia dell’esperienza estatica molto convincente (specialmente quando equipara i vocabolari che accomunano elevazione narcotica e spirituale), la rappresentazione dell’oggetto in esame – la fascinazione per la droga come esperienza che afferma il sé, la preoccupazione più per l’assuefazione che per la dipendenza – prevale sulla valutazione materiale della cosa stessa – il narcotraffico sommerso e le sue conseguenze a raggiera per innumerevoli persone. Tolentino usa sistematicamente la forma passiva quando descrive partite di pasticche goffrate con un preciso marchio, spedite a New York, comprate in dosi singole due milioni di volte a settimana: la droga è un soggetto unico che oblitera la volontà e l’azione delle parti in causa, il rischio di chi rifornisce e di chi compra.
Sparisce l’infrastruttura internazionale che estrae olio di safrolo dagli alberi della canfora cambogiani, sintetizza nei laboratori industriali olandesi e cinesi, esporta tonnellate di pasticche colorate in Europa e in Nord America, le distribuisce al dettaglio a prezzi accessibili per adolescenti festaioli, rischia anni di carcere federale e multe milionarie. Anche la facilità con cui Tolentino ammette la propria fedeltà alla cannabis nei materiali promozionali – tra foto dei suoi bong e raccomandazioni culinarie per la fase chimica – contribuisce a massimizzare il fattore simpatia tacendo il fatto che Tolentino viva in uno stato (New York) dove il consumo di marijuana è solo decriminalizzato (e consentito esclusivamente a scopo medico), in un paese in cui uso e possesso sono tuttora illegali a livello federale. Anche in questo caso, l’interesse di Tolentino per le catene umane che coltivano, trattano, confezionano, trasportano, distribuiscono, smerciano e consegnano a domicilio 24/7 è marginale, se non assente.
Tolentino sembra preferire rassicurazione, intrattenimento, appagamento di chi legge al rischio di indisporre, stupire, scontentare raccontando l’oscuro, l’inedito e lo scomodo.
Che Tolentino faccia sfoggio di una familiarità da budtender di dispensario nel valutare differenze e preferenze tra indica e sativa, tuttavia, suona stonato: come micro-consumatrice, Tolentino è al sicuro al termine della filiera ben servita dai service in nero, ma basta ricordarsi che nel 2017 – mentre Tolentino lavorava alle bozze di Trick Mirror – per ogni persona bianca arrestata per possesso di marijuana nella città di New York, gli agenti della NYPD arrestavano otto persone nere e cinque persone ispaniche. La centralità della ricerca e definizione del “bene” nei testi di Tolentino di certo non risponde all’arbitrarietà binaria di concetti oltremodo semplicistici come legalità e illegalità, ma l’estremismo di certe sue posizioni – non esistono soluzioni individuali ma solo misure politiche collettive, la vita virtuale conferisce troppe informazioni annientando la possibilità di agire, non c’è un modo di partecipare attivamente all’economia dell’attenzione senza svendere la propria identità – indica un fatalismo organizzato per posizioni nette, o tutto o niente, che sembra non voler nemmeno prendere in considerazione il tentativo ambiguo, il diniego imperfetto, la distanza critica, la defezione occasionale. L’idea di moralità come purezza intaccabile che i detrattori di Tolentino le scagliano addosso è lo stesso progetto etico che i suoi saggi posizionano come ideale (irraggiungibile), e che lei stessa ribadisce, a colpi di confessioni e auto-deprecazione, di non essere in grado di applicare.
È come se, non potendo essere e agire al sicuro di ogni riprovazione o conflitto di interessi, Tolentino rinunci a proseguire la riflessione, o a rivelarsi oltre il dettaglio biografico pruriginoso, per condividere una riflessione che la renda vulnerabile, ma che implichi anche la lettrice nello stesso processo revisionista del sé. Non c’è traccia di un progetto etico alternativo, o almeno un abbozzo, che valuti la zona grigia tra poli morali opposti, dove succede gran parte della vita ordinaria: cosa significa realizzare il meglio che si può con quello che si ha, fare la cosa giusta fatta anche per ragioni di meschino posizionamento, misurarsi con la rappresentazione che diventa prassi. Sconvolta dalla realizzazione di ciò che le persone, sé stessa inclusa, fanno per abitudine o perché costrette, Tolentino non si capacita di come quelle stesse persone, sé stessa esclusa, cerchino nel loro piccolo, anche se schiacciate dal “capitalismo”, qualcosa di meglio, o di fare la cosa che sembra più giusta, anche senza un beneficio apparente. In sostanza, scegliendo di scremare la visione ipotetica, la prospettiva immaginifica da testi che fotografano esclusivamente quello che è appena stato e quello che è, Tolentino rinuncia a ciò che Vivian Gornick chiama “the merest hint of complication”, il minimo accenno di complicazione. Rimuovendo l’urto del takeaway, addolcendo l’esperienza della lettura con tesi affermate con nitore e sorrette da panoramiche circolari e ego-riferite, Tolentino sembra preferire rassicurazione, intrattenimento, appagamento di chi legge al rischio di indisporre, stupire, scontentare raccontando l’oscuro, l’inedito e lo scomodo.
The Situation and the Story. The Art of Personal Narrative è un saggio-manuale elaborato nel 2001 dalla scrittrice di nonfiction Vivian Gornick sulla base di una serie di lezioni con studenti di scrittura. Gornick ha affinato, nel corso di decenni, uno stile di scrittura personale e di ricerca, a metà tra il memoir e la nonfiction, capace di fondere la propria presenza ai margini e a sostegno della storia che si prefigge di raccontare, invece che centrarla. Il risultato è una prosa sfaccettata che mira a comprendere l’esperienza stessa, ma non si perita di riposizionarla come emblema d’altro. Gornick sa che scrivere “io” non basta: “A volte in un saggio la mera presentazione di un sé frammentato diventa tesi in virtù dell’insistenza da parte dell’autore che la sola confessione sia una rivendicazione esistenziale della nostra attenzione”. Gornick parla di una “situazione” simile, ma fondamentalmente inferiore alla “storia” presente in ogni lavoro letterario: le circostanze, i fatti, la trama grezza che convergono nella situazione non sono niente senza “l’esperienza emotiva” della storia, “l’intuizione, la saggezza, la cosa che una ha da dire” intessute nella composizione letteraria.
Gornick scrive passaggi di teoria che si prestano – a seconda dell’inclinazione favorevole o meno di chi legge – sia a correggere che approvare le tecniche adottate da Tolentino. Sta alla sensibilità della lettrice, sola con la sua copia del libro, valutare quanto Tolentino sia riuscita con successo a “trasformare il più basso livello di interesse per sé stessa nel tipo di empatia distaccata che un brano richiede per poter essere di un qualche valore agli occhi della lettrice disinteressata”, ma il responso sarà indelebilmente viziato da quanto davvero “disinteressato” fosse lo sguardo in partenza. Sarà comunque difficile, o perlomeno insincero, negare il lavoro di autocontrollo, revisione e riflessione che sostengono la condivisione di materiale personale (insieme a una giusta dose di baldanza): ammettere i propri “sentimenti contrastanti”, nota Gornick, è “il punto preciso da cui la nostra elogista finalmente inizia a scervellarsi” e, intendendoli come esperienza, inizia a scrivere. “Penetrare ciò che è familiare non è affatto ovvio. Al contrario, è lavoro molto duro”, scrive Gornick come principio teorico, sembra quasi avesse in mente i saggi di Tolentino. Sono sicura che Trick Mirror possa funzionare per alcuni nel senso che Gornick auspica da parte di un testo: suscitare la fiducia che la voce narrante possa accompagnare verso “una radura in cui il senso delle cose è più ampio di com’era prima”. La mia parte di responsabilità, come lettrice, è non essere riuscita ad abbandonami alla veracità delle confessioni, accettare che fossero sufficienti per illuminare il tragitto. Ma il familiare che Tolentino descrive non mi è di conforto, non lo riconosco, e le macchinazioni mostruose che indica, invece, già le vedo, dure e scintillanti.