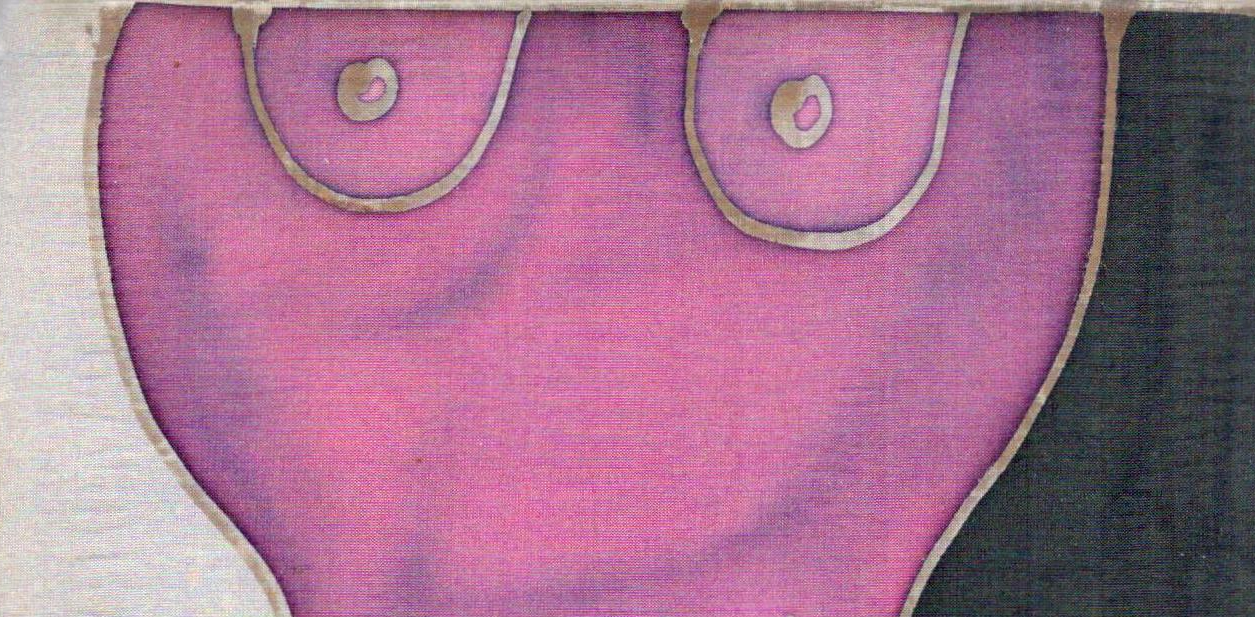
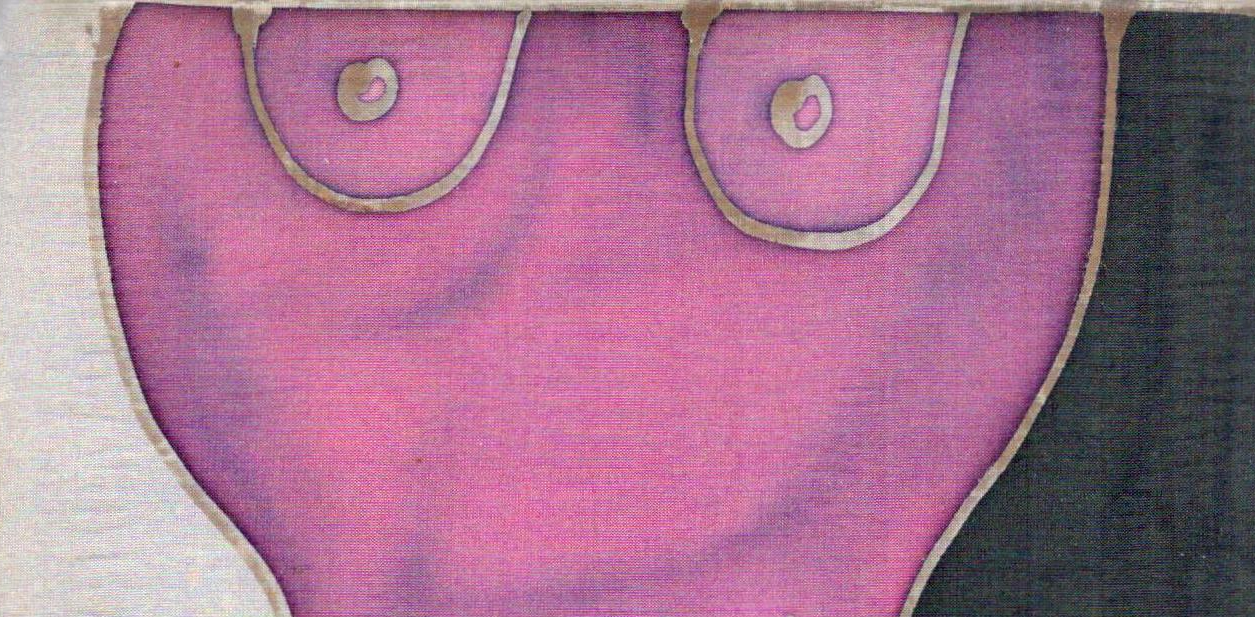
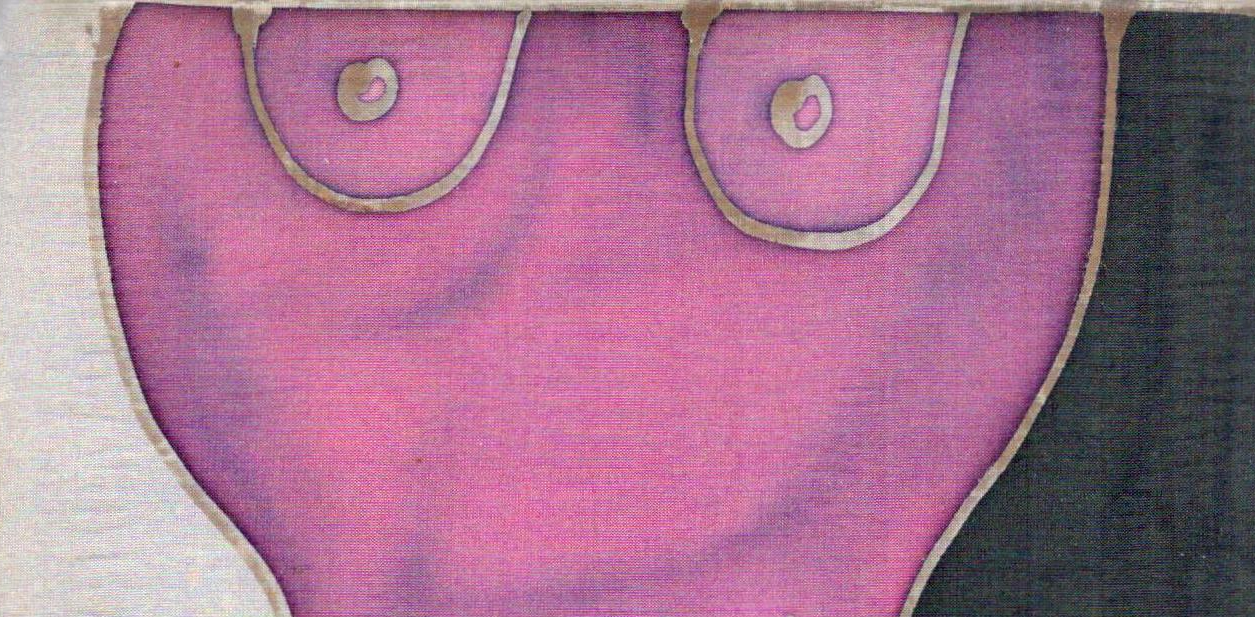
“I n amore parlare è creare specchi, entrare in quel gioco di goccioline sfaccettate che restituiscono immagini in un tornado di ceneri e falene”. Quando mi sono imbattuto in questa frase di Julio Cortázar, all’interno di Papeles Inesperados, e ho scoperto che apparteneva alla piccola prefazione a una raccolta di racconti di Mauricio Wacquez (“per cose del genere la chiave di lettura sembra averla Mauricio Wacquez”, ammiccava Cortazar), ho avvertito da subito l’impulso irrefrenabile di sapere tutto su questo Wacquez. Mi era già capitato di legarmi un’ossessione del genere al guinzaglio: durante la lettura di Rayuela avevo capito che alla Maga bisognava spiegare “perché Caterva di Filloy, e tutto il resto”, e mi si era scatenata una dipendenza affettiva che dopo un viaggio sufficientemente approfondito mi avrebbe portato a riporre un fiore sulla tomba di Juan Filloy a Córdoba.
C’è una foto, scattata da Nathalie Waag in Provenza, probabilmente a Saignon, il buen retiro di Cortázar (lì avrebbe scritto Correzione di bozze in Alta Provenza): è agosto, è il 1968, e Julio e Mauricio conversano amabilmente di fronte a uno Chateau-de-Mille. Tre anni più tardi sarebbe uscito Excesos, la raccolta di racconti di Wacquez prefatta da Cortázar, e se non ne avete mai sentito parlare è perché di Wacquez, in Italia, non è ancora – colpevolmente? – stato tradotto nulla. Quando sono riuscito a entrare in possesso di una prima edizione di Excesos, e ho iniziato la lettura, ho fatto un altro incontro: la mia copia era piena di note, note del lettore che mi aveva preceduto, e che a quanto pare non lo aveva particolarmente amato. Alcuni degli appunti: “incongruente”, “voglia di rendere tutto troppo oscuro”, “affettato”, “pedante”, “kitsch”.
Ciononostante, le annotazioni si susseguivano fino all’ultima pagina, il che mette in evidenza la prima, potentissima caratteristica della scrittura di Wacquez, e cioè quella di essere destinata a quelli che proprio Cortázar definiva – magari in maniera poco inclusiva – “lector macho”, ovvero il lettore che completa, partendo dallo scritto, il suo significato. Wacquez ti lancia un guanto di sfida, ogni paragrafo è un invito al campo di fichi d’india all’alba. Che poi la prosa di Wacquez a me è sembrata tutt’altro che oscura, anzi. Perché indipendentemente dal significato profondo delle frasi – che sì, si prestano a una stratificazione interpretativa stimolante – è proprio la costruzione, l’azione artigianale di assemblare le parole, a essere magistrale. La musicalità, le vibrazioni che provoca nel nostro immaginario.
Com’è possibile, allora, che sia così misconosciuto? Cosa ha ostacolato il suo percorso? L’ausilio autoimposto non solo dalla propria terra, il Cile, ma anche dalle correnti letterarie che imperavano in quel momento? Una semplice questione di pregiudizio nei confronti della sua biografia? Il fatto di essere così diverso dai suoi contemporanei?
Antiautoritario a oltranza, “anticlericale furibondo”, Wacquez non è mai stato militante in niente.
Osservo una foto di Wacquez: è di profilo, una mano tra i bottoni della camicia. Somiglia vagamente a Giorgio Gaber, ma con tratti da indio, gli zigomi pronunciati, la bocca una semplice fessura. Chi lo ha conosciuto lo ha definito un dandy: girava con cappello e bastone da passeggio, gesticolava durante i suoi discorsi, disinvolto e disinibito. Sapeva essere insolente, iracondo, mordace; e poi erudito, raffinato, elegante.
Era nato nelle campagne cilene, a Colchagua. Proveniva da una famiglia di coloni di Bordeaux, il nonno in Algeria e il padre in Cile, si occupavano di viticoltura. Quando, a cavallo tra i due secoli, la fillossera ha decimato il patrimonio vitivinicolo europeo, il Cile è rimasto, a un certo punto, l’unico paese al mondo a produrre vino. Ed è là che aveva deciso di trasferirsi Wacquez padre: aveva sposato una donna molto più giovane, e avevano avuto questo figlio malaticcio, che aveva trascorso buona parte dell’infanzia a letto tra tifo, problemi digestivi e un soffio al cuore. In quella solitudine, anche affettiva (parlando del padre: “la sua codardia, la sua serietà – che era soprattutto mancanza di immaginazione –, la sua violenza, i sessant’anni che ci separavano avevano fatto sì che qualsiasi forma d’amore tra noi fosse impossibile”), Mauricio si era fatto lettore insaziabile: aveva sviluppato un’erudizione di tipo classico, alla quale però aveva affiancato una predisposizione allo stravolgimento delle regole, un’anarchia latente.
“Eravamo puro rancore e speranza”, dice Wacquez riferendosi a Los Novísimos, la gang – più che la corrente – nata dalle macerie della generazione che li aveva preceduti, quella degli anni Cinquanta, dei José Donoso, per intenderci. Il caudillo dei Novísimos era Juan Agustín Palazuelos, un dromomaniaco coi vizietti dell’acido lisergico, della marijuana, dell’eccentrico, della provocazione, tutte meravigliosi occupazioni che esercitava con un’ingegnosa passione da adolescente fluorescente. La sua prosa, e quella di Skármeta, di Carlos el mono Olivarez, era fatta di frasi corte, pungenti, paratassi precise e puntuali. Tutto il contrario di Mauricio Wacquez, piuttosto orientato a un’ipotassi rigogliosa, per quanto mai ingarbugliata, coi ritmi del contrappunto musicale. A fare da trait d’union tra i Novísimos, un po’ come succedeva ai real-visceralisti dei Detective Selvaggi di Bolaño, era l’interesse smodato per il sesso, per quella “rabbia che si rivoltava verso l’interno”. Il sesso al di là dell’edonismo, come chiave interpretativa, come metafora dei rapporti di potere.
Antiautoritario a oltranza, “anticlericale furibondo”, Wacquez non è mai stato militante in niente, se non forse nella soddisfazione dell’ego dionisiaco preconizzato da Norman O. Brown, apostolo del principio del piacere e delle perversioni polimorfe come cura alla nevrosi provocata dalla repressione degli istinti. Non a caso, in esergo a Excesos, Wacquez ha posto la celebre massima di William Blake, “la strada dell’eccesso porta al palazzo della saggezza”.
Il rifugio politico ed estetico di Wacquez è stata la letteratura: lì è riuscito a sperimentare ciò che spesso la società a lui contingente proibiva.
Dromomaniaco a sua volta, in perenne fuga, definiva la letteratura “un mestiere per fuggitivi”. Ed è in esilio, in effetti, che l’ha colto il Golpe del ‘73. Lo sradicamento, non solo in termini letterali ma anche e soprattutto concettuali, fa di Wacquez, come in fin dei conti di Bolaño, uno scrittore non tanto in esilio, quanto dell’esilio. Quello di Mauricio nasceva da un’incompatibilità con l’establishment, con l’identità nazionale, con le convenzioni: un atto politico senza essere davvero un atto politico. Nella vita quotidiana come nella letteratura: “La nostra lingua ha una sintassi rigorosa. Prima appare il soggetto, poi la sua azione e infine le circostanze determinanti. Sfidare quest’ordine può essere un’arte, un artificio o una sfortunata trasgressione figlia dell’incapacità di farsi comprendere”.
Il rifugio politico ed estetico di Wacquez è stata la letteratura: lì è riuscito a sperimentare ciò che spesso la società a lui contingente, i paletti della moralità, proibiva. Nell’articolo sulla rivista Ercilla, scritto ma non firmato da Donoso, in cui si presentavano i Novísimos, Wacquez era immortalato con una copia del suo primo libro tra le mani, Cinco y una ficciones, a cui avrebbe fatto seguito, ultima opera pubblicata mentre era ancora in Cile, Toda la luz del mediodía. Excesos sarebbe uscito durante la sua parentesi francese, dopo la quale Wacquez aveva trovato nello sperduto paesino collinare di Calaceite, in Aragona, il suo porto d’approdo. Là avrebbe scritto due dei suoi libri più significativi, Frente a un hombre armado e Ella, o el sueño de nadie, e poi tradotto molto dal francese: Apollinaire, Stendhal, Cocteau e Flaubert.
“Ogni romanzo è una copia di un altro romanzo. Perché fanno tutti parte dello stesso romanzo, quello che uno scrive nel corso della sua vita“, diceva parlando delle sue opere, tasselli di un mosaico compiuto nelle cui ombre, nei cui chiaroscuro, si annidava la sua visione del mondo.
Lo dico una volta così non me lo chiedete più: tutti i libri che scrivo, o quasi tutti, al 95% sono autobiografici. Potranno non essere riferimenti facilmente riconoscibili, ma io sì, li riconosco. […] Un testo non è bello perché appartiene a una determinata vita, ma perché l’arte gira intorno a una certa alchimia che è prodotta dalla realtà e che la realtà rinnega allo stesso tempo, perché è ormai già convertita in letteratura.
E ancora: “Il romanzo è due volte autobiografico. La prima, nelle allusioni alla vita del suo autore; e poi, perché attraverso il romanzo la vita stessa si trasforma in esperienza letteraria vivida, irreversibile come ogni conoscenza“.
La curiosità morbosa con cui critica e lettori si chiedevano incessantemente quanto di biografico ci fosse nelle sue opere nasceva soprattutto dalla presenza costante, massiva, reiterata di riferimenti all’omosessualità. Nelle opere di Wacquez succede sempre tutto di sera, sul confine della notte, oppure all’alba; cioè quando le ombre si impossessano dei contorni delle persone, delle cose. La sua scrittura è evocazione: tell, don’t show. “La parola ha sempre avuto un peso maggiore rispetto alla realtà. Per me è più interessante la vita raccontata che quella vissuta”. Nella vita raccontata ci sono meno inibizioni, meno costrizioni sociali: l’anarchia edonista, la dedizione alle perversioni si fa strumento d’indagine sociale, senza tabù: “il problema della moralità è una scelta primigenia”.
Nella sua scrittura di silenzi, di sfilacciamenti, di rigore stilistico ed estetico, la libido, l’emozione sessuale sono il propellente della vita stessa. Attraverso il sesso possiamo “scavalcare il recinto degli stupidi, dei demagoghi, di chi ha le armi e ci minaccia. Non c’è niente al mondo che potrà tenermi lontano dal perseguimento del piacere, che mi dà la chiave per tutto il resto: per credere in una madonnina avvolta in uno straccio, per amare chi voglio”. Il sesso, il piacere, la perversione in Wacquez sono torce che illuminano il buio dell’esistenza. Anzi: vanno subito spente, perché ogni conoscenza è scoperta. “Non credo sia possibile entrare nella vita di qualcun altro, neppure con l’amore, anzi soprattutto con l’amore. L’amore è possibile perché non ti conosco: se ti conoscessi saresti già un paio di scarpe vecchie”.
Lontano dai moti che ribollivano in Sudamerica, e in Europa, Wacquez era “un pessimista che voleva che tutto andasse per il verso giusto”.
Wacquez si è tenuto lontano da tutto quello che, nella sua epoca, ha decretato il successo di un certo tipo di letteratura latinoamericana: l’irrazionale, il mito. Cosciente, però, che la letteratura, “cioè quello che mi propongo di fare, è fatta esattamente di mistero, mito e magia”. L’ha cercata altrove, tra le ombre, tra i moti della libido, nella difficoltà di trovare razionalità in ogni relazione, in ogni rapporto di potere.
Frente a un hombre armado è un romanzo irriverente e provocatorio: una specie di immaginario da Marchese de Sade che incontra la muscolarità di Jack Kerouac e l’eleganza di Scott Fitzgerald. “Una risposta romanzata al golpe del ‘73”, nelle parole dell’autore, ma forse anche e più profondamente a tutta la letteratura sudamericana che l’ha preceduto, al realismo magico di Gabo, al fantastico di Borges e Bioy Casares. Il protagonista sbalza da un piano temporale all’altro, dal crepuscolo del regno di Francia di Luigi Filippo agli anni Quaranta campestri di Colchagua alla Bordeaux del post-guerra; e l’autore dalla non fiction al romanzo libertino alla parabola morale. Al centro c’è l’esplorazione della violenza, della sessualità, delle pulsioni scatenate dal potere. Possedere ed essere posseduto, dominare ed essere dominati.
Così come ogni cellula tende a mangiarsi un’altra cellula, allo stesso modo ho l’impressione che ogni forma di potere sia sopraffazione. Mi interessa cosa giri in testa ai potenti, agli ambiziosi, perché per mantenersi viva l’ambizione ha bisogno di inserirsi in una struttura di potere, e questo è un fatto biologico che finisce per passare per la violenza, per l’uccisione del vicino.
Nello squilibrio di rapporto generato dal potere, l’umanità vacilla: “Se mi puntassero una pistola alla tempia io direi tutto quello che vorrebbero sentirsi dire, e in condizioni del genere tradirei con molta facilità. Qua l’eroismo non c’entra niente”.
In Frente a un hombre armado, i personaggi apprendono durante le battute di caccia i segreti della seduzione che porta a letto, e nel letto i segreti della guerra. Ma l’uomo armato cui allude il titolo è anche la personificazione dei capisaldi patriarcali che dominano la società cilena contemporanea a Wacquez, e chissà ancora oggi la nostra, fondati sul machismo e sulla superiorità di classe. Quella attorno alla quale ruota tutto il romanzo è la relazione tra padrone e servo, a prescindere dal desiderio erotico omosessuale che ne consegue, o che lo rafforza. Il padrone che sceglie di farsi sodomizzare dal servo rinuncia al potere nella sua forma più superlativa. Ma dimostra anche che, nell’annientamento, o nell’amore, è sempre necessaria una condivisione, l’accettazione dei propri ruoli: l’asservimento al fine ultimo della caccia, che è poi lo stesso della guerra, e chissà dei rapporti amorosi: la cattura – che è un prodromo di morte – della preda. “Dipendere da qualcuno, essere posseduto, essere il centro della passione, è questo tutto ciò a cui anela (il personaggio, Ndr)”, scrive Wacquez. “In questo senso, l’amore si avvicina molto all’ossessione. Assume una forma particolarmente intensa: l’odio per la libertà del prossimo”.
Frente a un hombre armado viene definito un bildungsroman queer – queer come fantastico significante liquido, come aggettivo che fa vacillare la stabilità dei nomi che qualifica. Un romanzo di formazione che passa attraverso il totale abbandono di pregiudizi, tabù, idiosincrasie e che in questo abbandono finisce per rivelare la solidità delle fondamenta stesse di quei pregiudizi, di quei tabù. La letteratura, diceva Wacquez, “è il miglior strumento per interpretare la Storia e per non farla, la miglior maniera di essere un codardo”. Lontano dai moti che ribollivano in Sudamerica, e in Europa, nei suoi anni, quasi nichilista nel profondo, Wacquez – “un pessimista che voleva che tutto andasse per il verso giusto” nel ricordo di Jorge Edwards – andava a suo modo controcorrente, come un torrente che anziché discendere si arrampica sul Glaciar Universidad, controcorrente rispetto ai controcorrente stessi, impegnato in un gioco di ricerca di se stesso, dell’identità umana, nei frammenti degli specchi.
Il Wacquez-uomo guarda al Wacquez-autore come fa il personaggio di quel famoso racconto di Cortázar in cui l’uomo che osserva l’axolotl finisce per essere l’axolotl stesso: e a leggere Irene*, così vicino alla musicalità del capitolo 7 di Rayuela, così perfetta personificazione del sempre cortazariano Amore 77 (“E dopo aver fatto tutto quello che fanno, si alzano, si lavano, si mettono il talco, si profumano, si pettinano, si vestono, e così progressivamente tornano a essere ciò che non sono“) viene proprio da chiedersi se – magari proprio in virtù di tutta questa cortazarianitudine – casomai non ci stiamo perdendo qualcosa di prezioso, nel lasciarlo così in disparte, Mauricio Wacquez.
Prima, ieri, io la amavo, Irene. Fino a ieri che se n’è andata, l’amavo follemente, io. Ora, ora che cerco di far sì che la linea della palpebra non sfugga via, di disegnarla come sempre gliel’ho vista disegnare, un occhio già terminato, l’altro che tuttavia credo verrà un po’ diverso, più scuro, con un’ombra meno violetta, tendente al malva (che cos’è, l’inesperienza!), la scriminatura meno docile e ondulata e soprattutto d’un altro colore – stiro l’occhio con l’indice della mano sinistra mentre l’altra mano trema al ripassare il bordo sul quale sono piantate le ciglia – senza sapere perché, dal momento che ho utilizzato la stessa matita per l’uno come per l’altro occhio; ora che sembra che questo ritocchino finirà per essere un vero disastro, impalato come sto sul pavimento umido del bagno con le sue pantofole di raso che mi opprimono selvagge i piedi, cercando di stare in equilibrio tra scivoloni che mi tocca inclinarmi verso lo specchio dove la luce è più forte perché quest’occhio venga possibilmente uguale all’altro, cosa della quale dubito; ora che sento che il calore della lampadina scioglie il fondotinta che mi sgocciola sulla fronte e sulle guance come una sudorazione eccessiva, che minaccia anche di far crollare a terra, e inondare, il paziente lavoro che ho fatto sugli occhi; ora che realizzo che dovevo mettermi prima il pancake o il talco in modo che la pelle, ora, sarebbe già secca e non avrebbe schizzato questa specie di sperma: lo sento correre silenzioso sul collo, ed è per questo che me ne sto tranquillo, per non rovinarmi i vestiti: le macchie di grasso impregnano per sempre la mussola bianca; ora che realizzo, con un’occhiata, che le unghie sono venute ruvide e dal taglio irregolare e – ciò che c’è di più terribile – che non hanno lo stesso tono di colore che usava lei; ora che non so quando finirò di dare all’occhio quell’aspetto trasognante che riusciva a raggiungere lei ogni volta che nel corridoio mi diceva sono pronta; ora che, questo sì, ricordo che proprio all’angolo della palpebra la linea saliva verso l’orbita, sfumando, con una terminazione appuntita, come una piccola coda; ora che devo pure sbrigarmi perché deve mancare poco a quando lui arriverà, devo andare a sedermi in salotto, accendere la televisione, ripetere i movimenti che hanno accompagnato le nostre ultime serate, lente e silenziose; ora che mi manca solo di mettermi le scarpe e tutto il resto e quest’occhio, che palle, non sarà mai uguale all’altro, e sembra che sia meglio lasciarlo così; ora, sì, ecco, ora sì che sono Irene.
*Irene [da Excesos, Editorial Universitaria, 1971, Santiago del Cile, traduzione FG]