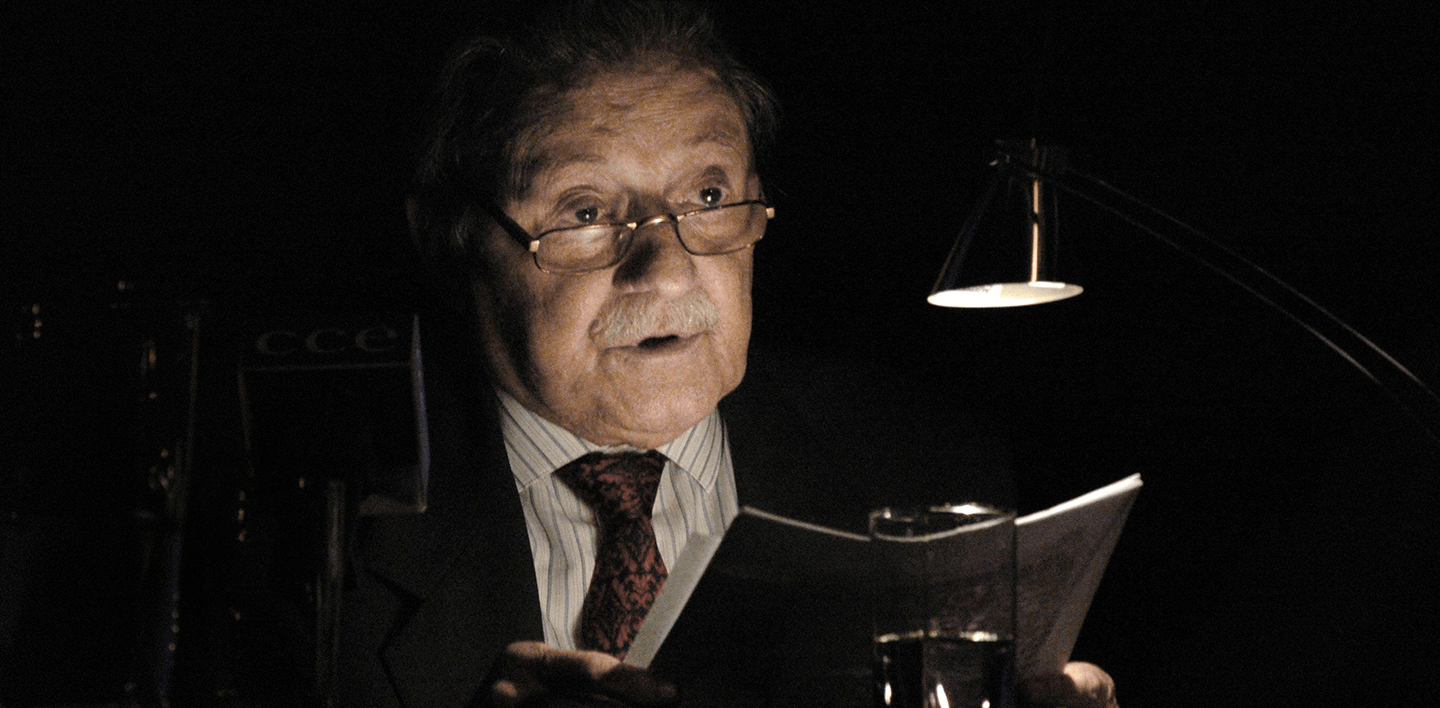
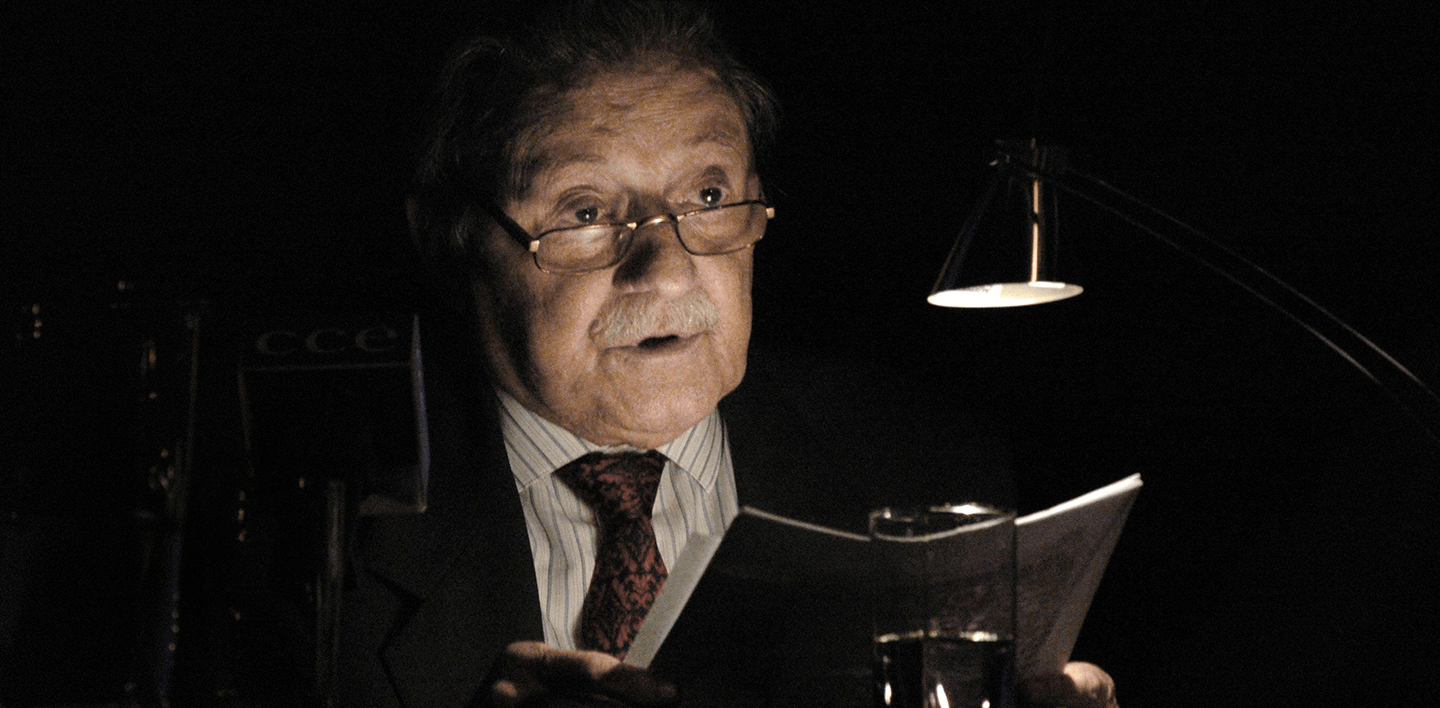
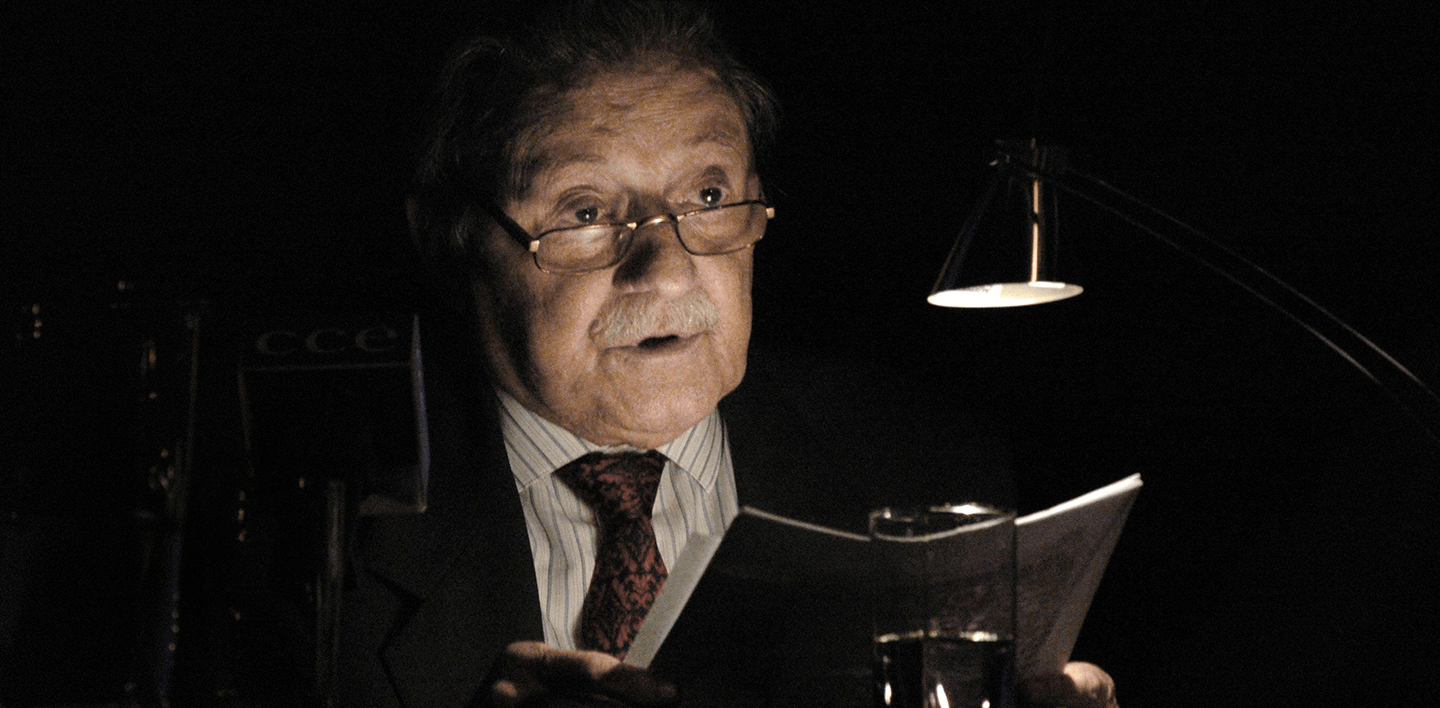
A dieci anni dall’uscita in Uruguay, è stato appena pubblicato in Italia da Nottetempo Il diritto all’allegria, una raccolta di riflessioni, brevissimi racconti, aforismi, considerato fin dal titolo il testamento di Mario Benedetti. Si tratta di un insieme di frammenti disordinati, legati dal filo conduttore della libertà di pensiero, che consente di spaziare da considerazioni intense e generali sulla perdita e sul senso di assenza alla scoperta che anche i sentimenti più impensabili hanno un orizzonte invalicabile, alla malinconia sotto forma di fotografia, all’indimenticabile passato rimasto fermo da qualche parte e alla difficoltà di lasciarlo andare.
C’è un micro racconto sulla necessità e il pentimento di estraniarsi dal mondo e un altro sul desiderio di vendetta scolpito su una lapide. C’è una consapevolezza speculare a quella di No man is an island di John Donne, che porta a riflettere sulla ineluttabilità della solitudine, a prenderne atto senza compassione.
Ogni essere umano è un’isola. Nel migliore dei casi, fa parte di un arcipelago. Ma anche così, ogni isola è diversa dalle altre. Alcune sono fertili, prodighe, feconde. Altre sono aride, magre, rinsecchite. Ogni essere umano è un’isola in cui convive soltanto con la sua coscienza e talvolta con un lago calmo, che gli mostra quali tratti assume il suo volto di naufrago.
C’è anche molta ironia, qualche gioco di parole di cui sembra divertirsi anche lo stesso Benedetti, un’affettuosa presa in giro della scrittura stessa (“La virtù più evidente della poesia è di non essere prosa”). Si avverte, solo ogni tanto, un timore pessimista per quello che resterà dopo. Benedetti lascia intravedere una sorta di angoscia estranea ai suoi libri, una paura che ci ha fatto credere non appartenergli ma che pure, evidentemente, deve far parte degli anni e dell’accettazione di un mondo limitato davanti a sé: “dopo la fine, che cosa verrà? (…) Sarà uno scantinato, una nuvola scura, un giardino di fiori appassiti? Una noiosa pianura, senza orizzonti in vista, senza punti cardinali in cenere? Un’infanzia senza giochi, una vecchiaia senza capelli bianchi?”.
In contrapposizione ai toni negativi, che di poco spazio hanno diritto nella poetica di Benedetti, nell’antologia si avverte preponderante un senso di riconoscenza per ciò che di bello sopravvive alla globalizzazione, ai torturatori, alle fini inevitabili. Alcuni brani sono infatti dei semplici omaggi a ciò che si riduce all’essenziale, sia il testo che la forma sono il risultato di un lavoro di cesellamento che percorre un doppio binario verso l’individuazione di ciò che rimane e che è fondamentale: l’infinita modestia degli alberi, il vortice dei paesaggi fuori dai finestrini di un treno, la sensazione di camminare scalzi per il mondo, la possibilità che sotto ogni pietra si nasconda una poesia, il rammarico per l’assenza di un museo delle allegorie, unica cosa mancante in un presente sovrabbondante. E soprattutto, all’improvviso nel libro, troviamo poche righe dedicate all’allegria, invocata e pretesa come diritto irriducibile di chiunque, come speranza celata pronta a sommergerci inaspettatamente, da saper riconoscere come breve rinascita, da afferrare per il breve tempo in cui ci illudiamo che ci appartenga.
Abbiamo diritto all’allegria. A volte è fumo, nebbia o un cielo velato, ma dietro questi contrattempi c’è lei, in attesa. Nell’anima c’è sempre una fessura a cui l’allegria si affaccia con le pupille vispe. E allora il cuore si fa più vivace, abbandona la quiete ed è quasi uccello. (…) L’allegria sopraggiunge dopo le assenze, alla fine delle nostalgie. Quando ritroviamo ciò che amiamo e la sua unanime rivelazione, è normale che la gioia ci abbracci e ci venga voglia di cantare, anche se non abbiamo voce, anche se siamo rauchi dei dolori passati.
La mia scoperta di Benrdetti risale ad alcuni anni fa. Lo avevo sentito citare o semplicemente nominare in tante storie di autori sudamericani che quando ne riconobbi il nome sulla copertina di un libro lo presi senza pensarci. Era La tregua, il diario di un uomo comune negli interminabili e noiosi mesi che lo separano dalla pensione, momento atteso di cui non avrebbe saputo cosa fare. Martín Santomé vive trascinando la quotidianità tra l’impiego in una ditta di pezzi di ricambio d’auto, le battute inutili dei colleghi, le serate solitarie o in compagnia dei figli. E sopravvive ai lunghissimi fine settimana diviso tra una passeggiata, un caffè, i propri pensieri, nient’altro.
Finché nella sua vita entra Avellaneda – il suo nome non ha senso perché lui non lo proferisce mai, è il suono del suo cognome l’unico a risuonare e ad assumere un significato diverso ad ogni pronuncia – nuova impiegata dell’ufficio con la metà degli anni del signor Santomè. Nasce un rapporto delicato che offre speranza inattesa e qualche squarcio illusorio di felicità silenziosa e reciproca, il tempo riprende a scorrere troppo velocemente, ogni giorno torna ad assumere un senso, la monotonia lascia il posto all’attesa, al desiderio o forse a una fiducia eccessiva. Si arriva a intravedere il compromesso raggiungibile tra amore e libertà, a scoprirne contemporaneamente il risvolto assurdo.
Avevamo deciso di prendere le cose con calma, di lasciar fare al tempo (…). Ma il tempo vola, lo si lasci fare o meno, il tempo corre e rende lei ogni giorno che passa più desiderabile, più matura, più fresca, più donna, mentre ogni giorno minaccia me di rendermi più acciaccato, peno forte, meno vitale. Dobbiamo fare in fretta se vogliamo incontrarci, perché nel nostro caso il futuro è un inevitabile distacco.
Per l’intero libro si ha l’impressione di inoltrarsi nella confessione intima di quello che accade in un uomo stanco, in bilico tra la rassegnata consapevolezza di aver già vissuto e il dubbio di poter osare fantasticando che quella vita non sia già terminata, che vi sia spazio per l’inatteso, per un miraggio che non si ha il coraggio di chiamare felicità. Nel personaggio di Santomè si alternano, addossandosi l’uno all’altro, spingendosi e contraddicendosi, tutti i sentimenti di un uomo in tempesta dentro un piccolo spazio che è il tempo presente, incredulo e disilluso, diffidente del domani.
Questa giornata con Avellandea non è l’eternità, è solo una giornata, una delle povere, indegne, limitate giornate alle quali tutti, da Dio in giù, siamo condannati. Non è l’eternità, ma è l’istante che, in fin dei conti, ne costituisce l’unico vero succedaneo. Non mi resta, dunque, che serrare i pugni, gustare questa pienezza senza alcuna riserva, senza prospettiva alcuna. L’ozio definitivo verrà più tardi, forse, l’ozio sicuro, forse allora ci saranno molte giornate così, e se ci penso questa fretta, quest’impazienza, mi appaiono una fatica ridicola. Forse, solo forse. Ma in questo Frattanto c’è il sollievo, la sicurezza di quel che è, di quello che sta succedendo.
Solo lo scorso anno Nottetempo ha pubblicato anche il primo libro di Mario Benedetti, scritto nel 1953, Chi di noi. Si tratta di un romanzo breve in cui tre voci rappresentano i punti di vista di un triangolo amoroso che tende a non realizzarsi mai. Miguel si rivela in un quaderno, scrive all’uomo mediocre che ha sempre ritenuto di essere, compiacendosene con indulgenza.
E così, persa ogni speranza di credermi intelligente o appassionato, mi resta quella meno presuntuosa di sapermi sincero. E per sapermi sincero ho iniziato questo diario, in cui punisco la mia mediocrità con una testimonianza personale e oggettiva. È vero che il mondo pullula di persone banali, ma non di persone banali che si riconoscano tali. Io si, mi ci riconosco. D’altronde, mi rendo conto che quest’orgoglio assurdo non mi porta a niente, se non a un’imbarazzante insofferenza verso me stesso”.
Cerca di ricordare la propria vita con Alicia e di individuarne i momenti fondamentali, si interroga sulla natura dei sentimenti provati nel corso degli anni, non distingue in cosa sia consistito quel rapporto in cui c’era anche Lucas – invidia, gelosia, irrinunciabili e mute serate nei bar, assenza e desiderio. Alicia si sfoga in una lettera destinata al marito. Va indietro con la memoria, vi incontra l’uomo che ha scelto e quello che era simile a lei, rivede la propria immagine estranea e irriconoscibile, sente ancora un bisogno di disprezzare e l’impossibilità di dimenticare.
Lucas invece, l’altro, si nasconde dentro un racconto forse inventato o forse no, in cui ritrova Alicia in incontri diversi da quelli immaginati, che inventa e romanza, isolando la verità solo nelle note a piè di pagina. Ognuno di essi cerca di svelare se stesso in modo leale senza riuscirci davvero, dietro ogni affermazione si nasconde un dubbio e un interrogativo che rende complesso avvicinarsi alla verità, ogni voce contraddice la precedente e mette in dubbio la successiva in una potenziale spirale senza possibilità di fuga chiarificatrice.
Ogni libro di Benedetti sembra arrivare in Italia solo a decenni di distanza. A differenza dei tanti autori sudamericani, i cosiddetti boomistas – di cui Ilan Stavans spiega le ragioni dell’ascesa sulla Los Angeles Review of Books (tradotto sul blog di edizioni Sur da Francesca Clemente) – il cui “movimento ebbe un impatto vasto e profondo. Creò una storia e un’identità continentale condivisa, o almeno l’illusione di essa” e le cui opere sono esplose negli anni sessanta e settanta diffondendosi in Europa e nel resto del mondo senza più smettere di essere lette, quelle di Benedetti ci sono arrivate in modo più disorganico, a grandi intervalli di tempo l’una dall’altra, senza, sembra, un vero e proprio progetto letterario ad accompagnarle. Pur facendo parte della stessa generazione e provenendo da analogo orientamento politico e sebbene trattino temi legati alle dittature militari, all’esilio, alle condizioni del popolo che rimane, le storie dello stesso lato del mondo vengono rivelate con modalità e voce diverse negli uni e nell’altro.
In Benedetti manca il concetto di real maravilloso che ha caratterizzato le opere di Amado, Garcia Marquez, Vargas Llosa, Fuentes, Cortázar. La sua è una scrittura realistica senza nulla di surreale, talmente realistica che appare introspettiva e rischia di far intravedere in ogni personaggio un possibile alter ego dell’autore. Rispecchia le vite con cui ha convissuto a Montevideo e quelle che ha incontrato negli anni dell’esilio a Cuba, in Spagna, di ritorno in Uruguay, ci sono gli stessi contrasti e gli stessi dolori narrati in modo magico dai colleghi sudamericani della stessa epoca ma rivelate con un tono che le fa avvertire più vicine, più quotidiane, troppo possibili. Nella presentazione a Racconti (ed. Multimedia) Rosa Maria Grillo spiega il motivo per cui il suo percorso in Italia si è differenziato nel tempo e nello spazio da quello degli esponenti del realismo magico che hanno raccontato lo stesso, e allo stesso tempo un altro, Sudamerica:
La scrittura realista di Benedetti, invece, in quanto specchio critico di una realtà in cui convivono apparenze e aspirazioni europeiste e contraddizioni e sofferenze sudamericane, senza quella ‘aura magica’ presente in tanta narrativa e cultura afro-indigena del resto del continente, non poteva attirare noi occidentali stanchi di città, di routine, di apatie, di uomini e donne senza qualità e senza mistero. Rispetto agli ‘esotici’ (…) Benedetti ci rimanda in un mondo apparentemente troppo simile al nostro, e non è facile andare oltre le apparenze del suo narrato per scorgervi le cifre specifiche di una latinoamericanità soffusa, di una sottile ironia, di un narrare che mostra le voragini distruttive che sia prono tra la necessità di apparire e la volontà di essere, tra la banalità del quotidiano e la tragedia del singolo, tra l’umanità del torturatore e il tradimento dell’amico.
Un esempio è offerto dalla raccolta Montevideanos (inedita da noi, salvo alcuni brani contenuti in Racconti), titolo che ricalca Gente di Dublino e che offre una panoramica sulle abitudini e sulle debolezze degli abitanti della capitale uruguayana. La città in cui Benedetti è cresciuto è la costante di altri due romanzi, entrambi pubblicati da La Nuova Frontiera.
Grazie per il fuoco è ambientato in un paese in cui, per un certo periodo, era proibito ai mass media persino dare notizia dei sucidi. Qui Benedetti racconta il confronto fra tre generazioni che diventa metafora di un Uruguay corrotto e sempre uguale a se stesso. Lo fa descrivendo il cinismo di un padre potente e influente, da tutti rispettato e temuto; le speranze di cambiamento che un nipote confida di trovare in una sinistra che sopravvive; soprattutto le angosce e il tormento di un figlio oppresso dall’impossibilità di scegliere, il suo convincimento di dover eliminare quel padre, per poter vivere, e la sofferta incapacità di farlo.
La verità è che so che non cambierò, perché non prenderò nessuna decisione risolutiva, drammatica. Finché si tratta solo di pensieri, di un semplice gioco mentale, allora mi sento pieno di coraggio, ho l’impressione che sto per decidermi, che sto per fare il salto, ma quando viene il momento di creare i fatti e accettarne le conseguenze, allora mi prende una paura irrazionale, un panico simile a quello che mi prendeva da piccolo, con le mosche che io trasformavo in mostri, o con la vacca cattiva, o a vent’anni, con il treno col suo occhio di ciclope, o a venticinque, quando l’autobus mi fece volare. Non so esattamente se sia paura della miseria, dell’insicurezza o del disprezzo degli altri. Forse è qualcosa di meno onorevole di tutto questo.
Claudio invece è il protagonista di Fondi di caffè, in cui Benedetti, tralasciando ancora una volta la struttura del romanzo classico, ci fa conoscere i quartieri di Montevideo, i suoi parchi, i viali e le discariche, attraverso gli occhi di un ragazzino degli anni quaranta la cui adolescenza resta soltanto sfiorata dallo scoppio della seconda guerra mondiale. Claudio vive e racconta la quotidianità e le grandi avventure dei quindicenni, il primo impatto con la violenza affrontato come in un mistero di Sherlock Holmes; riesce ad individuare con chiarezza il momento che mette fine alla propria infanzia e a spiegare, da allora, il percorso verso una lontana maturità, fatto di libri decisivi e di scoperte sessuali, di incontri con persone che hanno inconsapevolmente qualcosa da insegnare o da lasciare, come il cieco Mateo, che cerca di spiegare la differenza tra memoria e immaginazione, e la governante Juliska, immigrata montenegrina che non imparerà mai la lingua né a vivere senza nostalgia in un paese dal cielo troppo stellato per sembrare vero.
Si tratta di un romanzo di formazione costruito con frammenti di ricordi in ordine per lo più cronologico e con alcuni salti temporali. Paradossalmente, elemento ricorrente rimane la figura del quadrante dell’orologio che Claudio, aspirante pittore, disegna fissandone le lancette alle tre e dieci, orario chiave nella sua breve traiettoria di esperienze, il momento in cui è accaduta ogni cosa fondamentale e in cui forse rivedrà la ragazza conosciuta, da bambino, tra i rami di un albero di fico, che da allora ha continuato a riapparire improvvisamente nella sua vita, per tornare sempre a svanire come un fantasma.
Infine, Pedro e il capitano (BFS edizioni), una breve pièce in quattro atti ambientata interamente in una stanza degli interrogatori. Gli unici due personaggi sono gli uomini che danno il titolo all’opera, torturato e torturatore, che fin dalla prima pagina vengono caratterizzati in modo inconfondibile: l’uno giovane, incappucciato, ferito, immobile; l’altro in uniforme, impeccabile, a testa scoperta.
Il dramma si svolge inizialmente attraverso i monologhi del capitano – in cui si alternano toni duri e comprensivi, tentativi di battute di spirito e slanci di autocompiacimento – e i silenzi di Pedro che, atto dopo atto, appare sempre più malridotto nel corpo ma più saldo nello spirito e nella dignità, cosa che lo porta ad osare un tono confidenziale, ad azzardare una voce provocatoria e insolente ma sgombrata da ogni paura.
Capitano: Ma chi sei? Un suicida?Pedro: Niente di tutto ciò. Mi piace abbastanza vivere.
Capitano: Vivere mutilato.
Pedro: No, semplicemente vivere.
Capitano: Ed io ti offro semplicemente di vivere.
Pedro: No, non semplicemente. Lei mi offre di vivere come un morto. E allora preferisco morire da vivo.