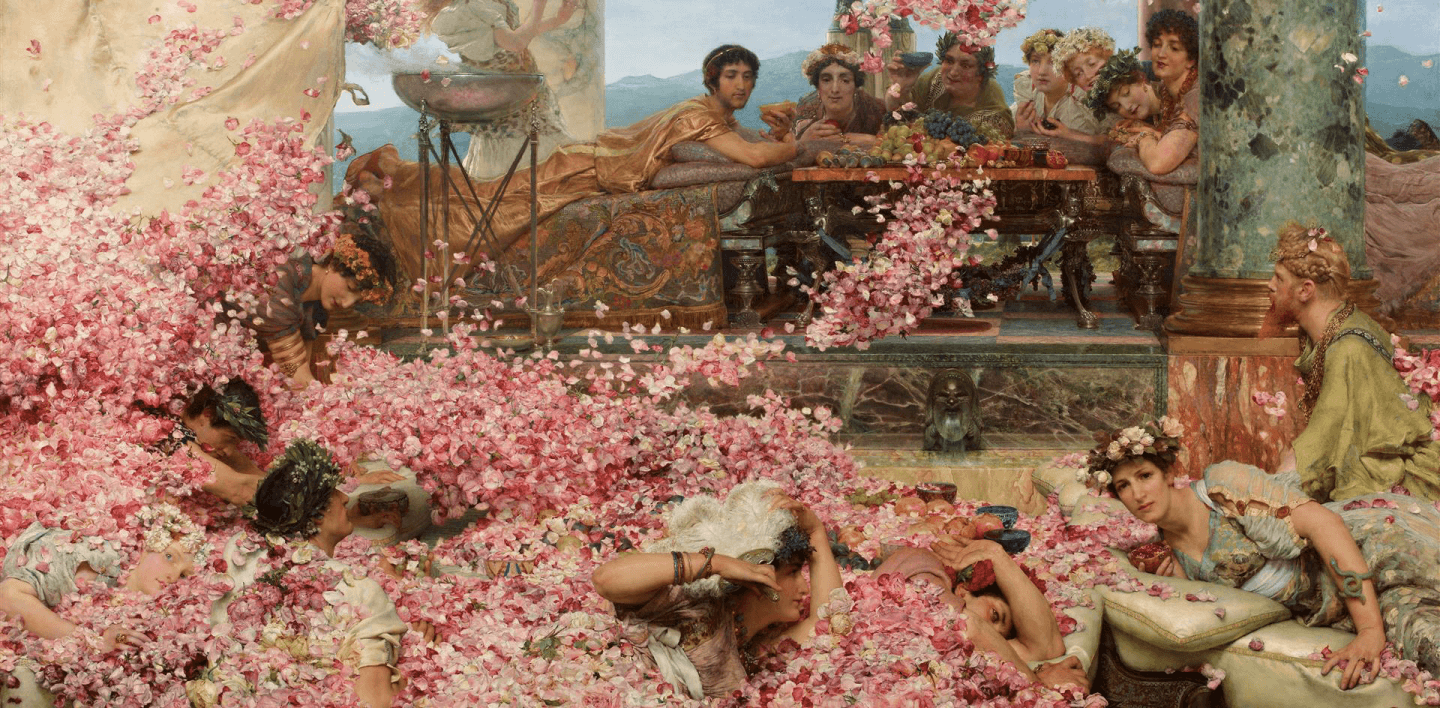
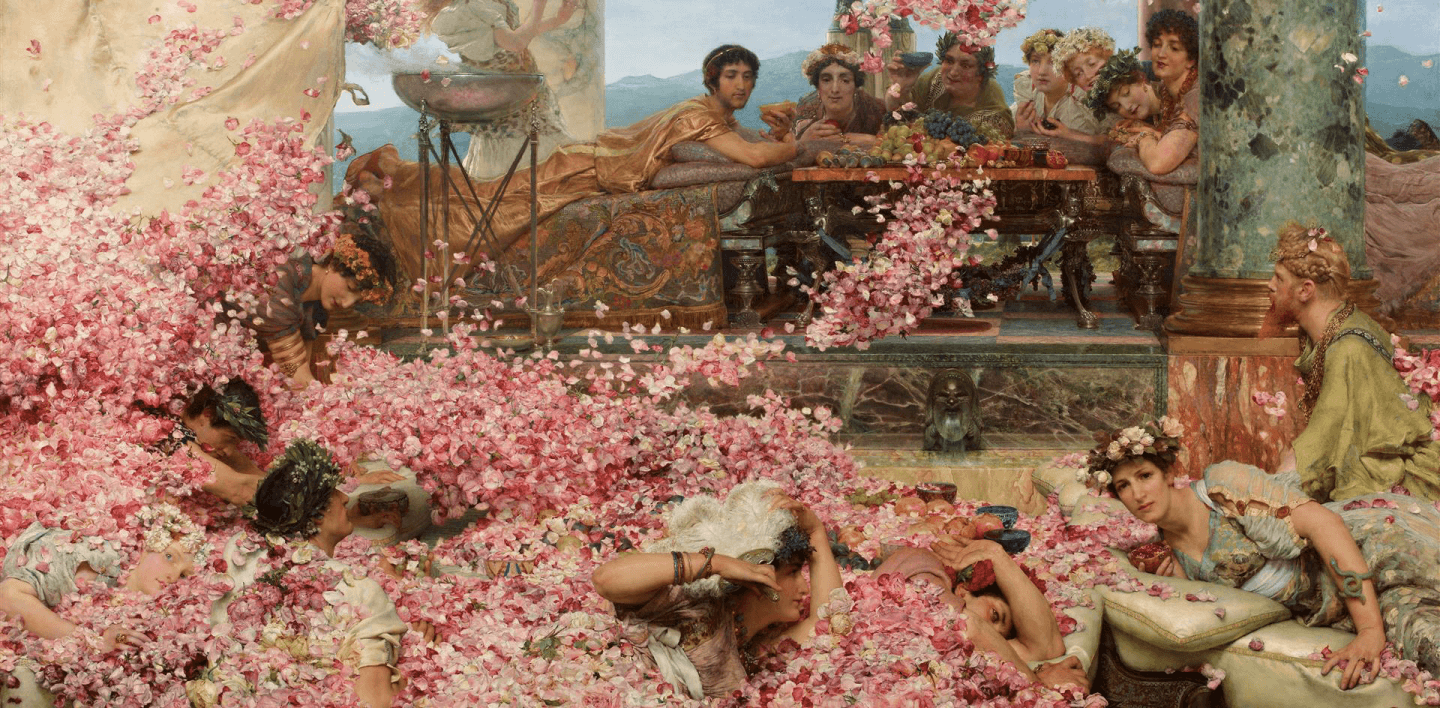
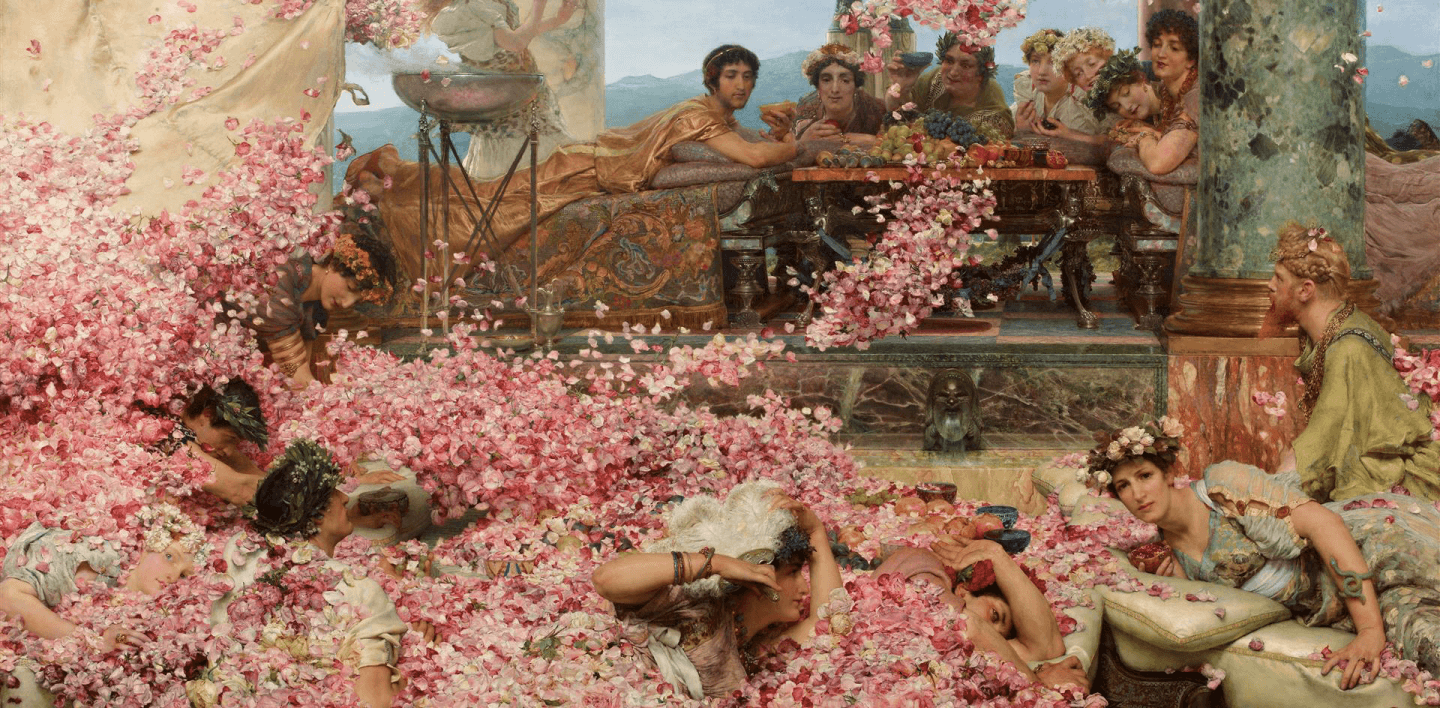
L eggere significa divinare tracce: è una caccia continua, una ricerca in cui, se sono visibili soltanto le orme, è perché resta immancabilmente ineffabile la preda, vale a dire l’obiettivo finale. Leggere è una rincorsa priva di percorsi prestabiliti; ed è anche una corsa senza mete, perché giungere al traguardo non si può, nel campo dell’arte, a meno di far coincidere quest’arrivo con una fine ultima. Se la nostra speranza è che la lettura, come pure l’interpretazione del mondo e dell’uomo, debbano o possano condurre a delle spiegazioni definitive, vuol dire che siamo caduti nell’illusione del white rabbit, il bianconiglio di Alice, quella di essere sempre in ritardo: perennemente attesi e in attesa in un dato momento, di un attimo che crediamo essere prossimo ma che non possiamo mai davvero raggiungere, se non quando il futuro sarà oramai divenuto un imperdonabile passato.
Ma il futuro è sempre, potenzialmente, già passato: il tempo non esiste in quanto linearità, ma solo come incrocio di possibilità; e infatti, la possibilità che un evento passato possa scatenarne uno futuro, è calcolabile soltanto fino a un certo punto, ovvero finché le leggi note del nostro muoverci nell’universo ci spiegheranno che da un punto A, a precise condizioni spazio-temporali e date un certo numero di premesse, si possa arrivare a un punto B. Ma poi, se sotto altre condizioni e con premesse differenti sia possibile tornare ad A, dovremo prendere atto che il ritorno è impossibile se intendiamo quel punto nella sua immutevolezza. Tornare dove si era prima è un’illusione spazio-temporale e anche psichica: un’allucinazione davanti alla quale dobbiamo arrenderci, ricrederci, mettere in discussione le vecchie leggi; oppure accettare di poterle applicare solo a una forma di conoscenza definita.
Questi enigmi, che sembreranno triviali, nacquero nella mia mente diversi decenni fa in un’austera aula universitaria romana. Devo aggiungere che non ero solo. La compagnia prossima era rappresentata in primo luogo da un vecchio professore, che instillava nelle nostre orecchie di giovani studenti il veleno del dubbio, proprio come quel Claudio che, nell’Amleto di Shakespeare, instillò il suo veleno mortale nei padiglioni auricolari di re Amleto (parliamo in quest’ultimo caso di un padre che, per complicarsi e complicarci la vita, non trovò di meglio da fare che dare al principe, suo figlio, il suo stesso nome, Amleto; ignaro, va detto, dell’adulterio della moglie – altrimenti non avrebbe scusanti neanche di fronte al meno convinto dei freudiani). C’era poi con me, e la figura non è affatto secondaria, un compagno di università ora scrittore, con il quale – nelle pause dalle dense lezioni – ci divertivamo a inventare storie. La più rivelatrice, per queste pagine, riguarda un critico, un critico immaginario.
Sì, tanti bambini hanno un amico immaginario; noi postadolescenti ci inventammo un critico immaginario, una sorta di guru impalpabile quanto improbabile, difficile da decifrare o da individuare, in grado di spaziare tra argomenti apparentemente discosti quali l’astronomia e la linguistica, l’antropologia e la veterinaria, la storiografia, la drammaturgia, l’idraulica e così via.
Il nostro critico immaginario era in grado di sfoderare, quando meno ce lo aspettavamo, le definizioni più taglienti ed enigmatiche. Come quando descrisse la traduzione – quello che sarebbe divenuto il mio ambito di diletto e di ricerca – non alla stregua di un ponte, come fanno in tanti, ma come “la mina che quel ponte ha fatto saltare”; oppure quando ci spiegò a distanza che
non basta attendere il nemico, dovrete immaginarvelo: solo così sarete in grado di vederlo ancor prima che vi sferri il colpo finale.
Queste ed altre massime – inventate, ma cosa non lo è? – ci rimasero impresse per anni, e talvolta colorano persino le mie lezioni davanti a nuovi studenti che avranno anche loro, sicuramente, i propri critici immaginari. Ma quella che più ci colpiva era una sententia autobiografica inserita nelle sue memorie postume, da cui emergeva con forza il distillato di un pensiero proteiforme e remoto: “a sedici anni iniziai a leggere il mio passato futuro nei cumulonembi. E credo di aver smesso di farlo soltanto l’altro ieri”. Questa ammissione, che mescola tempo e spazio in maniera assai nebbiosa, quasi fossero (non lo sono?) un impasto nebuloso di eventualità e possibilità incrociate, ci fece capire sin da allora che, ad esempio, quel che è definito dalla parola “evento” non esiste se non come storia, come narrazione. Gli eventi del passato, quelli che finiscono nella Storia con la S maiuscola, sono essi stessi delle storie; e in quanto storie, vengono raccontati, passando da occhi e orecchie, a menti che li rimembrano una volta smembrati, per poi porgerli di nuovo ad altri occhi e ad altre orecchie che a loro volta li smembreranno, li rimembreranno, e così via ad infinitum.
Ma cosa voleva dire il nostro critico immaginario con quella criptica espressione “il mio passato futuro”? Forse che il futuro trattiene le proprie fondamenta nel passato? E se sì, esiste la possibilità che, una volta affondate le radici in qualche dove, la pianta non venga su bene come ci aspettavamo? O persino che muoia, non raggiungendo altro futuro se non quello del proprio ultimo momento? E non è forse questo quel che accade a tutti noi? Raggiungere il nostro ultimo momento nel futuro, un futuro, però, che diviene passato giusto un attimo dopo? Non viviamo il presente se non per un infinitesimo attimo, un atomo di tempo che si sfalda presto, come gli orli sfumati dei cumulonembi. E la nostra vita è fatta di questi atomici presenti che desiderando divenir futuri, finiscono sempre per esser passati. Ecco cosa ci spinge a ricordarli come storie.
Ma per non lasciare inevase domande fondamentali poste dal nostro critico immaginario, mi si lasci domandare come si possa leggere alcunché (men che meno il passato futuro) nelle nubi. Sarebbe come prevedere l’avvenire nei fondi delle tazzine di caffè, o divinar responso affidandosi alle evoluzioni stellari e planetarie. Eppure, in tempi andati qualche grande padre della scienza considerava lo studio delle influenze astrali quasi alla stregua di una scienza esatta: un sapere in grado di creare connessioni verificabili tra eventi distanti, di fare nesso estremo, come direbbe Bergonzoni. Se non si può leggere nulla di verificabile nelle nubi, non è soltanto perché non contengano il DNA del presagio, ma anche perché, per così dire, nessuno vede mai, nello stesso momento, la stessa nube in cielo. Possiamo persino arrivare ad affermare che i due occhi della stessa testa, e dunque della stessa persona (sebbene, com’è evidente, in noi albergano sempre più persone…) non vedono la stessa nube fissando al contempo in cielo lo stesso “oggetto” – se posso usare il termine per descrivere un aggregato di minuscole gocce d’acqua in sospensione negli strati alti dell’atmosfera.
Qualcosa di simile a questa illusione, in astronomia è detto parallasse, ossia lo “spostamento angolare apparente di un oggetto, quando viene osservato da due punti di vista diversi”. Tale “legge” possiamo applicarla, con un minimo di buon senso, a tante sfere del consesso umano, e può certo spiegarci persino le incomprensioni e i fraintendimenti, le letture sbagliate, quelle paranoiche, come le chiamava Eco, ossia quando chi ha scritto non viene inteso per quel che ha scritto, ma per come un lettore abbia voglia o decida di leggerlo indipendentemente da lui o da lei. E può anche, questa legge, non limitarsi soltanto al campo dell’interpretazione, ma persino passare all’azione, per così dire. I misunderstandings, i fraintendimenti, possono condurci ad agire in un modo che avrà date ripercussioni; e talvolta, nei casi più gravi, non basterà più, per assolverci di aver scatenato reazioni non volute, neanche tornare con la mente e con le spiegazioni a cosa aveva fatto scattare quella nostra azione che si è rivelata foriera, ad esempio, di tristi lacerazioni. Queste fratture non ricomponibili l’avranno già soppiantata in termini di importanza; di importanza fattuale, intendo, in termini di “fatti”, insomma. Ma prima di proseguire con la trattazione di questo strano termine (“fatto”) che con la letteratura non avrebbe troppo a che fare, e che per qualche motivo arcano consideriamo un lemma tra i meno interpretabili (“i fatti sono fatti”, si dice), vorrei soffermarmi su quell’altro sostantivo usato scientemente al plurale già due volte nelle righe precedenti: “fraintendimenti”.
Nella mia esperienza di traduttore di testi impossibili ed estremi, mi sono con la pratica abituato, o forse assuefatto, a una tecnica di scrittura che nasconde i significati, non dietro l’uso specifico di certi termini, né grazie alle relazioni sintattiche tra questi e quelli che hanno accanto, e neanche tra il rapporto che si istaura tra le parole e il contesto; ma proprio all’interno dei termini stessi, nella loro composizione intima. Una sorta di semiosi segreta, da iniziati (ma chi legge libri non è sempre in qualche modo un “iniziato” al mistero della letteratura?) Ecco un esempio assai lampante, che chiama in causa l’ultima misteriosa opera dell’irlandese James Joyce.
Nel suo Finnegans Wake, libro della notte e dell’oscurità, l’irlandesissimo nome Patrick, da un lato simboleggia il santo patrono dell’isola e padre del cristianesimo irlandese, e dall’altro mina e decostruisce proprio le basi del cristianesimo, gettando ombre sulla dottrina della paternità divina su cui si esso stesso fonda. Tutto ciò, Joyce lo fa con un trucchetto banale e semplicissimo, ovvero la scomposizione del termine nelle sue componenti. Premessa: la sintassi dell’inglese prevede che se abbiamo due sostantivi appaiati, spesso il secondo è la “testa”, il centro, il perno dell’espressione, mentre il primo lo specifica in vario modo. Un esempio chiave può essere questo, l’espressione “Papa boys”: abbiamo due sostantivi appaiati, di cui il secondo, il perno, è boys > “ragazzi” e il secondo la sua specificazione, Papa quindi “del Papa”; ergo papa boys > “i ragazzi del papa”. Allo stesso modo, o quasi, Patrick non sarebbe più solo Patrizio, ma scomponendolo diviene anche “Pa” + “Trick” (Papà + trucchetto), ovvero: “il trucchetto della paternità”. Da cui consegue la decostruzione di cui dicevo, quella della dottrina della Trinità cristiana secondo cui Padre e Figlio sono consustanziali, ossia racchiusi in un’unica persona della stessa sostanza. Tutto questo è per Joyce, noto ateo, soltanto un gioco, un trucchetto, ma anche un opium populi, uno stratagemma dalle gigantesche conseguenze.
Provenendo dalle stesse teste da cui nasce quella comunicazione che ci truffa e ci tuffa sempre in arene di possibili equivoci, non si presterà forse lo scrivere letterario più all’incomprensione che alla comprensione?
Tornando ora al termine “fraintendimenti”, e usando questa lente obliqua della scomposizione, si comprende ancor di più, credo, la ragione intima del suo significato. Fraintendimenti significa “incomprensioni”, ma leggendo il termine lentamente e con la scomposizione abbiamo “fra + intendimenti”, vale a dire, il trovarsi in compagnia di diversi intendimenti, di diverse motivazioni per agire in un dato modo, di diverse strategie intese a ottenere un qualche obbiettivo. La preposizione “fra-” usata come prefisso, può esprimere “scambio, e quindi equivoco”, dice un noto dizionario. Scambiare significa dunque tante cose, tra cui anche riavere in cambio qualcosa di diverso da quel che si è dato. E significa pure, se parliamo di idee, dare all’altro quel che l’altro prenderà, ma non con i nostri stessi “intendimenti”.
Questa tecnica di lettura ravvicinata, lenta, e vagamente paranoide, a volte funziona, come nel caso citato, altre meno. Prendiamo la citata parola “incomprensione”: la preposizione usata come prefisso “in-” rimanda alla negazione, e non possiamo certo usarla per intendere uno stato in luogo. Ma siamo sicuri che sia sempre proprio così? Mi chiedo se non possa essere anche lontanamente plausibile – non dal punto di vista grammaticale o della storia della lingua, ovviamente, ma da quello della vita reale – che un parlante non nativo, ad esempio, applicando in maniera deviante ed erronea la regola per cui la preposizione “in-” sta per stato in luogo , si convinca che il termine “in-comprensione” significhi qualcosa come “stare al centro della comprensione”, trovarsi al cuore della possibilità di capire.
Seguendo questa strada al limite dell’assurdo, potremmo persino domandarci da dove o da quando nascano i due significati lievemente contrastanti del verbo “comprendere”, che può essere inteso come “capire” o anche “racchiudere”. Esiste una relazione tra intendere e circoscrivere? È proprio necessario creare un insieme di cose, dati, oggetti, eventi e così via, per poterne poi discernere le relazioni reciproche o la natura? Certamente, delimitare aiuta a semplificare il lavoro del ricercatore e a massimizzarne l’efficacia in alcune fasi. Tracciare circonferenze o perimetri all’interno dei quali si possa condurre un’analisi sterilizzando i fattori esterni, considerati di disturbo, può servire. Ma poi, se è vero che studiando ad esempio un patogeno, un virus, è sicuramente utile lavorare in condizioni totalmente asettiche, quando se ne analizza la struttura, allorché dovremo scrutarne i comportamenti, sarà necessario allargare la circonferenza e far accedere all’interno della bolla una parte di ambiente esterno. Quando poi saremo alle prese con il vaccino, lo scontro tra entità dissimili sarà persino titanico, in quanto il virus verrà attaccato e sperabilmente annichilito nel suo stesso universo artificialmente ricreato; quando, infine, si dovrà testare il vaccino sugli umani, l’insieme dei fattori da accogliere aumenterà enormemente, ma non solo quello: si dovranno prendere in considerazione anche le possibili patologie tanto per iniziare, degli individui in cui lo si dovrà inoculare; e la catena sarà foriera di espansioni virtualmente infinite, dovendo moltiplicare in maniera esponenziale tutte le variabili. Bisognerà poi tenere sempre a mente, dulcis in fundo, la possibilità di varianti e variazioni del virus stesso, a cui il vaccino e le persone considerate immuni potrebbero essere esposte non senza sconosciuti pericoli, il che aumenta, e non di poco, il campo d’analisi.
Quand’è, allora, che potremo dire di aver compreso il comportamento di un virus e del suo antidoto? Soltanto, direi, allorché avremo, da un lato, allargato a dismisura il perimetro dell’insieme di fattori, agenti, dati, entro cui si compie lo studio, e dall’altro quando avremo accettato che ogni tipo di “comprensione” non può prescindere dall’allargamento di quel perimetro all’infinito, essendo le eventualità future innescate dai passati, esse stesse non “racchiudibili”. Comprendere significa, dunque, al tempo stesso racchiudere e non racchiudere. Vuol dire sicuramente non chiudersi. Schiudersi.
La scienza non ha a che fare con entità fisse e morte, ma con componenti in continua evoluzione, in continuo movimento, e non deve essere un non-scienziato a dirlo. Ma la letteratura? Provenendo dagli stessi occhi, orecchie, teste etc… da cui nasce quella comunicazione che ci truffa e ci tuffa sempre in arene di possibili equivoci, catapultandoci immancabilmente “fra intendimenti”, non si presterà, forse, lo scrivere letterario, più all’incomprensione che alla comprensione, ben sapendo che la parola “incomprensione” significa oramai, per noi, “essere al centro dell’evento interpretativo necessario a capire”?
Torniamo allora ai fatti, a quei fatti che per Mr Thomas Gradgrind, il soprintendente scolastico in Tempi difficili di Dickens sono l’unica cosa che si deve insegnare ai ragazzi:
quel che voglio sono fatti. Insegnate a questi ragazzi e a queste ragazze, nient’altro che fatti. Soltanto i fatti servono nella vita. Non impiantate null’altro, estirpate qualunque altra cosa. Si possono plasmare le menti degli animali pensanti soltanto sui fatti: nient’altro gli sarà utile. È questo il principio con cui tiro su i miei figli…
Ma cosa sono, i fatti? E cosa avranno mai a che vedere con la letteratura? Dal punto di vista teorico, oggi come oggi è rischioso se non ingenuo utilizzare in letteratura i concetti di “vero” e “falso”, poiché le affermazioni letterarie esistono al di là del vero e del falso. Possono essere falsamente vere o veramente false, senza alterare il rapporto tra testo letterario e lettore. Il che ha richiesto, da parte dei teorici della letteratura, la creazione di una terza via nell’interscambio tra l’uno e l’altro, una categoria mediana che descrive l’espressione letteraria come “né vera né falsa”. Ma già diversi decenni fa due leoni della critica, Wellek e Warren, avevano detto senza troppi fronzoli che il contrario di fiction non è verità ma fatto.
Dal punto di vista di chi prova a leggere nel cuore delle parole il loro intimo messaggio, anche al costo di doverle scomporre tentando di non vivisezionarle, non può sfuggire l’idea che fact condivida non poco in termini di struttura linguistica con act, un termine a cui tornerò tra pochissimo. Ed è anche interessante che la coppia fact-fiction mostri essa stessa uno strano apparentamento, condividendo tante lettere. È nelle lettere che si trova spesso l’arcano: nell’alpha, nell’omega, nei libri con lettere per titoli di Aristotele, perché le lettere sono gli atomi del linguaggio e lo compongono plasmandolo.
Se il personaggio dickensiano di cui sopra si illude di poter insegnare i facts, questo è perché essi sono e saranno sempre detti a parole, e le parole sono composte di lettere; ragion per cui, a meno di non voler creare un’equazione tra fatti (quindi eventi che esistono nel tempo e nello spazio) ed espressioni che li descrivono, bisognerà arrendersi. L’equazione ci obbligherebbe per logica a scomporre i fatti, scoprendone altri al loro interno, e poi a scomporre le espressioni, scoprendo che sono composte di parole composte di lettere; ma a quel punto sarebbe difficile far corrispondere i primi alle seconde, dacché possiamo dar per scontato che i fatti non sono le espressioni, sebbene una relazione tra loro esista. Ricorrendo invece alla soluzione del “né vero né falso” possiamo dire che i fatti “corrispondono e non corrispondono alle espressioni linguistiche”. Vivono dunque in una situazione di complicità promiscua, in cui si è una cosa e non la si è davvero. È uno stadio della significazione in cui si può essere anche il proprio opposto.
E nell’arte? Nella letteratura? Quale valore avrà, arrivare ad essere il proprio opposto? Oscar Wilde era convinto che qualcosa di artistico è vero soltanto se sia vero il suo contrario, il che riporta alla terza via, quella del vero-non-vero; e, aggiungo io, anche alla quarta, quella del falso-non-falso. Ma se nell’arte il vero non conta, forse è perché il vero non esiste neanche al di fuori. L’arte, che prescinde dai fatti, ma che dall’esistenza spazio-temporale nasce e che in quella vive, non deve giustificarsi rispetto alle categorie del vero e del falso; ma questo non significa che non le rifletta, quelle categorie, che non le “comprenda” (in entrambi i sensi, stavolta), ovvero che non le voglia modificare indicando nuovi orizzonti, nuovi cieli, e nuove terre.
Nel Coriolano di Shakespeare, Volumnia, la compagna del patrizio romano che dà il nome al dramma, ci parla a un certo punto di “misteri che il cielo non vuole la terra comprenda”. Heaven è l’alto, che sovrasta il basso ma includendolo nell’unicità del tutto: lo comprende in entrambi i sensi. Ne comprende i misteri, le ombre, le idee, i segreti. E l’arte, che è terrestre e umana perché impastata dell’argilla che tutti e tutto crea, è alto ma è contemporaneamente anche basso. È in alto, nella sua parte ineffabile, ossia nelle ragioni e rivelazioni; ma è anche in basso, perché quelle ragioni e rivelazioni innesta nel tessuto del nostro vivere. E allora, il mestiere – mystery è usato in Shakespeare anche per significare questo – dell’artista, del plasmatore, del creatore e ricreatore di mondi, è un filo rosso che unisce alto e basso, heaven e earth, un filo rosso intessuto da un cuore (heart) pulsante che permette di condividere il cielo e il mondo. Un cuore ardente, che brucia nel focolare (hearth) della terra (earth). La spiegazione dell’agire di un artista – to act vuol dire sia “compiere azioni” che recitare – rimane invischiata quindi nell’incommensurabilità umbratile della luce infinita e impenetrabile che unisce cielo e terra. Parliamo di un buio ermeneutico, quasi una coltre indissipabile di veli depositati su altri veli, di banchi di nebbia e nubi che nascondono il sole proteggendoci. Proteggendoci ovunque.